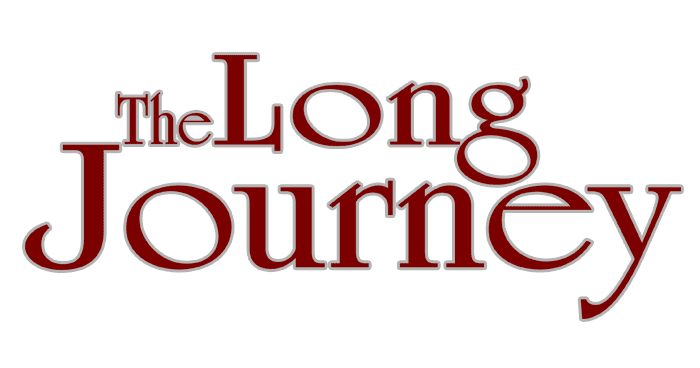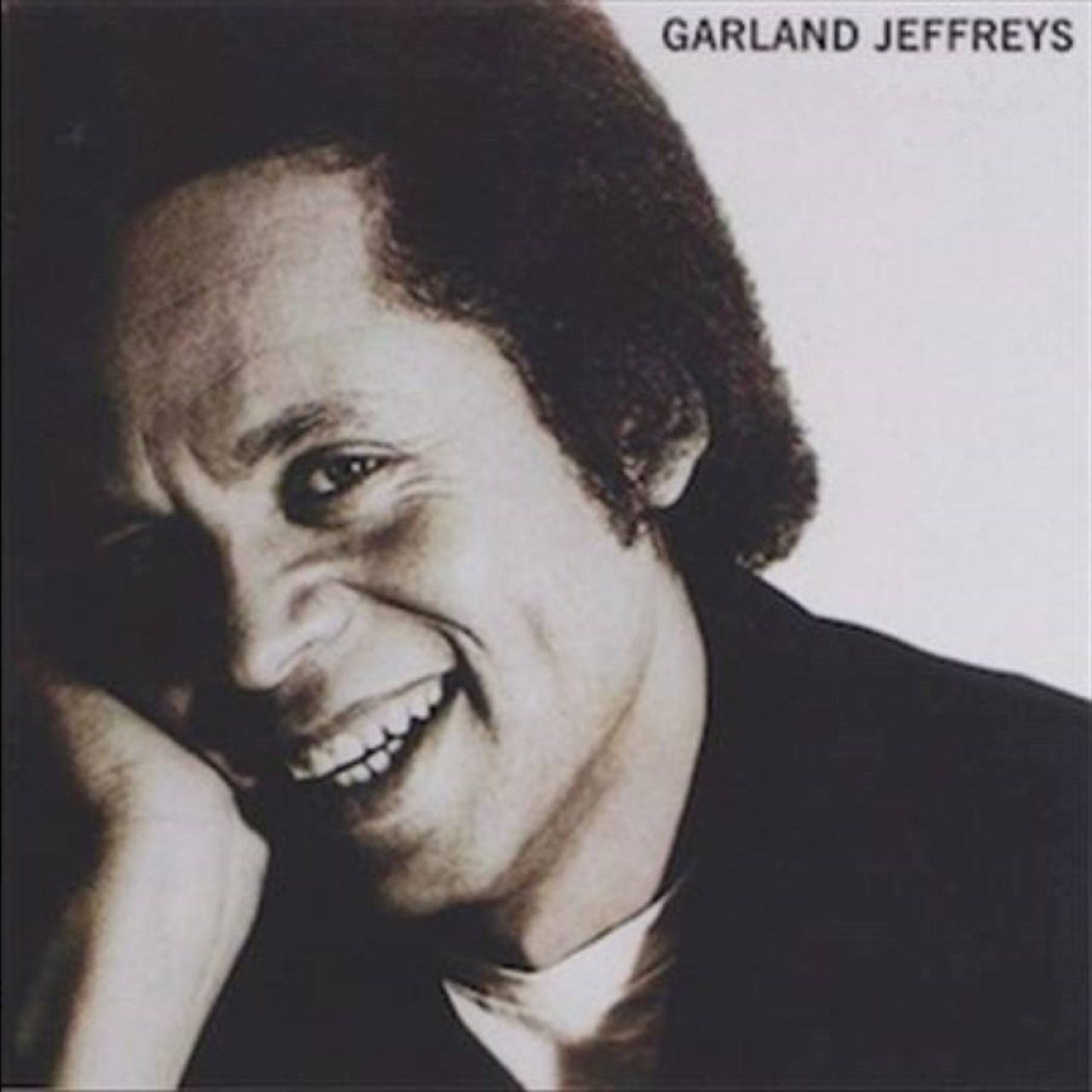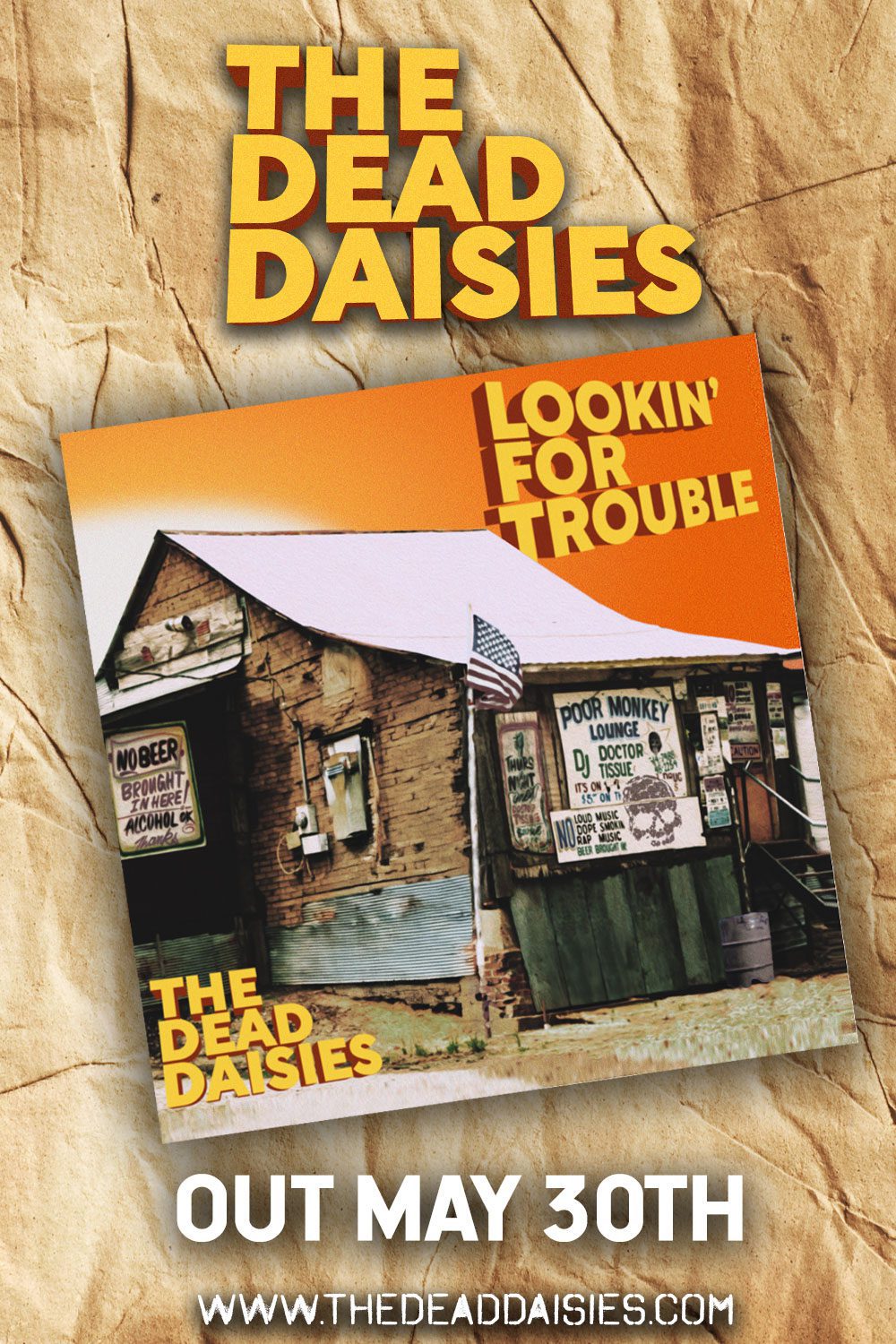‘Don’t Call Me Buckwheat’ segna il ritorno sulle scene di Garland Jeffreys, uno dei più eclettici e geniali creatori di musica degli ultimi anni. Un dettagliato ritratto dell’artista newyorkese.
Dura vita quella dei rocker, vita dura per i poeti urbani newyorkesi. Accomunati da un insolito ma crudele destino alcuni cantautori come Willie Nile, Steve Forbert e lo stesso Garland Jeffreys, hanno dovuto attendere quasi un decennio per poter nuovamente incidere per una grande etichetta, una major come si dice in gergo. Garland Jeffreys arriva ora con un’opera prima come Don’t Call Me Buckwheat, dopo un silenzio durato 9 anni.
Uomo dall’esistenza travagliata, dall’infanzia infelice contraddistinta da problemi razziali vissuti sulla propria pelle, è anche al tempo stesso e per contro, un personaggio amabile, estremamente simpatico, con un grande sorriso, mite dolce e con una esuberante voglia di vivere.
Don’t Call Me Buckwheat, il suo nuovo album, nasce proprio da questa voglia di vita e di racconto delle proprie esperienze. E’ come se Garland fosse andato dallo psicanalista e raccontasse a voce alta, nello studio, la sua vita trasmettendo in liriche ed in musica aneddoti, problematiche, paure e fantasmi da esorcizzare, nonché i momenti difficili di una vita ardua e complicata. Ma al nostro lettore interesserà maggiormente la vita artistica di questo grande ed abilissimo musicista con alle spalle una carriera costellata da album di indubbio valore.
Garland Jeffreys, nasce a Sheepshead Bay (Brooklyn) poco distante da New York nel 1944. Il padre adottivo è originario delle Antille mentre quello vero, un marinaio delle Indie Occidentali, aveva lasciato casa due anni dopo la sua nascita; la madre invece era di origine portoricana. Garland divide la sua adolescenza fra due passioni: l’arte classica ed il rock. Frequenta la Syracuse University (compagno di scuola di Lou Reed e Felix Cavaliere degli Young Rascals) e l’Institute Of Fine Arts.
S’interessa al Rinascimento, è innamorato dell’Europa e delle sue tradizioni, la scultura, la pittura, la letteratura, il cinema e vive per circa un anno a Fiesole e Firenze dove ha modo di tradurre in pratica i suoi studi.
Dal 1966 suona nei club di Manhattan, come solista o capeggiando delle minuscole bands come i Train, i Mandoor Beekman, i Romeo fino ai Grinder’s Switch Featuring Garland Jeffreys con cui incide nel 1970 un primo album su Vanguard, un gradevole disco di country-folk in compagnia di Stan Szelest (tastiere), Ernest Corallo (chitarre) e Sanford Konikoff (batteria). Suoi amici e compagni di scorribande nei sixties sono Lou Reed, John Cale e Felix Cavaliere. Punto d’incontro a New York era un club chiamato Orange dove fecero conoscenza con il poeta beat Delmore Schwartz e tutti insieme costituivano quella scena ‘intellettuale’ di cui avevano bisogno, una sorta di ‘intelligenza bohemienne’.
In comune con Lou Reed, Garland Jeffreys ha la capacità di rendere immediatamente poetiche le visioni del mondo esterno, traducendo il tutto in una metafora ricca di implicazioni squisitamente letterarie.
Nel 1973, la Atlantic pubblica il suo primo album solista con illustri ospiti come Dr. John, Alan Freedman (chitarre), David Bromberg (dobro) e John Simon al piano: 10 melodie tutte composte dal nostro songwriter che abbina splendide composizioni quali Ballad Of Me, Calcutta Moonsoon e She Didn’t Lie, a brani reggae come Bound To Get Ahead Someday. Garland regala preziosismi lirici non indifferenti e la sua musica sembra incontaminata dalle brutture del mondo che lo circonda. Nonostante per molti anni egli sia stato osannato come uno dei più dotati autori e musicisti che siano mai apparsi sulla scena della musica contemporanea, la sua promettente carriera stenta a prendere una piega definitiva, la via del successo e della consacrazione è ancora tanto difficile e tortuosa.
A poco serve la pubblicazione di un singolo Wild In The Streets (1973), definito un classico dell’underground, autentico inno di rivolta dei giovani americani ed anche la travagliata storia del contratto discografico con la Arista di Clive Davis si conclude prematuramente con un semplice singolo Disco Kid (1975) prima ancora di aver avuto l’occasione di incidere un album.
Nel 1976 Garland, firma un contratto pluriennale con la A & M e pubblica in questo suo fortunato periodo tre piccoli capolavori: Ghost Writer (1977), One-Eyed Jack (1978) e American Boy & Girl (1979). Da quest’ultimo lavoro viene tratto il singolo Matador che diventerà un grosso successo in Europa (Francia, Lussemburgo, Germania ed Olanda soprattutto).
Reggae e Soul sono le anime musicali di Jeffreys. Le sue primarie influenze sono costituite infatti da Frankie Lymon (il suo idolo), il rhythm and blues nero, il rock and roll, il reggae ed il calypso oltre a personaggi importanti come Little Richard, Sam Cooke, Chuck Berry, The Drifters, The Cliftons, The Heptones, Jackie Wilson e James Brown (tutti musicisti di colore) ed ancora Rolling Stones e Bob Dylan ma soprattutto Bob Marley.
Ghost Writer (si intende uno scrittore nero anonimo intento a scrivere materiale per altri) è un episodio autobiografico ed è l’album più poetico ed al tempo stesso più reggae di Garland.
Il reggae in un certo senso rappresenta la colonna sonora della sua vita ma nel 1973, quando egli inizia a proporlo, è troppo presto per prevedere l’esplosione di questa musica; bisognerà attendere il 1979 perché si possano conoscere pubblicamente le gesta di Jimmy Cliff, Peter Tosh e del suo amico Bob Marley (ascoltate la splendida versione di No Woman No Cry in One-Eyed Jack).
Ghost Writer è un disco imperdibile, non fosse altro per Wild In The Streets, Cool Down Boy (influenze reggae) in cui l’autore duetta con James Taylor, I May Not Be Your Kind e Spanish Town, stupenda ballata immersa nelle atmosfere dell’America del Sud, la musica latina dei paesi di lingua spagnola con una magistrale interpretazione vocale del nostro rocker.
One-Eyed Jack dedicato al suo idolo di gioventù Jackie Robinson (il primo giocatore di baseball nero di successo) è un microsolco maturo, sviscera il rhythm and blues nei suoi molteplici aspetti con brani come Reelin con Phoebe Snow alle voci e dei reggae eseguiti con classe e raffinatezza quali Been There And Back e Disperation Drive.
American Boy & Girl invece è un disco magico, per uno degli artisti più sensibili e preparati dell’attuale scena musicale americana. Un ellepì che rappresenta la simbiosi e la fusione del reggae e del rock. Se Matador, Bring Back The Love e Bad Dream rappresentano gli episodi reggae, Livin’ For Me, American Boy & Girl e Ship Of Tools riscoprono l’aspetto più autentico ed aggressivo del rock.
Osservate la copertina di American Boy & Girl, Chino e Lori, i due ragazzi ritratti in copertina sono un quindicenne portoricano ed una tredicenne bianca, lei già adescava e lui era già stato arrestato tre volte; è il volto povero della city (Brooklyn, Coney Island e New York in genere), che unito al miscuglio delle razze rappresenta il tema prevalente della scrittura di Jeffreys. Se American Boy & Girl è un lavoro triste e cupo e riflette gli umori dell’artista in quel determinato periodo (1979), il successivo Escape Artist (1981) è la fuga e la rivincita sulle avversità della vita, il ricordo di un passato da ‘city kids’, i bambini del ‘ghetto’, tema conduttore delle sue storie da Disco Kid a Wild In The Streets, da City Kids (vedi il long playing American Boy And Girl) a Mistery Kids (da Escape Artist) così cruente e reali, proprio perché Garland è stato uno di loro, uno di quei bambini dei quartieri poveri dove regnano l’indifferenza, la solitudine, i pregiudizi razziali senza un briciolo d’affetto o di speranza.
Garland è mulatto e cattolico, da ragazzo era evitato dai coetanei di religione cattolica perché di carnagione nera e schivato dai giovani di colore perché la sua pelle era troppo chiara (da qui il concetto autobiografico ripreso in Don’t Call Me Buckwheat). La tristezza di una vita così rovinosa (il padre era solito maltrattarlo e picchiarlo) era consolata dai dischi della madre. Garland aveva così avuto modo di ascoltare e di lasciarsi influenzare da Nat King Cole, Ella Fitzgerald, Billie Holiday, Sonny Rollins, Mills Brothers, Charlie Parker ecc. ecc..
Miami Beach dall’EP (quattro canzoni) allegato ad Escape Artist, sintonizza il reggae laico di Jeffreys, un ritmo morbido ed ipnotico. Rock And Roll Adult (1981) è un disco suonato da un adulto con il cuore e la vitalità di un bambino e viene pubblicato a soli pochi mesi dal precedente Escape Artist, album che aveva visto la partecipazione di musicisti importanti come Lou Reed, David Johansen, Roy Bittan e Danny Federici della E-Street Band, Steve Goulding (batteria) ed Andrew Bodnar (basso), questi ultimi due della band dei Rumour di Graham Parker, che hanno anche costituito la formazione che dal vivo ha accompagnato Jeffreys per diverso tempo.
Rock And Roll Adult (CBS) è uno degli albums ‘live’ più avvincenti del 1981. Una carica di umanità che traspira dai solchi. Si passa così da Wild In The Streets a 96 Tears, una cover del celebre brano di Question Mark And The Mysterians del 1966, da Matador (uno dei suoi capolavori assoluti) sino a 35 Millimeter Dreams, un sogno cinematografico in cui si parla di Greta Garbo, Humphrey Bogart, Rodolfo Valentino e Charlie Chaplin, tutti quei miti cioè, che hanno fatto grande il cinema. Infine il grande affresco di Cool Down Boy di oltre 12 minuti con la presenza di Martin Belmont (chitarra) e Brinsley Schwartz (chitarra), l’altra faccia della sua ‘live band’, anch’essi provenienti dai Rumor.
Garland Jeffreys vive la sua cultura mittel-europea in molte delle sue composizioni, come ad esempio in Jump Jump, dove vengono smitizzati giganti della letteratura e della pittura come Hugo, Cezanne, Monet e Van Gogh.
Guts For Love (CBS) suo ottavo ellepì del 1982 è principalmente un album di soul music con numerosi elementi rock ed alcuni immancabili momenti reggae (Rebel Love e Loneliness). C’è sempre stata una certa dose politica nelle sue canzoni; El Salvador sullo stile di Matador ed il brano Guts For Love lo hanno visto tra i primi artisti in assoluto a prendere coscienza dei problemi del centro America, molto prima di altri musicisti che hanno abbracciato la sua stessa causa solo alcuni anni dopo.
Spanish Town tocca argomenti come gli aiuti della C.I.A. al presidente cileno Allende e lo stesso rappresenta El Salvador in cui si denunciano gli interventi poco ortodossi degli Stati Uniti nei paesi dell’America Latina. Guts For Love (“Le viscere dell’amore”) è un album notevole, forse un po’ troppo arrangiato, in cui Garland fa ascoltare dei piacevoli rock come Real Man e Shout e dolci ballate come Surrender e Fidelity. La voce di Garland, chiara, limpida, è graffiante, è un altro dei suoi punti di forza.
Jeffreys spesso sfugge a riferimenti conosciuti, i suoi dischi sono pieni di feeling e spiritualità e si riallacciano con il rock urbano del miglior Bruce Spreengsteen e di Southside Johnny ma si collocano ugualmente bene nella tradizione dei soul singers ‘neri’ alla Stevie Wonder, Jackie Wilson, Frankie Lymon, Al Jarreau e Bob Marley (reggae) per citare gli artisti più vicini a lui ed al suo istinto musicale. Dopo 9 anni di silenzio Garland è tornato tra noi con Don’t Call Me Buckwheat, album dai ritmi gioiosi e dai testi autobiografici che rivelano il suo messaggio, la lotta contro la discriminazione razziale.
La fotografia spiegazzata sulla copertina di D.C.B. la dice lunga sulla storia di questo ragazzetto in tenuta da baseball, fotografato mentre se ne sta, giovane e innocente, di fronte al leggendario e glorioso Ebbett’s Field a Brooklyn. In verità potrebbe essere un qualsiasi giovane degli anni ’50 al campo di baseball accompagnato da suo padre. Guardando bene l’immagine però si vedono i distintivi di Jackie Robinson e di Roy Campanelle, simboli di orgoglio per un giovane il cui padre ha forse infranto i divieti imposti dal colore della pelle (vedi Color Line). Un ragazzo che in foto sembra abbastanza chiaro di carnagione, quasi un ‘bianco’ ma che in realtà porta bene evidenti le caratteristiche somatiche del nero mulatto, un giovane dichiaratamente ‘confuso’ e ‘sperduto’; quel bambino è Garland Jeffreys all’età di cinque anni e Don’t Call Me Buckwheat è la sua storia vera.
Un album multiforme, dal gospel di Moonshine In The Cornfield a brani a-cappella come I’m Not Know It All, cover di un pezzo del suo idolo Frankie Lymon (celebre con i suoi Teenagers negli anni 1956/60 ed alla ribalta con un hit come Why Do Fools Fall In Love?), morto prematuramente per overdose nel 1968.
Il rock and roll è degnamente rappresentato dal singolo Hail Hail Rock And Roll, una personale visione della nascita del rock’n’roll ispirata e dedicata ai suoi fondatori: Little Richard, Chuck Berry e Bo Diddley, tre esponenti fondamentali, tutti di colore. Si passa poi dall’ottimismo delle liriche di The Answer all’intenso reggae Welcome To The World. Spanish Blood. racconta uno dei suoi innocenti sotterfugi, usato qualche anno fa per presentarsi come spagnolo mentre I Was Afraid Of Malcolm è un significativo tributo a Malcolm X, una brano funk-rock esageratamente ‘tecno’ con la chitarra di Vernon Reid dei Living Colours. E se Bottle Of Love e Lonelyville risultano pezzi un po’ troppo fragili con una voce da brivido, Garland ugualmente conferma la sua grande vena creativa. Un album nel quale si respira rock e cultura, amore e disperazione, storia e cronaca, drammi e speranze.
Jeffreys ha prodotto un bellissimo capitolo di rock multirazziale partendo da un epiteto a lui rivolto durante una partita di baseball a New York. ‘Buckwheat’ sta a significare ‘grano saraceno’ ma nel contesto è il preciso riferimento al colore della pelle di Garland. Un titolo usato in modo assai dispregiativo, ricavato sfruttando un personaggio di un cartone animato ‘Buckwheat’ della serie televisiva Little Rascals (“Quella simpatica canaglia”) che rappresenta idealmente lo stereotipo del nero acculturato, ignorante, ovvero un fantoccio, uno scapestrato un po’ comico, buffo, pigro e fannullone, un burattino nero!
Nell’album dall’ottimo background musicale, appaiono strumentisti quali Sly Dunbar (batteria), Robbie Shakespeare (basso), Vernon Reid e Michael Brecker (sax tenore).
Un artista fiero, un rocker ancora assai integro, culturalmente e musicalmente parlando, un esempio da seguire. Pur essendo autore di 9 albums, Garland Jeffreys non ha mai raggiunto negli States, quel successo tanto meritato, pari al suo impegno compositivo ed alla sua eleganza musicale. La sua discografia resta quindi tutta da riscoprire e se amate il personaggio andate ad ascoltarvi i suoi lavori precedenti e non mancate il suo nuovo ed autobiografico Don’t Call Me Buckwheat.
Per gli amanti dei compact-disc Escape Artist è ora disponibile (stampato in Usa) altri invece sono stati editi in compact-disc per il momento solo in Giappone ma presto saranno in circolazione anche qui in Europa. Naturalmente Don’t Call Me Buckwheat è presentato in versione CD, LP e cassetta e merita tutta la nostra ammirazione.
Aldo Pedron, fonte Hi, Folks! n. 51, 1992