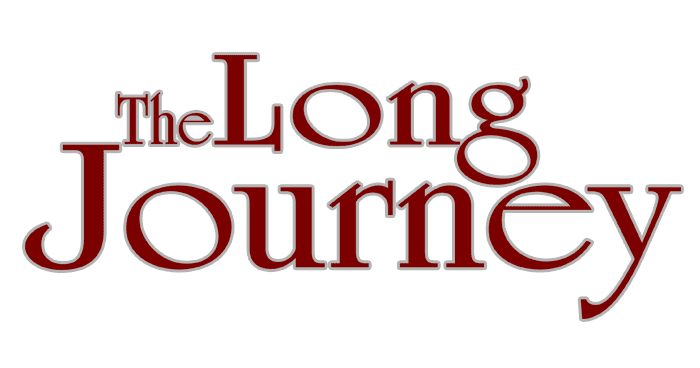Il sentimento dell’amore, l’opportunità di esibirsi davanti ad una pluralità di persone ed essere quindi al centro dell’attenzione e tutta una pletora di circostanze estremamente diverse e personalizzate rappresentano il motivo, ‘la molla’ per cui una persona decide di intraprendere la carriera artistica, di qualunque branca espressiva si tratti. Per Chuck Pyle, cantautore originario dell’Iowa, ma trapiantato nel più artisticamente fertile Colorado da più di trent’anni, l’elemento scatenante fu … la rottura di una corda del piano a coda che troneggiava nel salotto di casa.
“Quando avevo 5 anni, i miei genitori invitarono a casa un loro amico perché mi ispirasse suonando il piano. Sapevano già che amavo la musica in quanto ogni tanto strimpellavo il piano ad orecchio” ricorda Chuck. “Questo tizio era un pianista professionista e suonò con tanta enfasi che, non solo quasi fece crollare la casa, ma addirittura ruppe una corda del pianoforte stesso. Non ho mai dimenticato questo episodio e in seguito ho deciso che avrei assolutamente imparato a suonare il piano – senza rompere le corde”.
Trasferitosi in Colorado, Chuck inizia una inevitabile gavetta esibendosi come ‘cover-artist’ e suonando la chitarra (non il piano) nei vari centri turistici del Colorado lungo la catena delle Rocky Mountains. Il suo carattere estremamente timido inizialmente rappresenta un ostacolo che cozza in modo stridente con il suo desiderio di essere ‘on stage’, ma la necessità aguzza l’ingegno ed il salto di qualità della carriera di Chuck arriva nel momento in cui egli riesce, per la prima volta, a strappare una risata al pubblico presente in sala, grazie anche alle sue composizioni originali, cariche di arguzia, humour ed ironia: il suono di quella risata è una sorta di folgorazione ed il nostro performer decide che questo deve succedere ancora ed ancora ed ancora… Da allora il banco di prova di un brano a sua firma è stata la condizione che “…la canzone dovesse essere abbastanza buona da fare in modo che almeno non mi sentissi in imbarazzo davanti al mio pubblico nel momento in cui l’eseguivo…”.
Sembra che Chuck abbia ottenuto il suo scopo, visto che artisti del calibro della Nitty Gritty Dirt Band, Southern Pacific, John Denver, Tish Hinojosa, Geronimo Trevino III, Suzy Boggus e Bill & Bonnie Hearne hanno riproposto con successo i suoi brani.
Nel 1991 il rodeo cowboy Chris LeDoux ha avuto un significativo hit con Cadillac Cowboy (che già Jerry Jeff Walker aveva incluso nel suo repertorio) e lo stesso Jerry Jeff, citato quale “influenza prepotente” nella formazione artistica dell’imberbe Chuck, ha a sua volta registrato il gioiellino The Other Side Of The Hill negli anni ’70, durante il sodalizio discografico con la major MCA.
La carriera discografica di Chuck inizia nel 1985 con Drifter’s Wind (Starburst Entertainment SB1001-2) che esce per una minuscola indie di Boulder, che scomparirà di lì a poco non senza aver dato prima i natali ad una discografia quanto mai parca (sette albums in diciotto anni), ma almeno altrettanto interessante. Già con l’iniziale Breathless In The Night, Chuck illustra il suo suono: l’ispirazione è il folk, ma il piglio è cantautorale, prossimo ai fraseggi acustici e briosi tipici di Gordon Lightfoot. La voce è calda e profonda (ascoltate la narrativa Take Your Favors o Giving My Everything), il tono è colloquiale ed informale (Pilgrim Of The Wind sembra più una chiacchierata fra amici), ma non mancano le narrazioni ed i racconti ambientati nel grande West (Diablo Dead-Eye e la stupenda Two Of A Kind a firma Jon Ims), mentre la conclusiva Show Me The Way è sobriamente pianistica e quasi gospeliana.
Già in questo album di esordio, che ben evidenzia le potenzialità del nostro, compaiono due gioielli che arriveranno a diventare piccoli classici: Drifter’s Wind, title-track dell’album e per tanto tempo brano-manifesto per Chuck Pyle e Camel-Rock, infarcita di gradevoli sonorità country-rock stile anni ’70, quasi fosse un brano uscito dalla penna degli America più ispirati e futuro title-track di un album del 1995.
Chuck si fa accompagnare da un pugno di amici più o meno sconosciuti al grande giro: Larry Thompson (batteria e percussioni), Bob Abbott (basso), Jerome Gilmer (tastiere), Steve Sykes (chitarre), John Macy (steel e dobro), Dick Orleans (chitarra acustica) e Kostas (chitarra spagnola e futuro compositore di un certo successo in quel di Nashville) ed il risultato è un piacevolissimo disco di esordio per un personaggio che molto avrà ancora da dire e cantare.
Devono trascorrere ben altri cinque anni prima che Chuck riesca a ricreare le condizioni per tornare in studio di registrazione, ma dovrà arrivare a creare la sua stessa – ed indipendentissima label – Bee ‘n’ Flower Music per dare alle stampe Step By Step (BnF 1002-2). Sul piano artistico, il discorso riprende là dove era stato abbandonato con il disco di esordio e poco cambierà anche per il futuro. La voce di affina ed acquisisce maggiore spessore ed una più marcata personalità. Il suono della chitarra si allontana leggermente dagli schemi prettamente folk del disco precedente e viene meglio filtrato dalla personalità introspettiva di Chuck, che firma nuove perle quali Lay This Old Guitar Down, I Always Go Walking, ci conduce per mano ad ascoltare le narrazioni suggestive di Here Comes The Water, Keep It Simple, Train Wreck o lo stesso title-track, ci intenerisce con la delicatezza di semplici – ma mai banali – canzoni d’amore quali Light Of My Love o Why, Honey Why?, ci trascina su di un hardwood floor per unirci nella square dance di Family Land (co-firmata con Jon Ims), dal vago sapore cajun o ci meraviglia per la dolcezza di una Saturday Night Somewhere.
Anche qui, come per il disco precedente, troviamo due brani che verranno poi riproposti da molti altri artisti, elemento questo che si dimostrerà tutt’altro che trascurabile nell’economia di Chuck Pyle: Jaded Lover e Other Side Of The Hill, pur in versione cantautorale e quindi più ‘essenziale’ e minimalista rispetto ad arrangiamenti più corposi e grintosi ad opera di gruppi quali i Southern Pacific, che avevano già inciso una bellissima cover di Jaded Lover in aria di country-rock d.o.c. nel loro album di esordio del 1985 sotto il titolo di First One To Go.
All’attività di compositore si affianca una crescente richiesta di suonare dal vivo ed è così che dobbiamo attendere altri tre anni prima di assistere all’uscita di Endless Sky (BnF 1003-2) nel 1993. Chuck si è rasato la folta barba che gli incorniciava il viso, ma lo script è restato quello che ci aveva fatto amare i primi due dischi: l’iniziale Rio Rey, la soffusa Endless Sky, la discorsiva Everyday Now, la suggestiva Alaska Wind, le autobiografiche Slow Time Kid, Your Life In Love With Mine e The Winter Of Our Affair, la briosa Moonglow Rising, ancora vagamente reminiscente delle armonie care a Lightfoot, Keepers Of The Earth, socialmente impegnata verso un mondo senza confini, l’acustica ed elaborata Texas Mosey per chiudere con la sobria e pacata Sailing, rappresentano approdi imprescindibili di una crociera alla quale Chuck ci invita a partecipare per conoscere meglio e per approfondire il suo messaggio. Anche la grafica dell’album è accattivante e riporta i testi di tutti i brani, come già accadeva per i due albums precedenti.
Ancora due anni e nel 1995 esce il primo album di Chuck Pyle registrato dal vivo ed è appunto il brano Camel Rock a dargli il titolo. Il repertorio pesca dai primi tre dischi (Drifter’s Wind, Camel Rock, Keep It Simple e Jaded Lover), ma soprattutto propone brani nuovi ed originali, con le uniche esclusioni di The Entertainer Rag (brano celeberrimo tratto dalla colonna sonora del film noto in Italia come La Stangata, che ha segnato una certa riscoperta del genere rag) e di Highway, Highway, a firma del cantautore texano Stephen Allen Davis autore del misconosciuto The Light Pink Album, datato 1995, che comprendeva anche il brano in questione.
Anche Ruby riemerge dal passato della musica pop statunitense degli anni ‘40-‘50 e la versione che ci fornisce Chuck, aiutato in concerto dal solo fiddle di Gordon Burt, è quanto mai minimalista, ma non per questo meno sentita o vissuta: in certi casi l’ambiente necessariamente spartano – in termini di strumentazione – favorisce l’aspetto emozionale delle interpretazioni, elevandone il tasso qualitativo.
Anche Larimer Street è nuova e porta il contributo compositivo del fido Jim Ratts e di John Cables. Ballata lineare e confidenziale, ben si inserisce nel tessuto artistico del repertorio di Chuck.
Camel Rock è introdotta da un breve dialogo fra Chuck e Gordon e si risolve in un delicato brano acustico che coinvolge il pubblico presente, attento a pronto ad approfittare della ghiotta occasione di godere dello yodel del nostro.
Colorado rappresenta un’altra novità e verrà poi riproposta in studio nel disco seguente. E’ un excursus della carriera artistica del nostro entertainer a partire dal momento in cui gli fu “gentilmente chiesto di abbandonare il collage nel nativo stato dell’Iowa”, quando poi si trasferì in Colorado ed affrontò il duro lavoro di ‘cover-singer’, cimentandosi con brani quali San Francisco Bay Blues di Jesse Fuller e You’ve Got To Hide Your Love Away dei Beatles, entrambe appena accennate nell’introduzione del brano.
Altrettanto toccante risulta l’interpretazione di Highway, Highway, bozzetto acustico e sommesso dedicato ad un amore che non si esiste più.
Night Horse ha le movenze ed il passo della ballata western e certo non sfigurerebbe nel repertorio di Tom Russell o di Don Edwards.
Come già Colorado, anche Tucson Cactus Queen è destinata ad entrare in un virtuale ‘Best Of Chuck Pyle’, nonostante il brano verrà poi reinciso con il titolo di Sedona Ramona nel CD seguente.
Non poteva poi mancare Camille, l’omaggio alla figlioletta che Chuck considera la sua cantautrice preferita fin dalla tenera età di due anni (l’aspetto artistico del brano non fa comunque gridare al miracolo, ma è risaputo che i genitori non sono molto imparziali di fronte ai figli).
Se da un lato è vero che l’ambiente del concerto è necessariamente restrittivo in termini di orchestrazione ed arrangiamenti, è altrettanto vero che l’uso della strumentazione da parte di Chuck Pyle è sempre stato quanto meno parsimonioso, quindi la situazione non risulta particolarmente penalizzante: ne sono evidente riprova le conclusive Hey Hey Mama, sorretta dal solo fiddle (oltre alla chitarra acustica di Pyle) e Jaded Lover, brano ormai classico nella sua veste di composizione cantautorale.
A distanza dei canonici tre anni esce il nuovo disco intitolato Keepin’ Time By The River e l’album segna una certa svolta nello stile di Chuck. Prodotto da Doug Haywood e registrato in California (come si sente…), il disco gode anche di un arrangiamento, sempre molto essenziale e mai sopra le righe, ma che davvero contribuisce a completare la veste artistica della proposta in questione. A partire dall’iniziale title-track, la batteria soffusa (Don Heffington), il basso (lo stesso Haywood), la slide guitar (Cary Park) che fa tanto il verso a quella di David Lindley quando suonava con Jackson Browne – l’entourage è lo stesso – il pianoforte (Craig Doerge) e le armonie vocali (ancora Haywood in compagnia di Rosemary Butler e Jennifer Warnes) contribuiscono a creare un amalgama incredibilmente omogeneo e la musica di Chuck Pyle si eleva ben al di sopra del livello raggiunto fino ad allora ed entra in quel microcosmo prettamente californiano che è costellato di tanti piccoli-grandi (nostri) eroi.
Dell’arrangiamento originale di Colorado si mantiene il solo apporto del fiddle di Gordon Burt, il resto è pura West Coast anni ’70, con la sola gradita aggiunta della steel guitar di Greg Leisz: grandi risultati.
I Can’t Go To Mexico rappresenta un altro dei momenti più alti del disco ed un tuffo nel panorama geo-musicale che si trova a sud del confine, ben caratterizzato dall’accordion di David Jackson e dal cantato in spagnolo di Tish Hinojosa.
La ripresa di Other Side Of The Hill ne rappresenta l’ideale prosieguo, ulteriormente impreziosita dalla partecipazione vocale di Jerry Jeff Walker.
Lo stesso staff, aumentato dalla presenza di Rick Cunha alle voci, esegue anche la Tucson Cactus Queen di cui si parlava prima, ribattezzata per l’occasione Sedona Ramona: curioso notare come le composizioni di Chuck Pyle siano oggetto di rimaneggiamenti a livello di titolo, caratteristica saliente e che ne permette l’immediata identificazione, ma tant’è. La veste con arrangiamento favorisce il risultato finale ed il brano ne esce rivitalizzato, con il solito David Jackson ed il suo accordion sugli scudi.
Share Me With Texas è più sintetica come arrangiamento e reca la firma di uno dei più importanti autori degli anni ’70, almeno a livello compositivo: Steve Gillette. La sua Darcy Farrow è diventata un classico senza tempo e questa Share Me With Texas ha tutte le caratteristiche per bissarne il successo, grazie anche al fiddle (Gordon Burt) molto swingato.
Far Flung Places (a firma Jane Voss) ha le credenziali di una ballata di origine anglo-scoto-irlandese per quell’uso quasi in sordina delle cornamuse e per la voce malinconica, triste e sommessa, ma di grande presa emotiva. Il tutto confluisce in una ballata ad alto tasso emozionale.
La sensazione che questo album volesse essere una sorta di ‘rilancio-del-personaggio-Chuck-Pyle’ in veste californiana è estrinsecato dalla presenza, all’interno dei disco, di alcuni dei suoi brani più famosi, rivisitati in veste arrangiata e quindi più immediatamente fruibile dal pubblico, rispetto all’edizione originale voce/chitarra acustica. Se questo era il proposito, possiamo tranquillamente riconoscerne il successo a livello artistico, ma per quanto riguarda l’aspetto di marketing, non ci risulta che, da qui in avanti, Chuck abbia navigato nell’oro…
The Remember Song è un tipico prodotto della vena autoironica di Chuck ed è un’ agrodolce considerazione dell’incalzare dell’età, con tutti quei piccoli/grandi problemi che essa comporta: l’esigenza di usare gli occhiali (ma dove li ho lasciati?), la necessità di scrivere gli appuntamenti per non dimenticarli (ma dov’è la mia agenda?) e via dicendo: amarognola e molto fruibile.
Stars è un’altra bella ballata acustica, suonata in punta di dita, mentre la seguente Mile High Feeling è uno scintillante country-rock dedicato al rapporto che Chuck Pyle intrattiene con Denver, the Mile-High City.
Per concludere l’album più completo della sua discografia, Chuck rispolvera il title-track del suo secondo disco e Step By Step recupera quello spirito e quella vitalità che era risultata penalizzata nella versione originale, volutamente troppo stringata. Stavolta trovo però discutibili gli interventi vocali dei soliti Doug Haywood, Rosemary Butler e Jennifer Warnes.
Una menzione di merito invece per gli acquarelli di Elaine Frenett che abbelliscono booklet e copertina interna.
Soliti tre anni di attesa e poi… una gradita sorpresa: un disco di outtakes collezionate nell’arco di ben trent’anni, almeno stando alle note di copertina di questo A Few Miles Back – Chuck Pyle Volume 1. Situazione classica e molto… normale: l’esigenza domestica di fare posto in cantina costringe l’uomo di casa a prendere decisioni dolorose e disfarsi degli oggetti più disparati che, all’occhio estraneo, rappresentano solo un “volume occupato in modo arbitrario e discutibile”, ma che, all’occhio del proprietario, rappresentano frammenti e momenti di vita dei quali chiunque sarebbe restio a disfarsi: corsi e ricorsi storici, al di qua come al di là dell’oceano.
E’ così che il produttore Doug Haywood si mette diligentemente ad archiviare pile e pile di nastri contenenti frammenti di canzoni, registrazioni in studio e dal vivo ed ogni sorta di testimonianza che si è riusciti a mettere su nastro. Ne nasce il disco in questione e ne siamo davvero contenti: Colorado Wind è la classica ballata scarna negli arrangiamenti (voce e chitarra) nella migliore tradizione di Chuck Pyle, Show & Tell non se ne discosta molto per la struttura artistica e Jacked Up è soltanto un poco più ritmata.
Working Man’s Bread è una lenta narrazione a tempo di valzer, Ooga Booga ha una ritmica spezzata, mentre Boss Of The World è un piacevole esercizio per chitarra acustica e voce: prezioso e semplice al tempo stesso, mi ricorda alcuni pezzi dei Beatles tipo Blackbird.
Two By Two è puro Chuck Pyle-style, mentre No Remedy è sporca di blues acustico.
Pretty One, Wolverina Liar’s Poker, Say No e la conclusiva Jingle seguono tutte la filosofia del nostro: ironia agrodolce (ascoltate Jingle, in forma di intermezzo commerciale, appunto) inserita in un contesto quotidiano che ci pone tutti al centro delle vicende narrate e ce ne rende diretti partecipi: d’altronde Chuck è sempre stato un maestro nel catturare l’attenzione del suo pubblico.
Ad una sorprendente distanza di solo un anno e mezzo esce il settimo album della discografia di Chuck: Affected By The Moon ed è un altro grande disco, più complesso e strutturato dei precedenti, direi quasi più pretenzioso e stimolante, ma questo aggettivo va inteso nel senso che la stimolazione è più diretta al suo interprete che all’ascoltatore. Fin dall’iniziale title-track, con la chitarra sincopata, il violino jazzato ed il basso imperante, Chuck ci fa capire di avere le idee ben chiare circa il risultato da ottenere: un sound personale, onesto, scevro da qualsiasi compromesso commerciale, come peraltro è sempre stato e noi siamo dalla sua.
97 Hillside Road è un salto nel passato di Chuck, autobiografica ed acustica, è impreziosita da un piano liquido che obbedisce alle dita esperte di Pete Wasner, mentre Blue Train è ancora governata dalla sezione ritmica, con il basso in mano all’amico produttore Doug Haywood e la batteria che segue la volontà di Christian Teele, con Chuck da vari anni.
Le ballate (jazzate come Affected By The Moon e If Not Now, più tradizionali quali Outlaw’s Dream, Why Pretend, Romancing The Moment o Cowboy’s Christmas Dream) si mescolano fra di loro e l’interpretazione di Chuck le rende tutte parte inequivocabile del suo repertorio, proprio in virtù della SUA interpretazione. Momenti particolarmente felici di questo CD risiedono ancora nella bluesata Inside Of My Face, quasi un talking-blues, mentre Laurie Ann ha una solida base rock alle spalle.
I Love You Back è tutta miele, ma Think I’ll Go To Texas resta certamente fra le mie preferite, insieme alla già citata Cowboy’s Christmas Dream.
Cosa volete farci: aveva ragione chi scriveva “There’s a little cowboy in us all”. Chuck Pyle è un grande e la sua parsimonia discografica dimostra la validità di ciascuno dei suoi dischi: Chuck è uno che incide solo quando ne vale la pena ed ascoltarlo e conoscerlo è un dovere.
Dino Della Casa, fonte Country Store n. 68, 2003