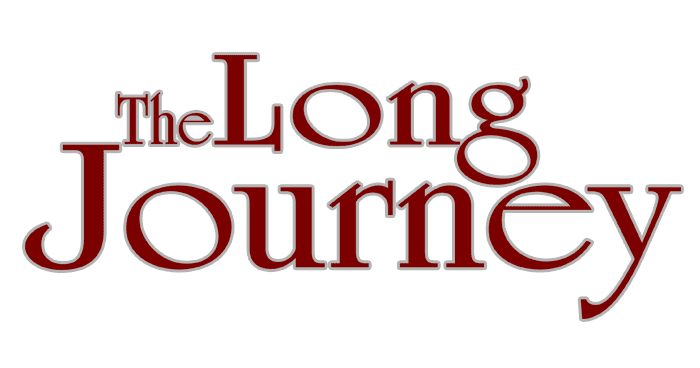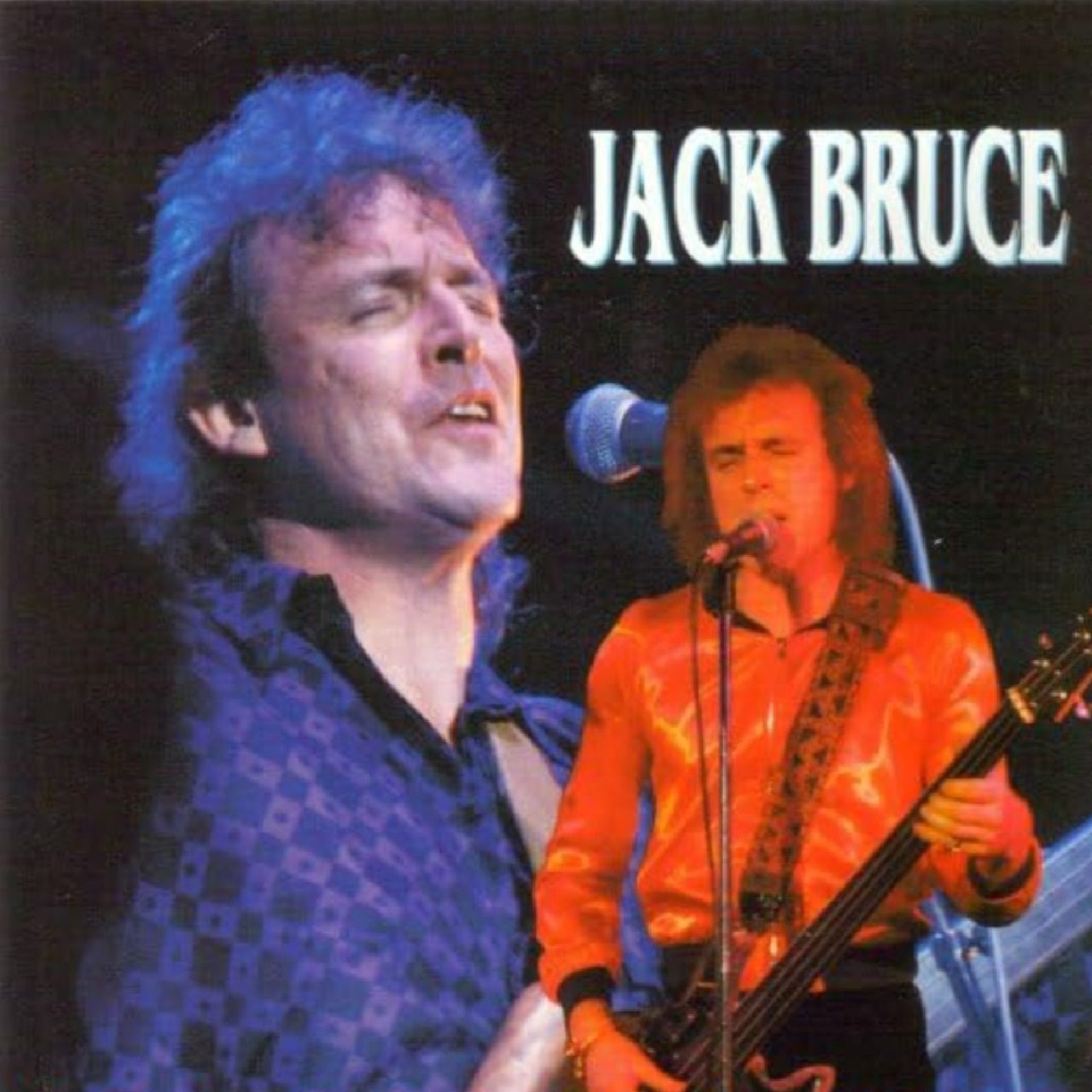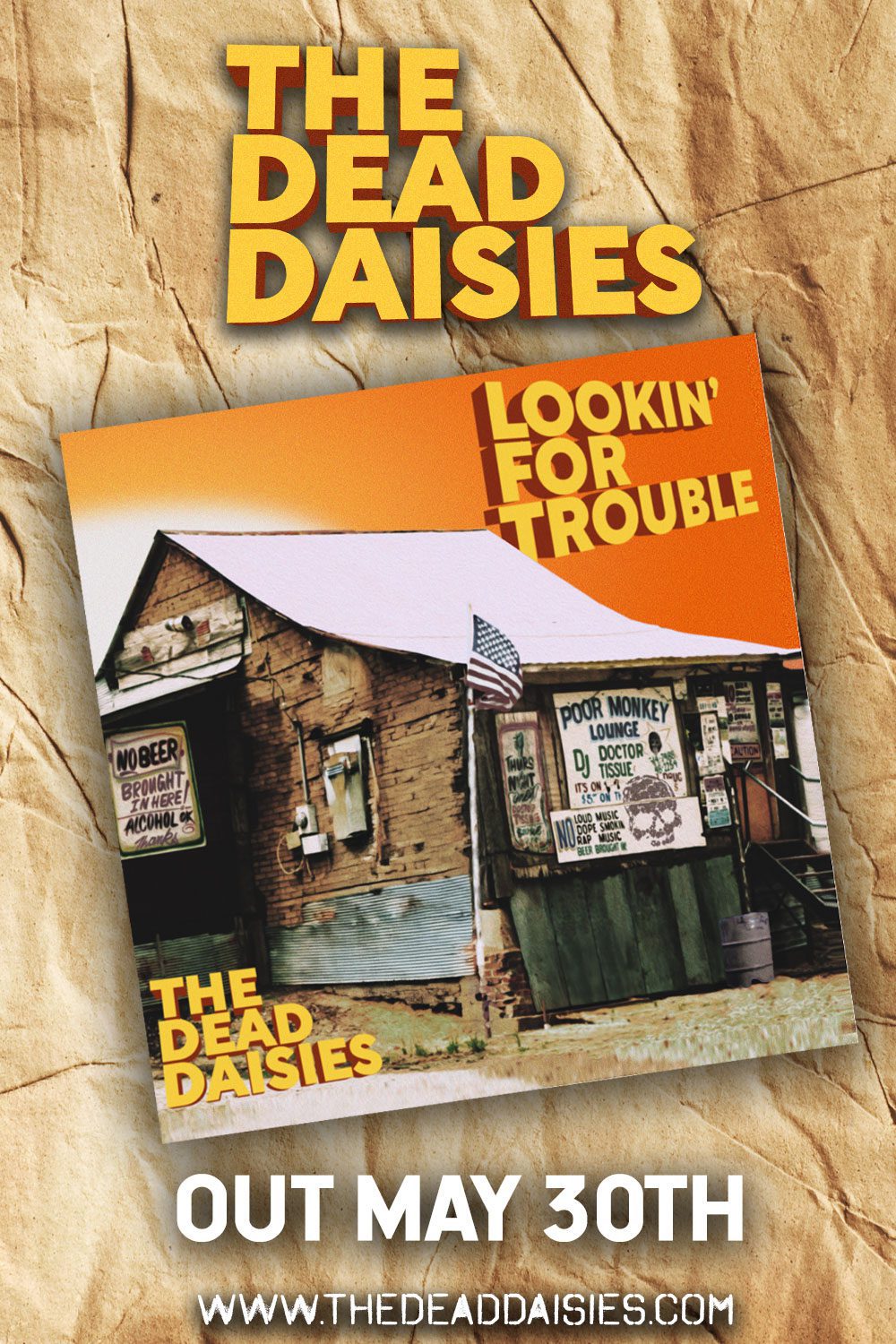Il suo ultimo album, Shadows In The Air“, non è certo un capolavoro. Ma la statura artistica e la gloriosa storia di Jack Bruce sono fuori discussione. Intervistato, ci ha raccontato della sua passione per la musica latina, il blues, del suo concetto di contaminazione. E, naturalmente, dei Cream.
Nel 1911 Bill Johnson, che suonava il contrabbasso ad arco nella Originai Creole Jazz Band, durante un concerto a Shreveport spezzò l’arco e fu costretto a pizzicare le corde del suo strumento con le dita. L’effetto fu talmente nuovo e ricco di sfumature che da allora divenne una moda suonare il basso “pizzicato”. È una leggenda diventata realtà nell’iconografia della musica popolare; fatto sta che da allora il basso ebbe il fondamentale compito di fornire la base armonica alle orchestre jazz, e al contempo il supporto ritmico.
Da Pops Foster a Jimmy Blanton, da Charlie Mingus a Ray Brown, Dave Holland e Jaco Pastorius, il basso nel jazz ha creato una voce strumentale di alta sensibilità.
Nel rock invece il basso è considerato poco nobile. Di solito funge da monotono sottofondo lontano anni luce dalla genialità di musicisti e compositori come Mingus & company. Fanno eccezione – con i dovuti distinguo – sir Paul McCartney, Sting e soprattutto Jack Bruce, ex eminenza grigia del blues inglese che divenne una star con la gioiosa macchina da musica dei Cream.
Seppur oscurato dall’ego ipertrofico di Ginger Baker ed Eric Clapton, Jack Bruce fu autore, e voce, di brani storici come Sunshine Of Your Love, White Room, I Feel Free. Suonava il basso con giri pulsanti, ora sofisticati ora ringhiosi, con il piglio dell’intellettuale che arriva dalla scuola di Graham Bond e Alexis Korner e la visceralità del bluesman e dell’improvvisatore.
Quando Clapton ha giocato a fare la popstar, Jack Bruce è rimasto lontano dai riflettori ma al centro della buona musica. Ha inciso dischi sperimentali come Harmony Row, ha messo il suo prezioso basso al servizio di giganti come Frank Zappa e John McLaughlin, come Lou Reed e Billy Cobham, come Mick Taylor e Mitch Mitchell e oggi è approdato a una strana supeband, piuttosto modaiola. Sono i Cuicoland Express, tra cui spiccano le chitarre dell’ex Living Colour Vernon Reid, le tastiere dell’ex Funkadelic e Parliament Bernie Worrell e un colorito ensemble di percussionisti con Horacio Hernandez, Robbie Ameen, Richie Flores.
Oltre a questi nell’ultimo album Shadows In The Air c’è un’orgia poco confortante di suoni latini con una valanga di musicisti come il prode percussionista cubano Changuito Luis Quintana, i fiati di Pirro Rodriguez, Mario Rivera, Miguel Xenon. Non è bastata la presenza di Clapton che fa rivivere gli assolo di White Room e Sunshine Of Your Love, e questi stessi brani non hanno salvato il concerto all’Alcatraz di Milano da un sound troppo disinvolto e con l’occhio alle nuove tendenze. Ma Jack Bruce difende la sua strada del nuovo millennio.
“Non ditemi che seguo la moda; sono più di vent’anni che mi occupo di suoni sudamericani. La musica di plastica che oggi domina il mercato non mi appartiene, io parto sempre dal folk e dal blues.”
Molti brani però suonano esageratamente moderni.
È difficile stare in equilibrio oggi. Io accetto sempre di rimettermi in gioco. Sarebbe facile suonare sempre il buon vecchio blues-rock. Farei felici tutti gli appassionati e anche me stesso, ma poi arriverebbe qualcuno a dire “quello è solo un nostalgico, un vecchio fuori dal mondo”. Così non rinnego il blues, ma mi confronto anche con i suoni di oggi, a rischio di sentirmi dire “vuoi imitare le nuove tendenze”. La verità è che io sperimento e tutto ciò che faccio ha radici nella musica tradizionale.
Ma cosa pensi di questa invasione di suoni latinoamericani che inflaziona il mercato?
È la moda, è il frutto dei voleri delle grandi case discografiche. Quando una cosa funziona, ci si buttano tutti a capofitto. Non mi curo delle mode. I musicisti, la critica e il pubblico competenti sanno distinguere chi suona con vero spirito popolare e chi incide dischi senza anima da gettare in pasto alle radio, alle tv, alle discoteche. Ad esempio le canzoni di Compay Segundo ti entrano nel cuore e nell’anima, come quelle di Dulce Pontes o di Ruben Gonzales.
Non ti piace essere definito un bluesman.
Il blues è la mia base di partenza, ma io cerco di inventare sempre cose diverse. Non sarei cresciuto con Alexis Korner e Graham Bond.
Raccontaci il tuo rapporto con loro…
Fu un periodo splendido di ricerca. Ci consideravano dei pazzi alla Roundhouse, anche gli altri musicisti non capivano quello che facevamo, e a volte neppure noi. Alexis fondeva blues e jazz, era un personaggio eclettico, eccezionale, ancora oggi è una bandiera. Fu il primo ad ascoltare i grandi bluesmen neri e a trasformare il loro suono in qualcosa di autarchico, che avesse il calore e la radice blues ma non fosse una copia pedissequa dell’originale. Anche Bond era un genio. Poteva guidare un gruppo rock come una big band alla Jimmie Lunceford. Era una specie di direttore d’orchestra.
Cosa hai imparato da loro?
Che la musica non ha confini, una cosa che molti sbandierano oggi come una grande novità.
Sei molto polemico con la scena musicale odierna.
No, lo dimostrano i musicisti che lavorano con me, da Reid a Horacio Hernandez. Ma voglio puntualizzare le cose: oggi tutti parlano delle contaminazioni come di una cosa nuova, stravolgente, geniale, ma le contaminazioni ci sono da sempre. Senza andare molto indietro persino Dizzy Gillespie ha suonato con percussionisti cubani come Frank Machito Grillo e Mario Bauza.
Per non parlare di quelle dei Cream…
Già. Abbiamo inventato una fusione di rock, blues, jazz, psichedelia, improvvisazione. Non siamo stati dei geni: era il frutto delle esperienze precedenti. Un piccolo cenacolo all’interno del più ampio cenacolo del British Blues. La vere novità furono due: eravamo un trio mentre prima c’erano gruppi aperti e con molti elementi. Poi sfidammo il pop imperante dei Beatles.
Cioè?
I ragazzi di oggi non sanno che nessuno voleva pubblicare i nostri dischi. Dicevano che era un sound troppo difficile. Quando cominciammo a vendere milioni di copie, chi aveva rifiutato le nostre canzoni cominciò a mangiarsi le mani.
Il disco preferito dei Cream?
Personalmente il Live, che rende al meglio la nostra dimensione. Ma tutti, da Fresh Cream a Disraeli Gears a Wheels Of Fire hanno qualcosa di interessante.
Come erano i rapporti con Ginger ed Eric?
Io badavo alla sostanza e a non apparire. Loro volevano sempre superarsi artisticamente, era una continua e tacita sfida. Anche stimolante.
Cosa ha logorato il vostro rapporto?
In pochissimo tempo ci siamo spremuti passando dalla psichedelia a lunghissime jam session senza barriere, dalle riletture durissime di blues come Rollin’ And Tumblin’ agli effetti elettronici e agli arrangiamenti con violini e clavicembali. Era difficile trovare nuove strade.
Quindi?
Sul palco ci completavamo l’un l’altro, ma quando si scontrarono le personalità di Eric e Ginger furono guai.
Molti dei Cream ricordano solo Clapton, la cosa ti infastidisce?
No, il mio lavoro è scrivere e cantare. Ero la voce dei Cream, lo divenni quasi per caso ma credo di aver dato un’impronta precisa alla band. Non ho mai cercato la popolarità fine a se stessa e non ho mai cercato di essere una popstar. Ho contribuito ad aprire la strada all’hard rock.
Qualcosa da rimproverare ad Eric?
No, altrimenti non avrebbe collaborato al mio ultimo album. Eric è uno che ha fatto delle scelte, ha sofferto, ha avuto il successo con i suoi alti e bassi. Bisogna conoscerlo bene per giudicarlo, quel che conta è ciò che suona, e secondo me dà il meglio quando suona il blues di Chicago.
Qualcuno ha detto che l’hard rock è nato dal basso di Jack Bruce e l’heavy metal dalla chitarra di Clapton.
Non sarei così categorico; certo abbiamo dato una mano a diffondere l’idea di una fusion tra blues e rock, tra rock e jazz. Prima un rocker che avesse sconfinato nei territori del blues sarebbe stato linciato dai puristi, e così un musicista di blues o jazz come me, non avrebbe mai pensato di ‘sporcarsi’ con il rock.
Ti mancano quei tempi?
Mi mancano gli entusiasmi collettivi di quell’epoca. Oggi, di quella generazione, siamo rimasti in pochi a combattere: Peter Green nonostante i suoi problemi psicofisici è sempre sulla breccia, John Mayall si tiene al passo con i tempi senza tradire le origini, John McLaughlin suona negli stili più diversi sempre ad altissimi livelli. Mi manca l’atmosfera della Londra anni Sessanta e Settanta, oggi c’è tutto un altro clima. Non c’è più un vero movimento. Per questo gente come Mayall è emigrata a Los Angeles.
Ma tra i bassisti chi sono i tuoi maestri?
Jimmy Blanton mi ha insegnato molto. Poi per la mia crescita è stato fondamentale Charlie Mingus. Cominciai ad ascoltare i suoi album in Italia, alla base militare di Aviano, e da allora la mia vita non fu più la stessa. Quando lo incontrai di persona ne rimasi affascinato, ha influenzato parecchio il mio lodo di suonare e di comporre.
Il futuro?
Concludere questo tour mondiale che mi sta dando soddisfazioni e poi tornare in sala di incisione. Tornerò al blues più canonico, così i miei vecchi fan saranno contenti, ma da lì ripartirò per nuove strade, sto pensando ad un’opera sperimentale e non smetterò di suonare con gruppi di musicisti multietnici.
Antonio Lodetti, fonte JAM n. 77, 2001