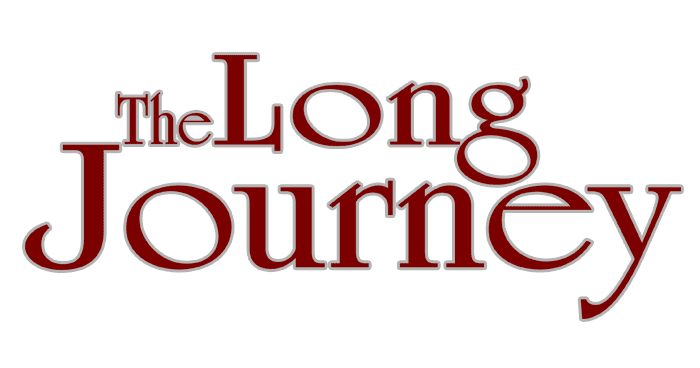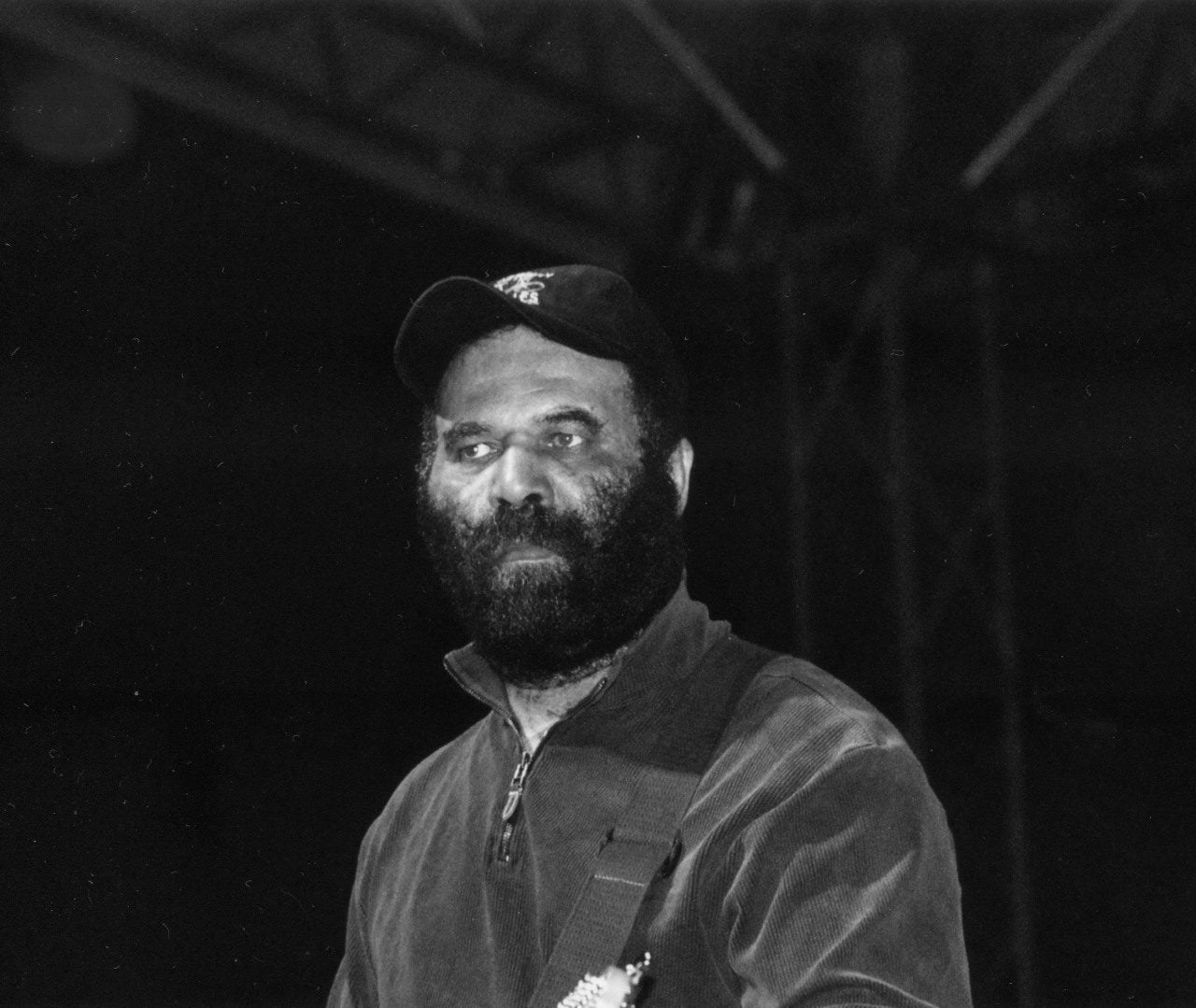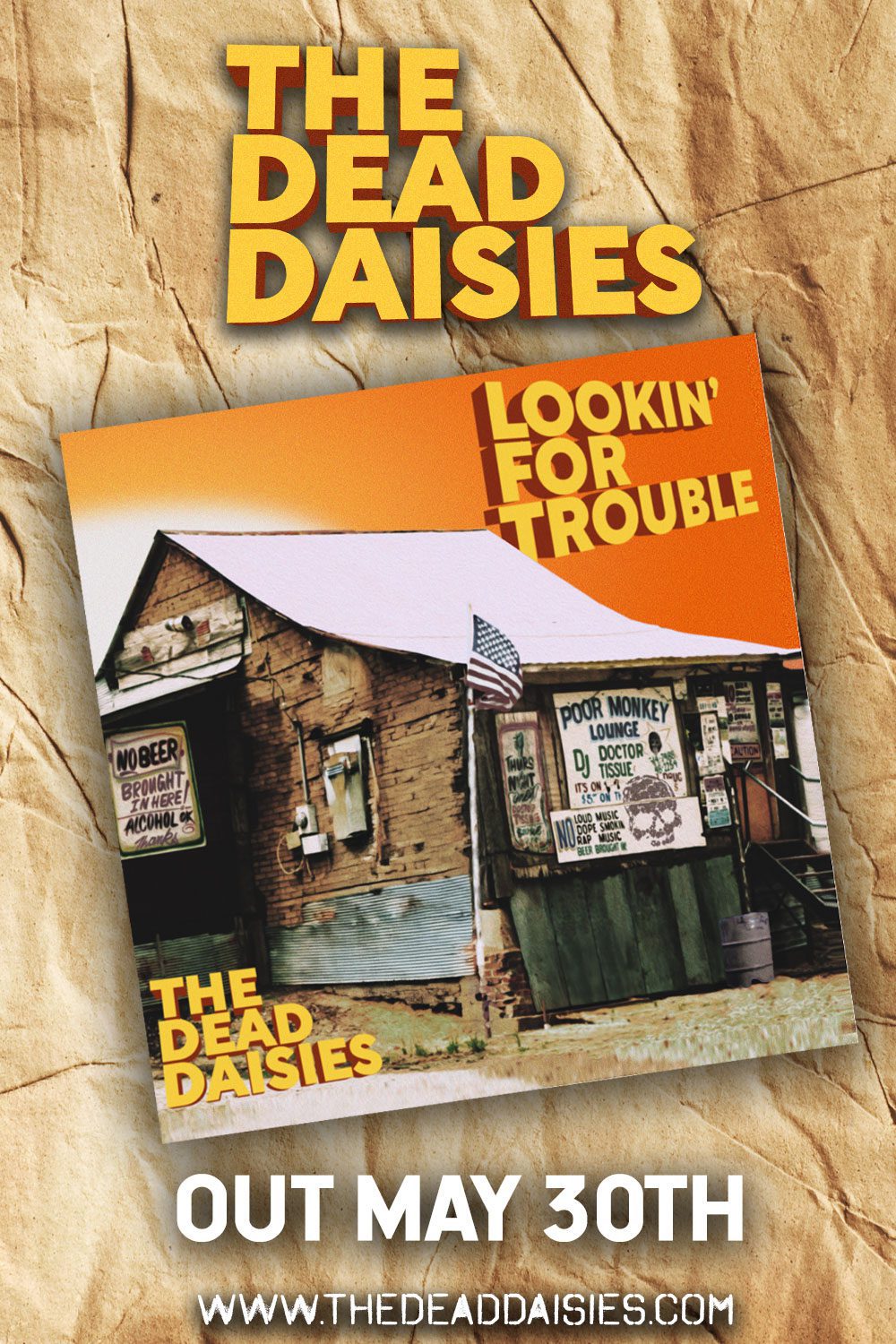A circa quindici anni dalla sua apparizione, travolgente, sulle scene blues e a dieci dal nostro primo incontro in occasione del suo debutto italiano al Folk Club di Torino (Il Blues n. 83), ritroviamo Otis Taylor in occasione dell’uscita del suo ultimo album My World Is Gone. Artista singolare e a sé stante, Otis è rimasto del tutto coerente con sé stesso, e il suo modo di fare musica lo pone al di fuori di logiche e correnti, tanto a livello musicale che a livello tematico. Chi altri ha saputo in questi anni coniugare una musica evocativa e magnetica, non a caso da lui definita ‘trance blues’ e l’attenzione nel raccontare, senza compromessi, temi sociali, marginalità e storie di sofferenze, grandi e piccole? Ad uno sguardo più attento, la sua discografia è più diversificata di quanto non possa sembrare e forma un corpus unitario di spessore. L’uomo è acuto, diretto e al contempo lontano da intellettualismi, e ne abbiamo avuto conferma nella conversazione che segue.
Potremmo cominciare proprio dal nuovo disco, My World Is Gone, che arriva un anno dopo Contraband, come è nato e quale è stato il ruolo di Mato Nanji?
Avevo cominciato a scrivere qualche pezzo per un nuovo disco e una sera ero a Denver per sentire il tour in tributo a Hendrix, chiacchieravo nel backstage con Chuck Campbell che ha suonato su alcuni miei dischi. Ricordo che Chuck si lamentava di qualcosa, c’era anche Mato il quale ad un certo punto se ne uscì dal nulla con una frase, un commento che in qualche modo mi è rimasto in testa, disse appunto «my world is gone», il mio mondo è sparito. L’album così ha finito per prendere una forma diversa e ad un certo punto ho chiesto a Mato, lo conosco da anni, di partecipare alle registrazioni.
Ha accettato subito o hai dovuto convincerlo?
Gli ho spiegato il progetto, e lui era convinto che potesse funzionare proprio perché io affronto l’universo dei nativi americani non da una prospettiva di protesta ma da quella del semplice storyteller. Per questo ha detto subito di sì quando gli ho chiesto di suonare; Mato è molto bravo come chitarrista e anche come cantante, tanto che ho dovuto quasi tenerlo a freno. Non ha suonato su tutti i brani ed ha cantato solo su alcuni, perché volevo che restasse un disco di Otis Taylor non uno degli Indigenous!
Sui nativi americani hai scritto anche in passato, pensiamo a Kitchen Towel, Mandan Woman, Took Their Land e Lost My Horse che era su White African e ritrovarlo qui, questa volta è stato diverso?
La differenza in questo caso è nel concetto che era alla base del disco, e avere Mato vi ha aggiunto una consistenza particolare. Sentivo la responsabilità di rispettare la storia del suo popolo, è stato molto importante avere la sua approvazione per tutto quanto, dai testi al filmato visibile in rete in cui suoniamo Blue Rain In Africa, alle fotografie incluse nel libretto è stato tutto concordato con lui.
Sapevi che avresti scritto sul massacro di Sand Creek?
Sì. Qui in Colorado l’episodio storico è molto noto, come anche la strage di Ludlow su cui ho scritto in passato (Your Children Sleep Good Tonight). Il mio approccio non cambia, racconto una storia, scelgo una prospettiva e la seguo. In questo caso posso sperare che, chi non conosce l’episodio vada a informarsi, come credo abbia fatto tu. A volte il testo del brano lascia spazio all’ascoltatore per immaginare una direzione diversa, per questo le note costituiscono una sorta di traccia per decodificare la canzone, restringere il campo.
Come mai hai scelto di riprendere Lost My Horse?
Perché tematicamente era affine al materiale del disco, e pensavo che potesse venire bene con Mato. Perdere un cavallo nel West di allora era drammatico, non parliamo poi del furto, potevano impiccarti per aver rubato un cavallo a quei tempi.
Anche in passato hai dato nuova veste a tuoi brani su dischi come Pentatonic Wars & Love Songs e Clovis People, sapevi che avrebbero funzionato?
Non posso rivelare i miei segreti! In ogni caso fino a che non provi non puoi essere sicuro che verrà bene. E’ la stessa cosa con i musicisti, devi fidarti del tuo istinto e cercare di prendere le decisioni che ti sembrano migliori. Non sempre funziona, ma almeno me ne assumo la responsabilità.
Come sei riuscito a costruire album diversi tra loro e a coinvolgere musicisti di varia estrazione (Moore, Musselwhite, Jason Moran, Chuck Campbell, Anne Harris…) pur conservando la tua personalità e coerenza?
Beh, devi prima di tutto essere te stesso…poi in inglese c’è un’espressione che descrive quel che non mi piace fare, cioè baciare il culo di qualcuno per avere qualcosa. Non lo faccio. Con i musicisti è lo stesso processo, una sorta di reciproco test continuo, io cerco di portarli fuori dalla loro ‘comfort zone‘ e vedere cosa succede, è stato spesso così specie nel progetto sul banjo (Recapturing The Banjo). Mi ricordo che una volta Alvin (Youngblood Hart n.d.r.) stava suonando un brano e stava incasinando il tempo, glielo dissi e lo rifacemmo, con Guy Davis o Gary Moore è stato lo stesso. Nemmeno io ho il controllo, anzi in quei momenti devi reagire, in un certo senso e rispondere alla nuova sfida che ti si pone davanti in quel momento. Così facendo, Gary Moore ogni tanto l’ho fatto diventare matto, su alcuni brani non era facile suonare ma poi ha trovato la chiave per farlo lì, era un musicista più versatile di quanto non si pensi. Su Ain’t No Cowgirl per esempio, all’inizio non riusciva a cavarci quasi nulla. Peccato se ne sia andato, Cassie tra l’altro ha suonato in Europa con suo figlio Jack.
Come Charlie Musselwhite, del resto che ha suonato in contesti sonori molto diversi.
Ah si Charlie è grande, sin da quando lo ascoltavo suonare Christo Redemptor da giovane.
Come era nata la collaborazione con Jason Moran e i suoi musicisti.
Jason lo conobbi ad un concerto in Germania, poi ci incontrammo di nuovo in America, credo, in West Virginia e gli proposi di collaborare. Penso che quel disco sarebbe stato diverso senza di lui, e per certi versi non sia stato apprezzato del tutto. Però mi piace ancora, abbiamo catturato una grande versione di Walk On Water.
Un altro musicista che è ormai parte integrante del tuo suono, almeno su disco, è Ron Miles.
Ron è un grande musicista, con lui ormai non c’è nemmeno bisogno di parlare, conosci il detto, ‘talk is cheap?’, Ecco con lui è così, credo sia il musicista più presente nei miei dischi, forse solo Cassie ha suonato in più dischi di lui.
Cosa rispondi a chi criticasse la scelta di pubblicare dischi con una troppa frequenza?
Non so se a Picasso dicessero che faceva troppi dipinti! Scherzi a parte non so quanto tempo avrò ancora per fare dischi, e ho sempre materiale nuovo. Inoltre prima di registrare Contraband ho avuto una serio intervento chirurgico, che per fortuna si è risolto positivamente e la cosa mi ha spinto a continuare a produrre dischi. Comunque non farò un disco dal vivo, quello lo faranno quando sarò morto!
Uscirà mai un tuo disco anche in formato LP?
Se ne era parlato, ma non dipende da me, è una decisione della casa discografica.
Come è nato Trance Blues Festival che organizzi nella tua città, Boulder, Colorado, da ormai due anni?
L’idea è nata dopo alcuni workshop che avevo tenuto qualche anno fa. E’ un piccolo festival comunitario in cui chiunque, di tutti i livelli e qualunque strumento suoni, può venire a suonare insieme. Ho coinvolto alcuni amici come sponsor e vari musicisti, tra cui quelli della mia band. Nelle prime due edizioni sono venuti Bob Margolin, Chuck Cambpell, George Porter Jr, Don Vappie ed anche Mato, per due anni di fila.
Che importanza ha avuto il Denver Folklore Center nella tua formazione, ricordiamo che hai dedicato un pezzo al suo fondatore Harry Tuft, Harry Turn The Music Up.
E’ un posto speciale. Ci sono andato ogni giorno dopo la scuola per anni, anche perché era a quattro isolati da casa. Ci si andava per imparare a suonare musica, ascoltare Mississippi John Hurt, ma anche solo per passare del tempo o ascoltare l’ultimo disco di Junior Wells. Era un momento storico davvero particolare e irripetibile.
Sei ancora impegnato con progetti sul blues nelle scuole?
Sì di tanto in tanto tengo ancora degli incontri, l’ultimo lo scorso novembre; è importante incuriosire i ragazzini che, forse, ascolteranno questa musica tra vent’anni. Su un centinaio di ragazzini magari questa musica piace solo a qualcuno, però se gli piace probabilmente continuerà a piacergli per il resto della vita.
A proposito di curiosità, ti è capitato di imbatterti in storie, finite poi sulle canzoni, ambientate al di fuori del Nord America? Ricordiamo almeno un precedente di qualche anno addietro, House Of The Crosses.
A volte sì, e non è detto che non succeda in futuro. Potrei ambientare una storia anche in Alaska! Chissà potrei scrivere di quando ho suonato in Libia circa otto mesi prima della rivoluzione. Era una situazione strana, suonavamo in un hotel di lusso ad un evento privato, c’erano molte guardie del corpo e non eravamo tranquilli, diciamo che speravamo di tornare a casa al più presto.
La tua musica, seppure sfugga a facili categorizzazioni, è stata usata in produzioni cinematografiche come Public Enemies di Michael Mann.
Beh, ovviamente significa molto, non solo dal punto di vista economico, soprattutto venendo da uno come Mann nelle cui produzioni la musica ha sempre avuto un ruolo centrale, la gente la nota, sin da quando era produttore di Miami Vice. Ma sono soddisfatto anche degli inserimenti in serie televisive e in un altro film, Shooter, insomma non posso lamentarmi di Hollywood. Sul perché abbiano scelto proprio quei brani, non so rispondere, forse è una questione di serendipità.
Se ti guardi indietro agli scorsi quindici anni, pensavi che avresti avuto questo tipo di percorso, di evoluzione?
No, a dire il vero non ci pensavo proprio, non saprei dire se ho avuto successo, ma del resto non faccio canzoni per vendere dischi. Non so ancora di preciso cosa farò nel prossimo disco, evito di ripetermi e di fare lo stesso disco due volte, cerco di sorprendere per primo me stesso. Scommetto che anche se fossi Sherlock Holmes non avresti indovinato alcune mie mosse! Non è facile, è un po’ come camminare su una corda sospesa, anche perché i critici sono sempre pronti ad aspettare che io commetta un passo falso o cada. So come ragionano: stavolta non è caduto, l’ha scampata, ma la prossima volta…
Devi raccogliere la sfida, in un certo senso.
Sì ma la macchina deve essere messa a punto prima di gareggiare! (ride) Suona bene, la puoi tradurre in italiano?
(Intervista realizzata il 16 marzo 2013)
Matteo Bossi, fonte Il Blues n. 123, 2013