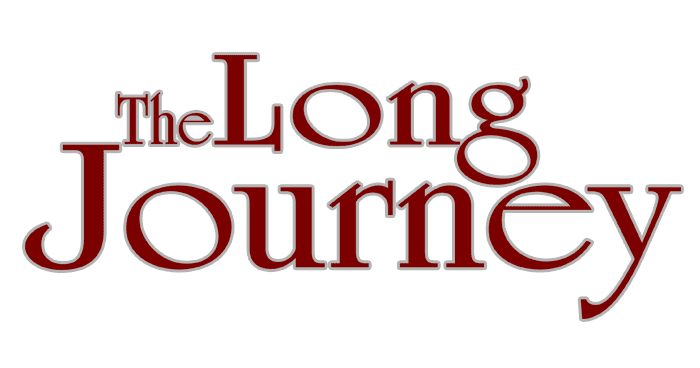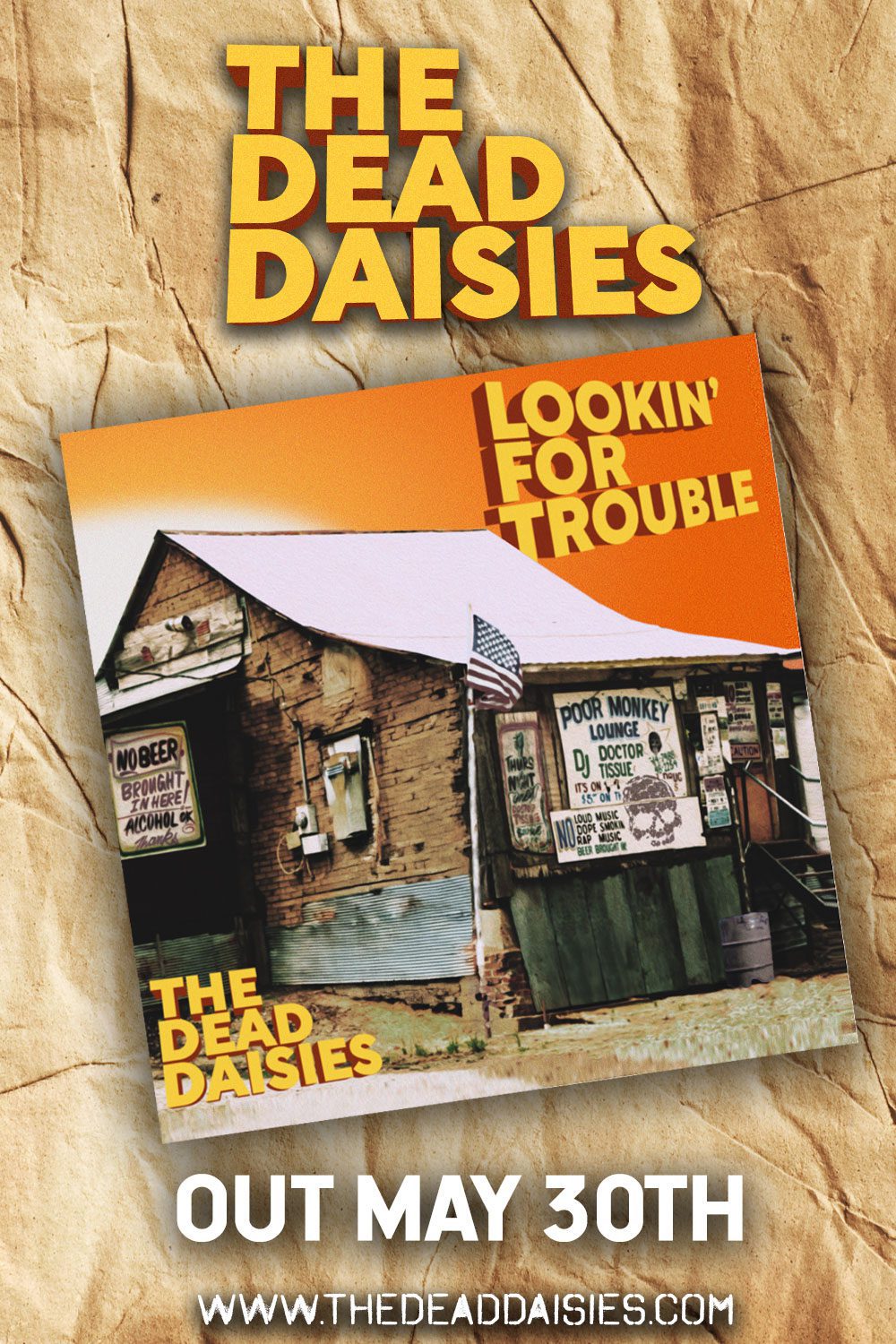Quasi si scusa Shakura S’Aida per il suo italiano: «Vivo in Canada, a Toronto, ci sono culture di ogni paese e siamo molto consapevoli che non tutti parlano inglese. Io ho vissuto in Svizzera e sono convinta che se visiti un posto dovresti cercare di avvicinarti a una cultura differente, imparare qualcosa, mostrare rispetto. A volte gli americani non lo capiscono, molti non viaggiano, gli europei hanno una mentalità diversa, tendono ad avere una visione più allargata. Toronto è una grande città, sei milioni di abitanti, c’è una Little Italy, un quartiere somalo, io abito a Little Poland, ci sono grosse comunità greche, ucraine, tedesche, ungherese, cinesi, thai, vietnamite, brasiliane…Sono nata a Brooklyn, ma mio padre è svizzero e perciò i miei decisero ad un certo punto di trasferirsi in Svizzera, una scelta di vita. Però mia madre dopo tre mesi decise che non faceva per lei, voleva tornare a casa, ma le ci vollero tre anni per ottenere il visto per il Canada. Negli anni Settanta era dura per noi in Svizzera, eravamo i soli neri e la gente ci indicava per strada, ovunque andassimo, mi toccavano i capelli, cose del genere. Per mia madre era insopportabile, lei negli anni Sessanta era un’attivista per i diritti civili, conoscete i Greensboro Four? Fecero un sit-in in un diner in North Carolina nel 1960 e mia madre fece lo stesso poco dopo, andò anche in prigione, era parte del movimento. Perciò vivere in un posto dove la gente ancora ti trattava in modo diverso per via del colore della pelle, quindici anni circa dopo le loro lotte, è stata molto dura».
Sappiamo che la figura di Nina Simone ti è particolarmente cara.
Negli ultimi cinque anni con mia madre abbiamo organizzato degli incontri nelle scuole in Canada, in cui lei parla ai ragazzi, raccontando le sue esperienze nel movimento per i diritti civili. Io conosco la storia ma ne ho sempre avuto un’idea eccitante, come fosse Woodstock. Poi tre anni fa siamo andate a Memphis al Civil Rights Museum, dove Martin Luther King venne ucciso ed ero contenta di essere lì con lei e con mia sorella, ma mentre visitavamo il museo lei era in silenzio, impassibile. Verso la fine ci disse che tutto questo non la rendeva felice, erano stati tempi durissimi, in cui molte persone sono morte e altre hanno rischiato la vita. Forse è stata la prima volta che l’ho capito, voglio dire, ero fiera di quanto fatto da mia madre, ma ne avevo colto solo l’aspetto avventuroso. Perciò visitando il museo aveva rivissuto la rabbia, la frustrazione, la paura. Poco dopo avevamo un incontro nell’Alberta, Canada, e mia madre stava parlando ad alcuni studenti neri e improvvisamente è scoppiata in lacrime. Mi ha detto che allora pensavano che avrebbero cambiato il mondo per le generazioni future, ma le cose non sono cambiate molto. Ci siamo sentite due giorni fa perché le hanno chiesto una intervista, dato che era coinvolta anche con le Black Panthers, ma mi ha detto che non vuole parlarne, tanta è la delusione per come le cose non sono migliorate. Quando ho pensato il progetto teatrale su Nina Simone è stato dunque un tributo a due donne che ho sempre ammirato. Ed ho coinvolto altre due artiste straordinarie, Kelllylee Evans, una delle mie cantanti preferite, lei ha una voce stupefacente, è la versione femminile di Gregory Porter e la mia seconda madre, Jackie Richardson. Jackie è stata l’equivalente di mia madre per la mia carriera, mi ha insegnato tutto quel che so come artista, partendo da come stare su un palco. Ho scritto questo spettacolo per noi tre e all’inizio mi hanno consigliato di scegliere un periodo della sua vita e incentrarlo su quello. Ho guardato alla sua vita e quello che la definiva, e questo ci accomuna, credo fosse l’inconsapevolezza di essere nera fino a quando qualcuno non ha cercato di fermarla a causa di essa.
Questo è un aspetto che mi tocca da vicino, perché nella mia famiglia chiaramente non ho mai avuto nessun problema, ma al di fuori di essa, in altri ambienti esterni la gente ti considera diversamente o si comporta in un altro modo con te per il colore della tua pelle. Negli anni Sessanta Nina frequentava James Baldwin o Lorraine Hansberry e loro la spronavano a prendere coscienza del proprio essere nera, era un momento topico del rinascimento artistico degli afroamericani. C’era tutta una generazione di artisti brillanti, che cercava di rompere barriere e cambiare le cose e le dicevano, «tu cosa stai facendo?» E lei non seppe cosa rispondere, era stata molto occupata con la sua musica. Cosi quando Lorraine Hansberry le chiese cosa stesse facendo lei, Nina, per cambiare il mondo, capì che non aveva riflettuto su cosa significasse essere nera, lo era e basta, non aveva pensato ai bambini morti in quella chiesa a Birmingham, Alabama (fatto avvenuto il 15 settembre 1963, vennero uccise da una bomba quattro bambine e ci furono molti feriti-n.d.t.-). Questo le cambiò la vita. Totalmente. Lo spettacolo racconta proprio questo passaggio dall’innocenza della gioventù alla consapevolezza, acquisita attraverso la contaminazione, il venire a contatto, e un contatto che causa un dolore profondo, con il razzismo. Passando poi per la fase dei diritti civili e in seguito la sua decisione di lasciare l’America, vivere in Europa e in Africa. Possiamo ascoltare Aretha, Otis, Elvis, il blues…ma la musica di Nina è rilevante, piena di significato per i giovani di oggi, come lo era venti o quarant’anni fa per i giovani di allora. Ogni generazione ha riscoperto Nina, attraverso il cinema, la televisione, le riprese dei suoi brani, magari in chiave dance o house, prendono Sinnerman e la rifanno. Molti magari non si rendono subito conto di stare ascoltando una cosa di Nina, quando Michael Bublè canta Feeling Good, e teniamo presente che la canzone venne scritta per un musical intitolato, credo, The Roar Of The Greasepaint –The Smell Of The Crowd, la canta esattamente usando l’inflessione di Nina Simone. Quando Gregory Porter canta Chain Gang, magari in modo inconscio, però ricalca l’interpretazione di Nina e potrei fare altri esempi. I musicisti di oggi attingono a piene mani dal suo repertorio.
Pensiamo poi che Nina era una pianista con una formazione classica alle spalle e le sue composizioni erano fantastiche. Nello spettacolo ci sono momenti in cui lascio spazio al piano, senza canto o al massimo con un recitativo, perché volevo che il pubblico comprendesse le sue qualità di strumentista e di autrice, distintamente. A volte infatti le due cose non andavano perfettamente insieme, ad esempio ho sempre pensato che Ain’t Got No, I Got Life avesse un testo fantastico e una parte di piano molto bella, ma insieme non funzionassero del tutto. Mi interessava il percorso di Nina alla scoperta di sé come donna e come nera, fiera di esserlo senza dover chiedere scusa a nessuno. Nel mettere insieme lo spettacolo, ad esempio sull’interpretazione di Four Women abbiamo discusso molto tra di noi, perché una pensava che le quattro donne fossero prostitute e un’altra che fossero donne sole, non riuscivamo a venirne a capo, alla fine il regista ci ha detto «non dovete essere per forza d’accordo, potete cantare ognuna la vostra parte tenendo a mente la vostra idea. Quando cantate insieme ognuna di queste donne avrà una sua voce». E’ stato importante e questo ci ha aperto una prospettiva diversa. Una delle mie canzoni preferite è Black Is The Color anche se stasera, posso già dirvelo, canterò la canzone di Billie Holiday che ha cantato anche Nina, Tell Me More And More And Then Some. Ma devo dire che dipende molto dal mio umore se ad esempio penso al mio ex compagno e canto Black Is The Color so che mi metterò a piangere, se invece sto pensando a mia figlia e al colore dei suoi capelli sono felice e orgogliosa, le emozioni variano e la canzone assume altri significati. Nello spettacolo la eseguiamo mentre sullo sfondo vengono proiettate immagini di un nero che viene impiccato mentre attorno dei bianchi stanno facendo un picnic. Quindi mentre canto “black is the color of my true love’s hair…” scorrono quelle immagini in forte contrasto, poi Jackie canta Blackbird dei Beatles ed io canto l’altra Blackbird, quella che fa “why you wanna fly blackbird…”, poi la band ad un certo momento smette di suonare, Roger e Tony sono qui con me stasera, e cominciano a fare step-dancing e le immagini diventano gradualmente più piccole e si vedono solo i particolari dei bianchi che ridono e si divertono e la corda che uccide l’uomo tramite impiccagione. L’effetto secondo me è molto forte e modifica il senso che la gente attribuisce alle canzoni. La musica di Nina ha molte sfaccettature, non ha un significato univoco, ognuno ne trova uno suo, forse perché lei era molte cose insieme, mischiava jazz, folk, blues, soul, musica classica, forse proprio per questa ragione i suoi brani sono stati ripresi da folksingers come da jazzisti.
Hai fatto parte di una formazione di world music agli inizi.
Kaleefah. Avevo ventisette o ventotto anni e Jackie Richardson mi chiamò dicendomi che c’era una persona che voleva mettere insieme una band, di cui io sarei stata la cantante principale, voleva anche sua sorella Betty, Jackie e un’altra nostra amica Gale come coriste, saremmo state in sei. Lei disse che sarebbe stato bello, io però non credevo di poterlo fare, voglio dire io non ero nessuno e Jackie che cantava da sempre sarebbe stata la mia corista? Assurdo. E anche la mia insegnante di canto avrebbe fatto parte delle coriste. Tutta gente con molta più esperienza di me. Avevamo due batteristi, un percussionista, fiati, chitarra e basso, un gruppo molto numeroso. Siamo stati anche nominati per un premio, ma credo che un progetto del genere fosse troppo in anticipo sui tempi, era il 1992 e l’avessimo fatto dieci anni dopo probabilmente avremmo avuto un riscontro diverso, all’epoca non c’erano folk festival e viaggiare con una band del genere era complicato e costoso. Però fu una bella esperienza, mi ha insegnato moltissimo. Cantavo da solista anche prima di allora, ma non seriamente, non ci ho provato davvero fino a circa dieci anni fa. Ho lavorato anche come attrice e lo faccio ancora se riesco ad andare alle audizioni! Anche per il cinema o la televisione, se si presenta l’opportunità.
Cosa ti ha fatto cambiare idea?
Avevo divorziato da mio marito nel 1998 ed ero sola con due bambine di uno e otto anni, avevo bisogno di lavorare. E per sette anni ho svolto vari lavori, receptionist, public relations, organizzatrice di eventi, sponsorship manager…un giorno ho pensato che il mio lavoro consisteva spesso nel raccogliere fondi, chiedere contributi alla gente, ma non lo facevo nemmeno per me stessa. Come avrei potuto dire alle mie figlie di seguire i loro sogni se io stessa non ci stavo nemmeno provando? Così nel 2005 scrissi nel mio diario che non avevo più paura di provare ad essere brava, grande, credo che questa dovrebbe essere l’aspirazione di tutti, di qualunque cosa si occupino. Così l’anno successivo chiesi in prestito dei soldi e realizzai il mio primo disco, Blueprint. Mi dissi che questo era quello che volevo davvero fare. Esattamente da lì ad un anno mi sono ritrovata sul palco del Montreal Jazz Festival, davanti a cinque/settemila persone, il mio primo grande concerto, sentivo l’energia del pubblico, come un’onda che si propagava verso di me e ritornava indietro, come in un ciclo ininterrotto. Capii subito che quello era ciò che volevo fare davvero e la mattina dopo mi ritrovai a piangere, so che sembra sciocco dirlo, ma ho sentito che il mio spirito era felice, perché cantare era la mia strada. Tanto è vero che da allora ho raggiunto gli obbiettivi che mi ero prefissata, dal cantare ai festival, venire in Europa, all’incidere per case discografiche, cantare in Russia, mi manca giusto il Giappone. Per me si tratta di capire e accettare i doni, i talenti che ho ricevuto e che non dipendono da me, so di non essere la miglior cantante del mondo, ma sento di essere fortunata a potere condividere questo talento che mi è stato dato, viaggiare, stabilire un contatto con persone differenti.
Sei a tuo agio con soul, blues, rhythm and blues,rock’n’roll, jazz…ma quale rapporto hai con il gospel?
Da bambina avevo una zia a Greensboro, North Carolina, che era una predicatrice e mi ricordo che a quattro o cinque anni le dissi che volevo cantare, eravamo in chiesa e mi ero messa a cantare e il coro della chiesa stava facendo le prove. Però la zia venne da me e mi disse che il maestro del coro le aveva detto che non potevo cantare con loro, non ero abbastanza brava. Ero una bambina e ci rimasi male, però mi ricordo bene quella musica, il gospel, la sensazione in quelle chiese battiste. Poi quando ci siamo trasferiti in Canada mi sono unita alla chiesa avventista del settimo giorno, era un modo di ribellarmi ai miei genitori, erano hippy e dunque non potevo buttarmi su alcool e droghe perché lo avevano già fatto loro, così sono andata in chiesa! I miei non lo capivano, la sera a cena mio padre diceva sempre «dove ho sbagliato?». Era divertente. Comunque per cinque anni ho frequentato la chiesa avventista e ho avuto modo di cantare tutto quel grande repertorio. Oggi pratico il buddismo e credo in tutte le religioni e in nessuna, ma adoro la musica gospel, la sensazione, l’emozione che trasmette, che non ha niente a che vedere con la religione, un ateo può benissimo apprezzare il gospel, perché parla all’essenza dell’essere umano. Pensiamo a Mahalia Jackson, Sister Rosetta Tharpe o gli Staple Singers, loro soprattutto li ascoltavo moltissimo, Mahalia invece l’ascoltava mia nonna. Due anni fa ho scritto una canzone con Keb’ Mo’, si chiama Clap Your Hands And Moan, ha un feeling gospel, non religioso, le parole dicono “when you’re trying to call heaven but the devil’s on the phone, clap your hands and moan”. Perché nel Sud si usa molto il ‘moaning’, che ha decine di significati diversi, mia nonna esprimeva tutto con un ‘mmm’, senza bisogno di parlare. E dicevano che il diavolo non ti sente se non parli, perciò se ti senti giù e hai bisogno di conforto, beh “clap your hands and moan”, come dice la nostra canzone.
Stai lavorando ad un nuovo disco? Time risale ormai a quattro anni fa.
Mia madre, che è anche la mia manager, mi continua a dire che devo incidere un nuovo album, io sono abbastanza testarda e ho aspettato. Gli altri tre dischi li ho realizzati perché dovevo farli, ma ora ho cinquantadue anni e voglio fare quello come mi sento, non quello che altri pensano debba fare. Ho ascoltato molto, ho ascoltato me stessa, le mie figlie, la mia band, la mia vita e quello che sto scrivendo ora riflette tutte le voci che ho in testa. Leggo degli omicidi che stanno avvenendo negli Stati Uniti o la situazione in Europa e sono due situazioni altrettanto tragiche, mettono le persone le une contro le altre, c’è propaganda negativa, si cerca di separare le persone invece di unirle. Non dobbiamo stare a questo gioco. Queste sono le voci che sento, come in quella canzone di MeShell Ndegeocello in cui canta I Hear Voices, Voices Is What I Hear, mi sento vicina a tutto questo.
(Intervista realizzata a Legnano il 7 agosto 2016)
Matteo Bossi e Silvano Brambilla, fonte Il Blues n. 138, 2017