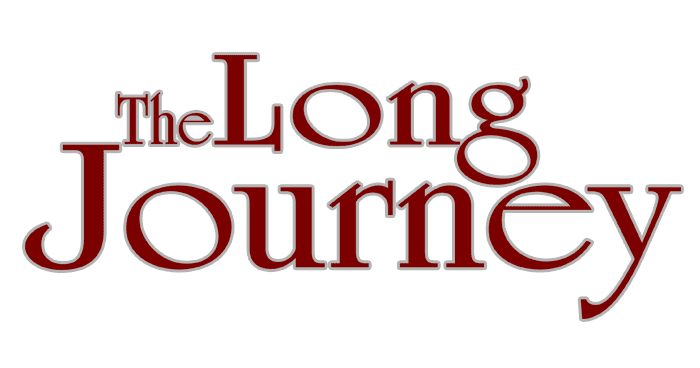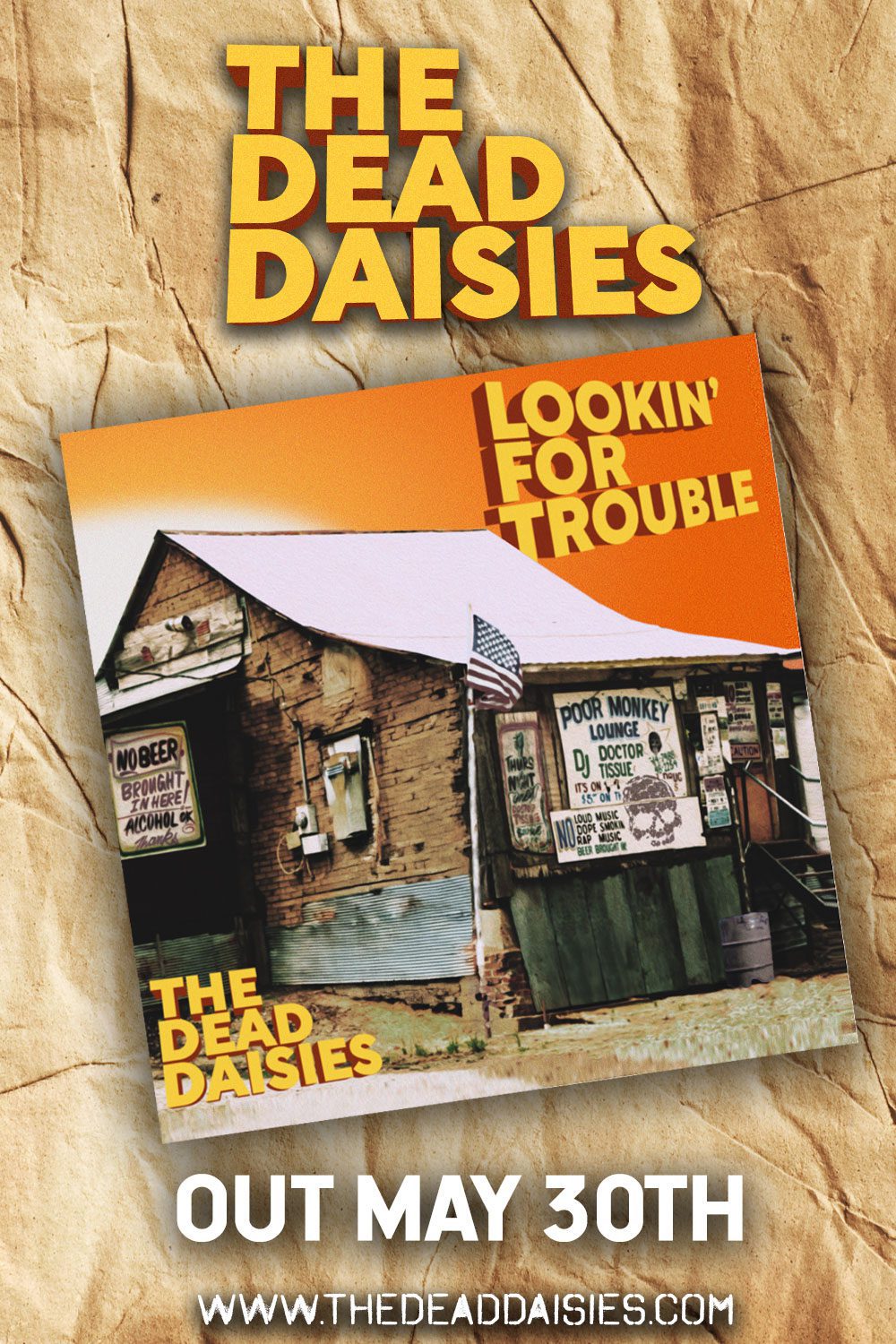Il ‘guitar hero’ non è una specie in via d’estinzione. Anzi, non sembrerebbe, ma le ultime annate sono stati stagioni molto fortunate per le chitarre. Solo, non si vede all’orizzonte l’outsider che arriva dai bar, dalle notti passate a suonare con i fantasmi del blues, quello che la Stratocaster se la porta anche a letto.
Il mondo si è riempito di scuole e di maestri, ed è giusto così che insegnare, così come imparare, è sempre un’arte difficile, ma manca sempre qualcosa. Quello che aveva Stevie Ray Vaughan, che faceva sentire, e non solo con la chitarra. Nel mondo degli autodidatti, dove il limite della formazione viene superato con le uniche risorse possibili, l’entusiasmo, la passione, le emozioni più epidermiche, SRV non ha inventato niente, anzi, ha preso pezzi di Jimi Hendrix, di T-Bone Walker, di Freddie King fino a jazzisti come Kenny Burrell e Wes Montgomery e li ha assemblati, con premura, gusto, attenzione al dettaglio, e comunque senza aggiungere niente di nuovo.
Stevie Ray Vaughan ha fatto tutto con la forza della sua chitarra, tanto da colpire l’attenzione di John Hammond, senior, (uno che, da Charlie Christian in poi, i chitarristi li ha visti tutti). Ha pagato un prezzo salato in termini di alcol e droga (In Step è stato il suo primo disco da sobrio, e purtroppo anche l’ultimo capitolo della sua storia), ma ha lasciato un segno indelebile. SRV ha portato a compimento l’arte del bricolage, prendendo e imparando il meglio, aggiungendoci una tecnica grezza, eppure efficace. Non è stato il primo neanche in questo.
Bruce Springsteen, che ha attinto a titoli, canzoni, stili, copertine altrui (Chuck Berry il più saccheggiato), nella canzone d’autore e nel rock’n’roll si è inventato un ruolo particolarmente emotivo, concedendosi con una generosità che ha ben pochi termini di paragone. In modo diverso, Bob Marley, ha raffinato le sonorità caraibiche e americane, miscelandole con una carica umana, spirituale e politica cristallina, ancora oggi. Entrambi prelevano dagli stessi linguaggi del blues e del rhythm and blues in comune con SRV che ha sempre reso nota la sua ammirazione per Hank Ballard e Willie Dixon, Buddy Guy, Howlin’ Wolf, Freddie King, Albert Collins, Guitar Slim, B.B. King e Lonnie Mack, tutti studiati e riproposti nei suoi dischi o dal vivo. Più di tutti, Albert King. Basta vederlo suonare In Session... dove, con molta umiltà e altrettanta ammirazione, si presta al suo servizio con lo scrupoloso rispetto dovuto al maestro. Va detto che l’attenzione è reciproca perché, come notava Samuel Charters a proposito di In Session…, «era evidente fin dai primi ritornelli che stavano suonando uno per l’altro». SRV non ha mai nascosto nulla, perché è molto più elegante citare che copiare (come hanno fatto poi molti dei suoi epigoni) e, anzi, si è solo posto come l’ultimo anello di una catena che risale fino a Muddy Waters, compreso nell’elenco. Non passerà alla storia come un innovatore, un musicista visionario, anche se il talento rimane emozionante, ma SRV aveva qualcosa che altri non avevano. Quella convinzione che l’ha portato a sfidare i suoi tempi. Ricordiamoci che SRV ha imposto con la sua forza, con il suo suono, anche ingombrante, volendo, un modello, per non dire un gusto che pareva scomparso.
Lo sfortunato Jeff Healey, Jonny Lang, Eric Johnson e via via fino a Joe Bonamassa si sarebbero accodati, ma all’alba del 1983, ovvero di Texas Flood, la chitarra e tutti i nomi di cui sopra erano diventati merce rara. Il blues ancora meno: salvo Robert Cray, con tutte le precauzioni del caso (bravo, elegante, raffinato, ma anche un po’ troppo patinato), la sua rappresentazione all’epoca era quella di una riserva musicale, ben confinata, e niente di più. E’ vero che SRV era esagerato, nelle misure delle corde, nei volumi, nel fraseggio torrenziale. Questo vale per tanti chitarristi, tutti (tanti) bravissimi e virtuosi, chi più, chi meno, suoi debitori, ma lui ci ha messo tonnellate di grinta ed energia per tirare fuori quei nomi e con quei nomi pure se stesso dal recinto. Questo è un lavoro che si può fare solo con la forza, che è anche quella di misurarsi con il pop, ai massimi livelli. Un compromesso? Può essere, ma è pur sempre un biglietto di andata e ritorno. Un conto è suonare il blues in un club o per gli iniziati, gli studiosi e gli appassionati. Un conto è portarlo ovunque, sfidando condizioni e situazioni che con il blues, o persino con la chitarra, non c’entrano un granché, confrontandosi con dimensioni inaspettate. Stevie Ray Vaughan, come raccontano tutte le sue biografie, è uno che ha sfidato il pubblico di Montreux e della televisione, che ha incantato Mick Jagger (e ce ne vuole, in fatto di chitarristi se ne intende, visto con chi convive da mezzo secolo ormai) per finire, in una delle sue ultime registrazioni, con Under The Red Sky di Bob Dylan (in compagnia del fratello Jimmie), un altro che per anni al momento di incidere prendeva soltanto il meglio dei musicisti disponibili e li chiudeva in uno studio di registrazione. Sempre mantenendo ben definiti i contorni della propria identità. Il suo tocco si distingue ogni volta, persino nella lussuosa produzione di Let’s Dance di David Bowie, dove il suono della sua chitarra, compresso tra mille effetti nella produzione ‘funky but chic’ di Nile Rodgers si distingueva comunque in modo chiarissimo, come se fosse in rilievo rispetto agli altri strumenti.
Il marchio di fabbrica rimbalzava dai solchi del suo esordio, un disco davvero capace di scuotere le pareti e di incendiare una casa. Texas Flood è stato una sorpresa e rimane ancora oggi un classico, e non tanto perché annunciava chissà quale novità, ma perché esprimeva tutta la personalità di un musicista. Secondo l’analisi di Ashley Kahn la grammatica di SRV è tutta in Texas Flood perché «più di ogni altro suo album, è la storia di Stevie Ray. L’album resta il più vicino alle sue personali radici, una fertile miscela texana di profondo blues, rhythm and blues e rock’n’roll dei ragazzi bianchi. Echeggia i suoi primi trionfi come chitarrista e serve a definire la linea d’arrivo di dieci anni passati a razzolare nei club, cominciati nel 1973 quando un ragazzo di diciotto anni di Dallas lasciò casa sua per approdare alla scena musicale di Austin». Il riassunto è impeccabile. Masticando per anni (spesso a fianco di Lou Ann Barton, cantante abituata alle torbide atmosfere delle ‘after hours’) la materia prima, SRV si è presentato all’appuntamento con un modello già definito. Uno stile ingozzato di istintività e coraggio. Sono elementi che non arrivano né con l’esercizio né con lo studio e nemmeno sono innati. Ci vuole dedizione totale, tanto che SRV è arrivato persino a dare il nome della (prima) moglie, Lenny, a una delle sue Stratocaster preferite. E’ stato così fino all’ultimo, anche se ha cercato di rinnovarsi e di rendere sempre più personale il suo sound.
Una delle visioni più coerenti è stata quella di Mikail Gilmore che ha scritto a proposito dell’evoluzione di SRV: «Si era mosso verso uno stile chitarristico più propulsivo, in parte derivato dal beat con gli accenti rock’n’roll e in parte dal funk mutuato attraverso il soul, con il quale la sua solista tagliente assimilava entrambi e spingeva le canzoni attraverso le parti ritmiche». In Step sarebbe stato l’apice di questa progressione, che era già chiara proprio con tutte quelle sfumature, nella sua portentosa versione dal vivo di Superstition di Stevie Wonder. Era l’intuizione giusta e non a caso In Step venderà un milione di copie, ma siamo alla fine della storia, siglata da un drammatico incidente. Dopo SRV, il blues e la chitarra sono tornati di moda, anche tra personaggi indecisi tra il blues e il pop come John Mayer (e nell’indecisione tendono a perdersi). Basta pensare a festival di tutto riguardo come Crossroads sui cui ogni anno di più aleggia la sua ombra e la sua mancanza. Nulla toglie allo spirito del raduno che edizione dopo edizione ha allineato tutti i migliori curriculum chitarristici del pianeta (anche troppi), ma rimane sempre il dubbio che manchi qualcosa, anche se è difficile dire perché.
Kenny Wayne Shepherd fin dal suo primo disco (era il 1995 quando uscì Ledbetter Heights) è apparso come uno travolto dal sound di SRV. Anche perché esporre un bambino a distanza ravvicinata a quel tornado alla tenera età di sette anni, prevede una sola conclusione, ma ecco la sua versione: «Stevie Ray Vaughan è stato l’ispirazione totale che mi ha spinto a prendere in mano la chitarra. L’ho sentito suonare per la prima volta quando avevo sette anni a Shreveport, Louisiana. Mio padre era il promoter del concerto, mi ha preso e mi ha messo da una parte del palco e ho visto tutto lo show dalla custodia di un amplificatore. E’ stato monumentale. Credo sia bizzarro pensare che un bambino di sette anni possa avere un’esperienza spirituale, ma mi ha contagiato per il resto della mia vita. Sei mesi più tardi, avevo la mia chitarra. Quello che mi ha davvero catturato era la sua libertà. Era una sensazione che sentivi uscire da lui. Riusciva a suonare con un tale fuoco e un attimo dopo poteva suonare con estrema delicatezza. Aveva l’abilità di raggiungere e afferrare l’attenzione di tutti e di tenerseli nel palmo delle sue mani. Suono a orecchio e sono autodidatta e ho imparato a suonare ascoltando le sue canzoni in continuazione. Ho imparato la storia del blues attraverso SRV». Non è stato molto diverso nemmeno per Gary Clark Jr., il più convincente tra i suoi discepoli recenti (il suo Live ne è la conferma) che ha detto: «Stevie (Ray Vaughan) è una delle ragioni per cui ho voluto una Stratocaster. Il suo tono, che non sono mai stato capace di ottenere nello stesso modo, era così grande e spesso e brillante nello stesso tempo. Se ascolti i suoi dischi e lo riguardi dal vivo, puoi dire soltanto che lui stava dando tutto. La sua passione era superlativa». La storia del blues, e un entusiasmo che non finiva più, ecco perché.
Marco Denti, fonte Il Blues n. 129, 2014