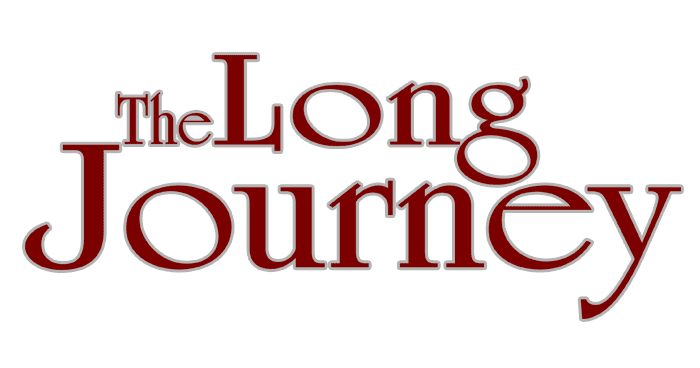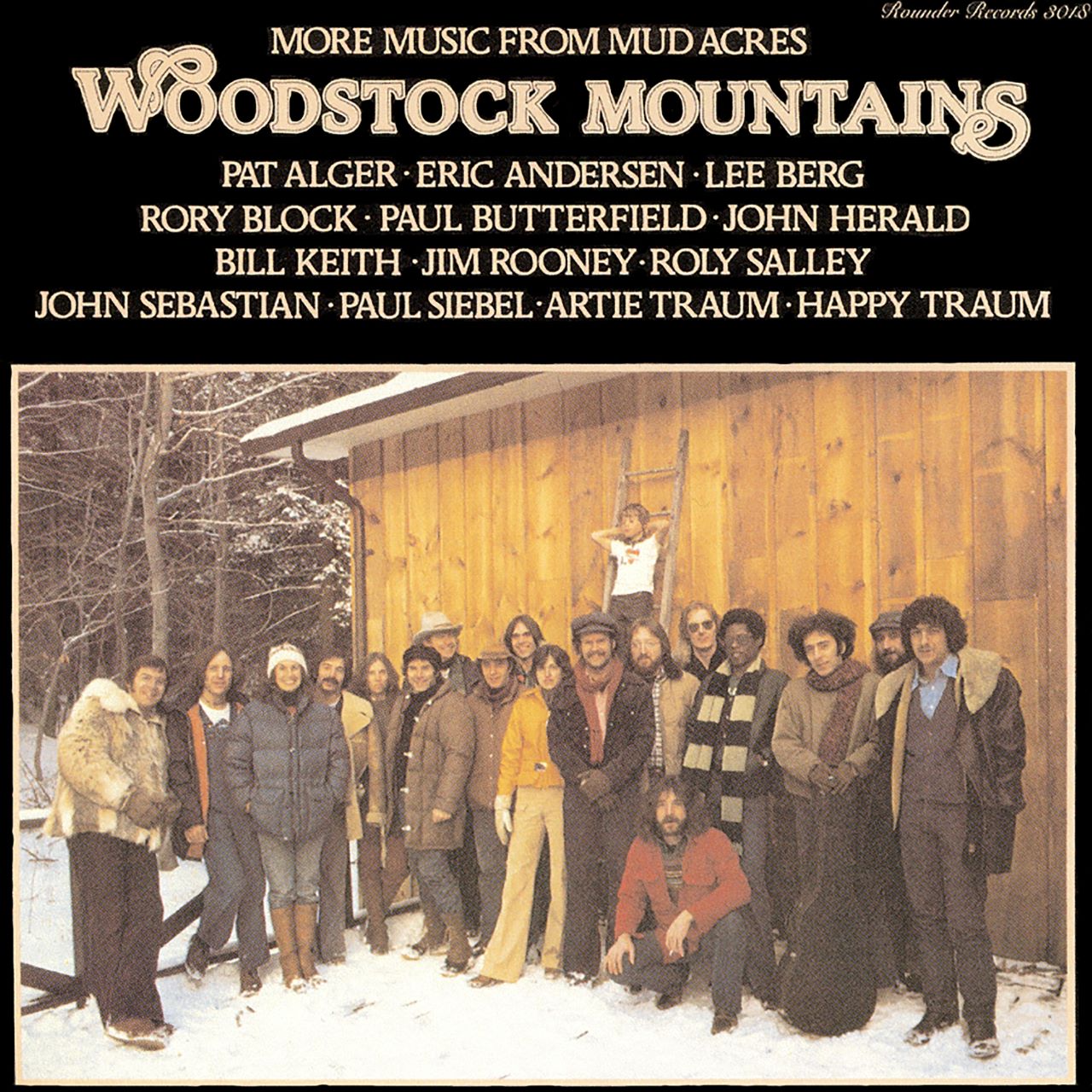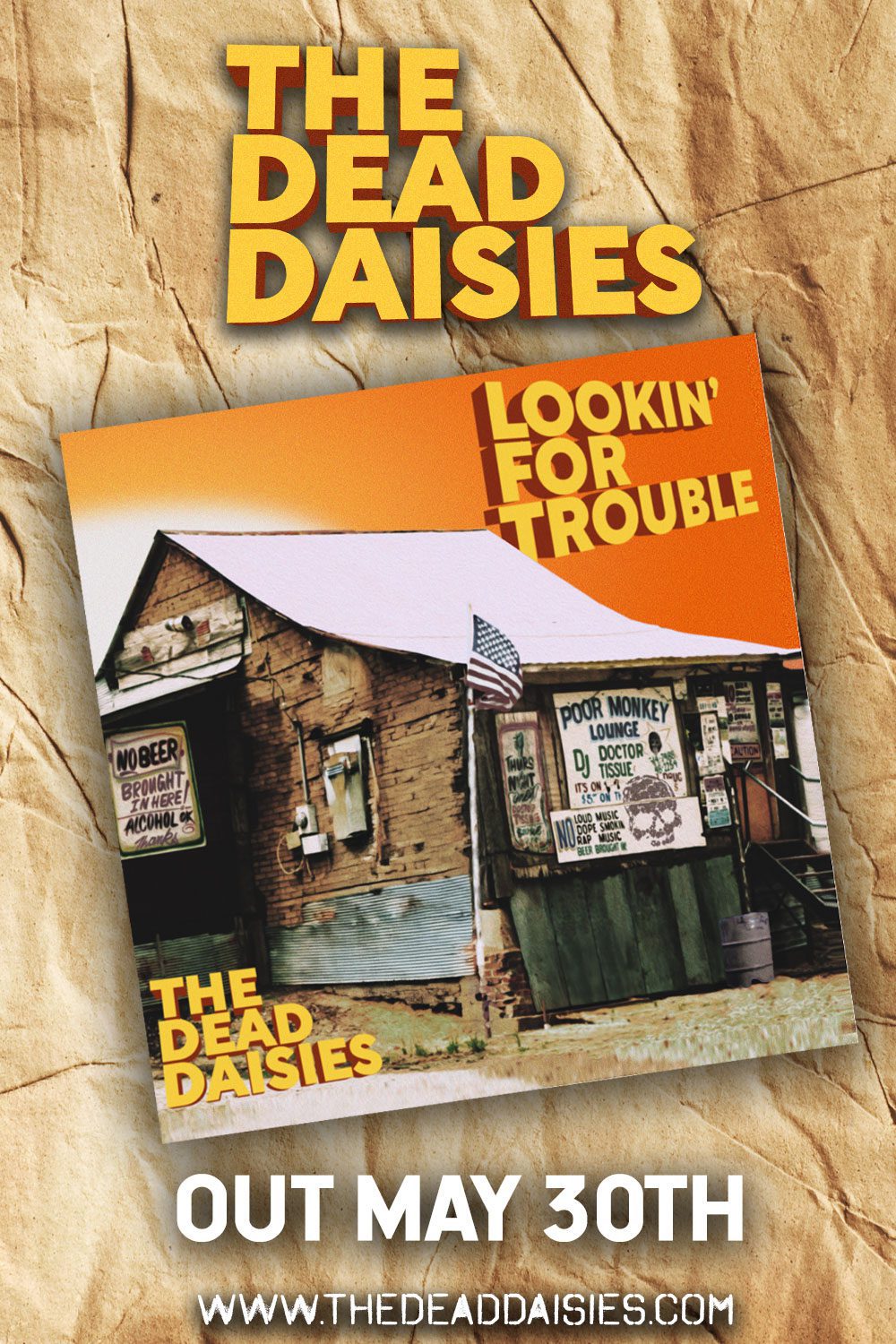Ogni tanto capita che artisti affermati smettano per un attimo di fare la musica che ha dato loro il successo e si permettano il lusso di accontentare non tanto il pubblico che li segue quanto… se stessi. E’ una specie di ritorno alle radici, utile per abbeverarsi alla fonte della propria storia, per acquistare nuova ispirazione. L’hanno fatto in molti: Nancy Griffith con Other Voices/Other Rooms, un disco straordinario, imperdibile, che deve il suo fascino al rispetto della cantante per le sue primigenie influenze; oppure Townes VanZandt con Roadsongs, in cui riscopre i motivi che l’hanno attirato nel mondo della musica. E sono buoni motivi.
E’ significativo che i due songwriters citati a mò d’esempio, pur avendo una riserva inesauribile di composizioni originali, abbiano voluto mettere su CD canzoni che non sono loro ma che non per questo non appartengono alla loro storia (ci viene in mente perfino John Lennon che registrò un album solo farcito di rock dei fifties, Rock & Roll; se quello non è amore…) anzi ne sono il fondamento, la stessa cosa è accaduta, in misura perfino maggiore, con la serie di albums detta di Mud Acres, sottotitolo ‘Music Among Friends’.
Nel lontano gennaio del 1972, infatti un gruppo ben collaudato di amici, musicisti di professione, con tanto di famiglie e corredo, si ritrovò dalle parti di Woodstock (da cui il nome Woodstock Mt. Revue, che verrà in seguito usato) per passare un week-end in compagnia, suonando vecchi pezzi che li univano in un comune retaggio, quelli che si ripescano dalla memoria, fra amici, per divertimento e non per avere successo commerciale. Musica che ‘si sente’, che viene dalle zone più profonde dell’anima. Musica rigorosamente acustica (gli unplugged dovevano ancora diventare moda), non necessariamente solo folk, ma anche blues, bluegrass e d’autore. Comunque assolutamente di altissima qualità.
I microfoni dello studio, ricavato in una fattoria, restano aperti per catturare tutto quanto accade in quell’atmosfera rilassata e priva di condizionamenti. Anatre del gioco sono i fratelli Traum, Happy e Artie, che in seguito a questi episodi avranno un periodo di notorietà mai sperimentato prima. Ma ci sono anche John Herald, ex Greenbriar Boys, Jim Rooney, oggi producer di grido a Nashville (ha prodotto lui Nancy Griffith), Bill Keith, inventore di un rivoluzionario modo di suonare il banjo, il ‘melodic style’, Maria Muldaur, vocalist del gruppo washboard Jim Kweskin Jug Band, e numerosi altri. Tutti più o meno provenienti dall’area di New York e gravitanti attorno ai luoghi di culto del folk e del blues, il Greenwich Village, il Club 47 di Cambridge’ dove prima o poi sono passati tutti (un pensiero al menestrello di Duluth, che solo un paio di anni fa è tornato con due bellissimi albums ad accompagnarsi con la sola chitarra, rifacendo vecchi standards folk; non è mai troppo tardi…).
E la musica? Superlativa. I due fratelli Traum danno il meglio in una whaling ballad di Ewan MacColl, ripresa anche sull’album appena pubblicato da David Grisman con Jerry Garcia, Off To Sea Once More (ascoltate la cupa Jolly Roger, con rumore di onde e di tavole di ponte che scricchiolano, di Roger McGuinn sull’album Cardiff Rose; non le somiglia in modo sospetto?). I due si superano anche nella Leadbelliana Titanio e nella Guthriana (scusate questa aggettivazione: è per la sintesi…) Jackhammer Blues, che svettano come tributo ad una intera generazione di giganti della musica popolare che non verranno mai dimenticati.
Maria Muldaur e Lee Berg uniscono poi in una stretta armonia le loro voci cristalline in una stupenda resa di Oh, The Rain di Blind Willie Johnson, tanto per restare in tema di irraggiungibili maestri. Infine due brani strumentali, particolari e gradevolissimi, che mettono in evidenza i banjos, suonati con stili diversissimi, di Bill Keith e Artie Traum.
L’album contiene altre gemme che per motivi di spazio non citiamo e che vengono dall’eredità degli Weavers, di Gus Cannon, di Flatt & Scruggs, di Gene Autry, dei Delmore Brothers, tanto per dare un’idea dello spettro coperto dall’ensemble, improvvisato si, ma non sprovveduto. Insomma, un capolavoro di assoluta bellezza e un repertorio di capisaldi della musica popolare eseguiti magistralmente. Tanto che la Rounder, soddisfatta dei risultati (in pratica: poca spesa, molti incassi) commissionò il bis che si concretizzò cinque anni dopo, probabilmente per la difficoltà di conciliare gli impegni di tutti: More Music From Mud Acres. Questa volta i mezzi a disposizione furono maggiori e la qualità della registrazione ne guadagnò moltissimo. La stessa copertina è meno spartana del primo episodio (foto a colori della combriccola nella neve, su fronte e retro), anzi si apre addirittura a libro per mostrare le foto-tessere dei partecipanti, assai più numerosi, alla reunion. Si aggiungono al gruppo il bravissimo Paul Siebel, che si esibisce in una versione da brivido di Weary Blues di Hank Williams, Eric Andersen, che non è da meno con Waiting For A Train del ‘singing brakeman’ Jimmie Rodgers, John Sebastian (che ricorderete anche nel raduno rock di Woodstock) che si prodiga in un duetto all’armonica nientemeno che con il mitico Paul Butterfiled in Amazing Grace.
Due sole torride armoniche: da sballo. Credetemi!
John canta anche la triste Morning Blues. John Herald, un po’ in ombra nel primo disco, qui esplode con la bella Bluegrass Boy, ed altrettanto fa Jim Roney in Sleep With One Eye Open, dal repertorio di Lester Flatt. Maria Muldaur se n’è andata ma al suo posto c’è l’ottima Rory Block che con Lee Berg offre due spettacolari performances: Long Journey e Whole World ‘Round, forse il lato più raffinato e sofisticato del disco. Eccellenti.
Bill Keith si lancia in una frizzante Sally Ann da manuale e il suo banjo duetta con la sola chitarra del sodale Jim Rooney nella irlandeseggiante My Love Is But A Lassie Yet. In molti brani, segnalo Barbed Wire, dal testo profondo, fanno la loro comparsa due nuovi arrivati che diventeranno però stabili presenze nei futuri episodi: Pat Alger e Roly Salley. Così con un bilancio anche più positivo, si chiude il secondo capitolo degli ‘Ettari fangosi’.
E’ in arrivo il terzo round, ma nulla dura all’infinito e si cominciano a vedere delle crepe nella freschezza dell’operazione. In Pretty Lucky, infine, il sogno si spezza. Rimane la Woodstock Mt. Revue ma non si nomina più Mud Acres. il disco è modesto e la musica di routine. C’è il solito classico di Woody Guthrie, Pretty Boy Floyd, affogato in una cascata di note della steel guitar, ed è praticamente l’unico pezzo che lega col passato. Ma c’è anche un brano di David Nitchen che c’entra come il pollo in una grigliata di pesce. Jim Rooney ripropone Interest On The Loan (che si può ritrovare, con diverso personale, anche sul solo Ready For The Times To Get Better, su etichetta Appaloosa) e all’aumento di nuovi arrivi (molti sinceramente mai sentiti) corrisponde un sound confuso, a cavallo tra pop, country e folk aggiornato. Insomma un po’ un risotto cotto senza guardare l’orologio.
Nel 1981 Artie Traum produce Back To Mud Acres, quasi a voler stabilire un legame più stretto con le prime prove ma sembra scomparsa quell’atmosfera artigianale, quell’aria di complicità, quel senso di rimpatriata presente in passato anche se in copertina si mostra il gruppo che passeggia accanto ad un auto scassata (metafora della… Revue?). Il sapore è più commerciale e up to date, quasi a dimostrare che sono validi anche gli autori contemporanei, non solo i miti della prima metà del secolo. Sarà, ma il risultato è inferiore allo standard solito. Del vecchio mucchio restano i fratelli Traum, Bill Keith e Jim Roney, da sempre affiatato duo e John Herald; ci sono poi Alger e Salley, qualche sideman e un’apparizione della dobroista Cindy Cashdollar.
Il meglio lo troviamo nella commossa Tennessee Blues di Jim Roney (Jim pesca dallo stesso disco citato e non si sforza nemmeno di fare qualcosa di nuovo!) che esegue anche un’ottima Why Don’t You Love Me di Hank Williams, nello spirito, lui sì, che ha riempito i dischi precedenti.
Happy Traum si spende in una alquanto manieristica Carolina In My Mind di James Taylor e John Herald presenta in chiave bluegrass Backdoor Blues di Washboard Sam. Panhandle Rag dello steel guitarist di Bob Wills, Leon McAuliffe, nelle mani di Bill Keith si salva ma non brilla. John Herald è sempre professionale ed ha la solita bella voce ma non svetta. Resta poco altro, soprattutto dovuto ai nuovi venuti che probabilmente non hanno mai respirato l’aria del primo Woodstock e fanno quello che possono.
Si chiude così, un po’ malinconicamente, un capitolo coraggioso e anticonformista, che ha aperto una strada da molti imitata ma non sempre eguagliata. Con gli anni ’80, il gusto di fare musica per proprio divertimento è scemato, nuovi linguaggi hanno preso il sopravvento e la musica acustica è stata confinata in settori marginali del mercato. In quegli acri di fango resta però indelebile l’impronta fossile di un periodo in cui contenuti e forma sono sposati in modo sublime, in cui l’eredità dei grandi del passato è stata riletta, rivisitata e filtrata con moderna sensibilità ma senza concessioni al business che ne falsassero la purezza.
E’ questa la grandezza della musica popolare e di chi la sa riproporre, rivitalizzandola senza snaturarla: la capacità di trattare con parole semplici i grandi eterni problemi, di comunicare, magari con un lessico nuovo, temi antichi e sempre attuali, altrimenti ignaro e ingenuo, compie il capolavoro. I ragazzi della Woodstock Mt. Revue, forse senza neppure rendersene ben conto, per un po’ ci sono riusciti.
Maurizio Angelo, fonte Out Of Time n. 23, 1997