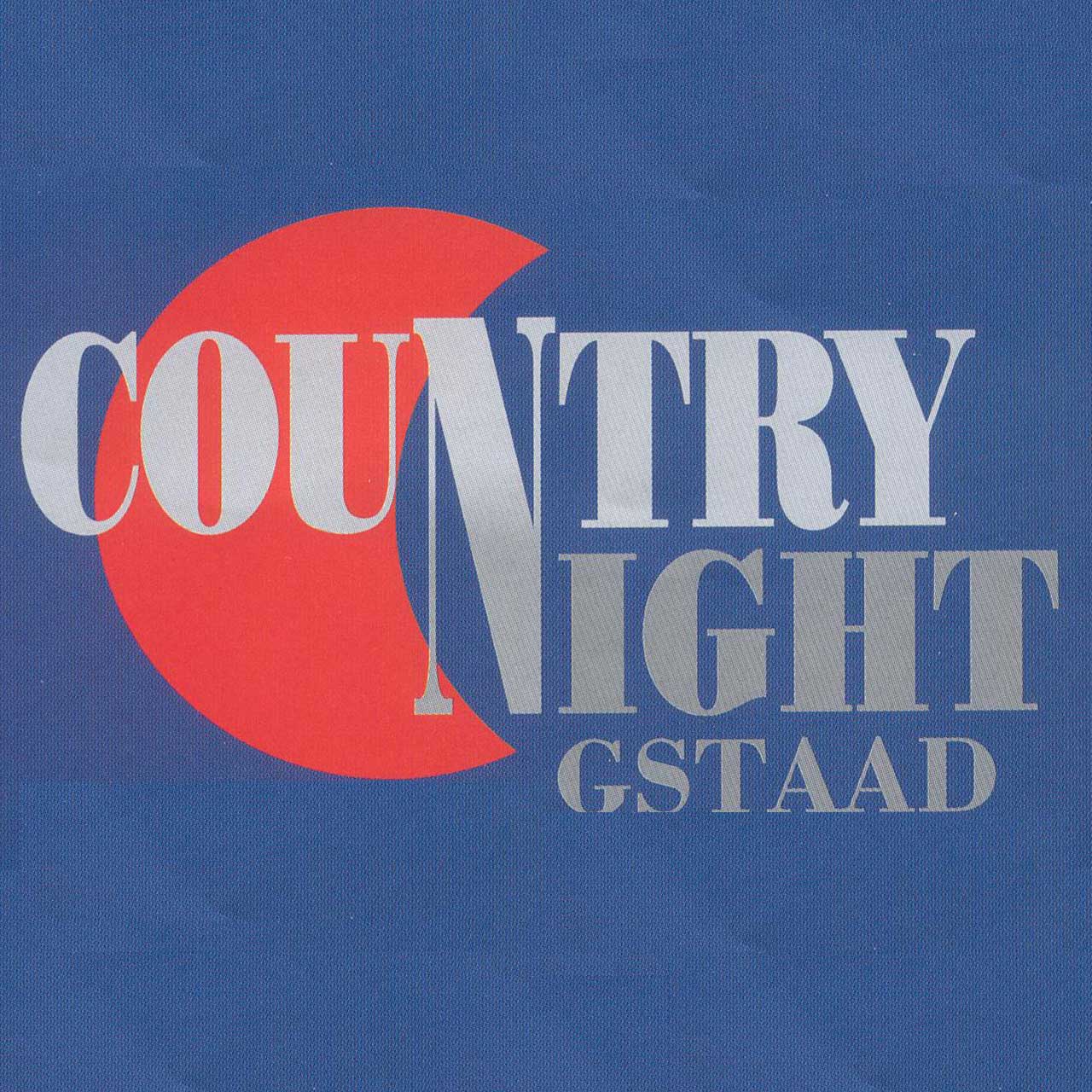Mai come nell’edizione di quest’anno, la sedicesima, la Country Night è stata più combattuta tra tradizione e mainstream, intendendo per tale la tendenza di certi ambienti della discografia di Music City ad ‘andare pop’ per conquistare nuove fasce di mercato. Il programma annunciato dichiarava apertamente una scelta artistica sbilanciata rispetto al solito, in quella direzione. Non sappiamo se la scelta sia stata condizionata da ragioni economiche, da casualità o da che altro. Sta di fatto che la diffidenza sul nome della headliner LeAnn Rimes ha tenuto lontano buona parte del pubblico italiano di affezionati, con le sconcertanti eccezioni di cui diremo dopo. Il doppio sold out ha però rivelato che ‘andare pop’ evidentemente paga sempre, almeno col pubblico svizzero, ed ha dato ragione agli organizzatori. I quali, un po’ sadicamente da una parte, ma anche, perché no, con buon gusto e lungimiranza, hanno voluto calcare la mano sottostando ad una probabile richiesta della giovane diva di ospitare, in esclusiva nello show del Venerdì, la pop star irlandese Ronan Keating per un avvincente, ottimo duetto, nel suo genere.
Per noi, sinceramente, questa edizione è stata la meno appagante in assoluto. Specie se confrontata con quella dell’anno scorso (ricordate? Terri Clark, Tracy Lawrence, Mark Chesnutt, Joe Diffie…) che ci aveva fatto toccare la cima della Jungfrau senza bisogno di funivia.
E tuttavia, questa ha avuto i suoi apprezzabili momenti. Si veda la Lonesome River Band, storica bluegrass band, un team di virtuosi che nel corso dei vent’anni di esistenza artistica ha contato tra i suoi membri parecchi nomi entrati progressivamente nel gotha dell’erbablu e che ora dispiega Mike Hartgrove (fiddle), Jeff Parker (mandolino), Sammy Shelor (banjo), Brandon Rickman (chitarra), JohnWade (basso acustico).
Per chi ama il bluegrass tradizionale, il loro concerto è stata una delizia: strumenti rigorosamente acustici, microfoni ambientali, quattro voci che cantano in perfetto high lonesome sound e che eseguono le parti soliste utilizzando come da manuale i contrasti di tono, le caratteristiche pennellate di alti e bassi, per sostenere il ritmo; e poi virtuosismi strumentali alternati, rolls di banjo sdoppiati, triplicati nei breaks per la gioia delle nostre orecchie; una scaletta tipica nel prevedere il giusto alternarsi di slow, mid-tempo e ultra-veloci, cantati e strumentali dal loro repertorio attuale (ultimo CD, Window Of Time), dai classici (Virginia Reel, Sittin’ On Top Of The World), o presi in prestito (Mary Ann da Jimmy Martin, I’ll Take The Blame da Ricky Skaggs). Su tutte, una strepitosa Georgia Mail con breaks straordinari di tutti gli strumenti ed una velocissima Rolling On Spencer.
Cosa dire di Jamie O’Neal che non ne sminuisca troppo le doti? Beh, come in tanti casi analoghi, che ha una gran bella voce ed una gradevole presenza ma che non ha un repertorio che la valorizzi ed uno stile personale riconoscibile (scrive lei stessa diverse delle sue canzoni). Eppure è riuscita a non convincere persino alcuni ben noti fans del country-pop. Pensate che i suoi pezzi migliori sono i due hits When I Think About Angels e There Is No Arizona. Tutto il resto è cronaca spiccia per un concerto abbastanza breve: un paio di anteprime, una sua canzone ripresa da Martina McBride (How Far), due banalissime canzoni dedicate genericamente alle ragazze (Trying To Find A Lady, Girlfriends) annunciate come se fossero l’invenzione del secolo, una citazione dal repertorio r&b di Linda Ronstadt (You’re No Good), due soft country con breaks strumentali semi-acustici altrettanto soft (In My Life e Pick Guitar) e il bis Every Little Thing con un timido banjo che affiora in superficie. Ed è tutto. Che influisca al momento il suo essere nuova mamma o il suo carattere apparentemente introverso non è dato a noi sapere. Ma per quanto ben dotata, noi così lontani dai giochi di Music City non vediamo per lei un futuro rilevante.
Il divertimento arriva con Michael Peterson, un artista che sta indicativamente tra David Ball e Ricky Van Shelton, star mancata per poco nei tardi anni ‘90 con due hits come From Here To Eternity e When The Bartender Cries, per discordie discografiche e improvviso matrimonio destabilizzante per la carriera. Il suo è un new honky tonk spiritoso, quello che gioca con le parole (One Of These Good Bad Habits, Love’s Great (When You’re Not In It), con i paradossi (Drink, Swear, Steal, Lie), con le storie quotidiane (Perfect Weekend) ma che sa essere maledettamente romantico quando rifà a suo modo la canzone del millennio When You Say Nothing At All o la sua From Here To Eternity; o intenso quando tocca le corde del cuore con una strepitosa versione di Good Time Charlie’s Got The Blues dello strampalato irlandese Danny O’Keeffe che riuscì a scrivere quel capolavoro country senza neanche essere americano; o commovente ed esilarante allo stesso tempo quando ripropone la sua When The Bartender Cries che fa definitivamente giustizia della figura del barista, fondamentale nella cosmologia honky tonk per la sua funzione di angelo consolatore, ma che in questo caso non lascia scampo alla disperazione perché persino lui ora piange (…Son, You’re in trouble/When the bartender cries…).
Scopriamo con piacere che Peterson ha scritto No More Looking Over My Shoulders, un hit recente per Travis Tritt e che sa perfettamente di cosa si parla in materia di shuffles (Lost In A Shuffle) e di roadhouse rock (Too Good To Be True). Il contorno è un po’ spoglio (basso, chitarra e batteria) ma sufficiente. Molto poggia sulle spalle dell’ottimo chitarrista Jason Jordan che ricama e riempie con licks spericolati tutto quello che sta tra la ritmica e la voce.
Un lungo intervallo per decomprimersi e resettarsi per il prossimo act (gli svizzeri si resettano con birra in media ogni venti minuti) ed ecco la superstar LeAnn Rimes che calca la scena in abbigliamento impressive: minigonna di jeans e giubbottino slacciato su body bianco attillato. Se si aggiungono i capelli sciolti e un portamento estremamente aggraziato, potrete capire che l’incipit non poteva passare inosservato. Ma aldilà dell’estetica, pur importante, quello che colpisce immediatamente è la voce, a dir poco fenomenale, che lei cura con attenzione e scrupolo (l’abbiamo sentita nel backstage fare i vocalizzi prima del concerto). Con quella voce, si dice, può fare quello che vuole.
E lei lo fa, fin troppo. Perché inizia con alcuni dei suoi primi successi (One Way Ticket, Blue, Big Deal), quelli che ci avevano fatto sperare in un buon decorso new country, poi vira improvvisamente sul country-pop riprendendo Trisha Yearwood (How Do I Live), poi imbocca decisamente la strada del pop (Life Goes On) e presenta i due nuovi singoli Won’t Be Lonely Long e Nothing About Love Makes Sense. La band naturalmente è ottima, solida, con due chitarristi in evidenza che si scambiano i ruoli di ritmica e solista e una steel guitar che non prende il comando ma affoga nel suono complessivo, nell’ unica funzione che le viene attribuita, quella riempitiva. E’ a questo punto che, al venerdì, si fa avanti Ronan Keating per il duetto di cui sopra, bello e studiatamente emotivo, una Last Thing On My Mind che al sabato viene riproposta in versione individuale. Ormai la strada è definita e lo show va avanti su quei binari. Quello che temevamo si compie ed una lunga intro di chitarra spagnola apre su Can’t Fight The Moonlight, tema del film Le Ragazze del Coyote Ugly che vedeva la nostra tra le protagoniste, avviata decisamente al genere dance.
Un altro intermezzo pop (I Do Love You, Right Kind Of Wrong) ci porta alla dichiarazione d’amore per il rock anni ’70, ed in particolare per il suo idolo Janis Joplin di cui ripropone in fedelissima versione Summertime e Me & Bobby McGee, l’unica vera canzone country, insieme a Blue, di tutto il concerto. E’ l’occasione per il primo e unico solo di steel guitar. Ma il gran finale va oltre e ci investe con una robusta versione della già robusta Rock&Roll dei Led Zeppelin, band che abbiamo molto amato, ma in altri tempi.
Lei è una forza della natura, usa la voce a piacimento e non possiamo fare a meno di renderle omaggio. E’ piaciuta a tutti perché non può non suscitare entusiasmo. Ha solo 22 anni e pensiamo che farà una gran carriera ma non compreremo i suoi dischi e probabilmente non andremo più ai suoi concerti.
Di country non ha quasi più niente, neanche la proverbiale propensione a fraternizzare con pubblico e giornalisti: al pomeriggio era fuggita dalla conferenza stampa dalla porta di fondo, ora fugge dal palco mentre Michael Peterson è da più di un’ora al banchetto dei dischi a firmare autografi ed a farsi fotografare. Non si è riposato un attimo ed ora sta per ricominciare a suonare sul palco del Saloon atteso da ore da un gruppone di linedancers prevalentemente italiani che hanno fatto tutta la strada dalla Padania solo per aspettare a gambette frementi lo show dell’Una di notte e finalmente sculettare, felici di aver risparmiato sul biglietto del festival. Li guardiamo girarsi e rigirarsi con gli sguardi persi nel vuoto, ci guardiamo sconsolati e ci allontaniamo nell’oscurità pensando di tenerci stretta questa Country Night con i suoi alti e i suoi bassi perché in Italia, con certo pubblico, non sarà possibile programmare iniziative di qualche rilievo per chissà quanto tempo. A meno di non farle gratuite, con bevande omaggio e con un pedanone al posto dei sedili.
Fabrizio Salmoni, fonte Country Store n. 73, 2004