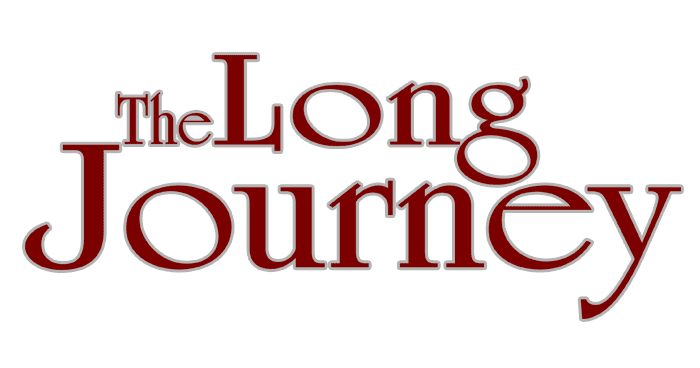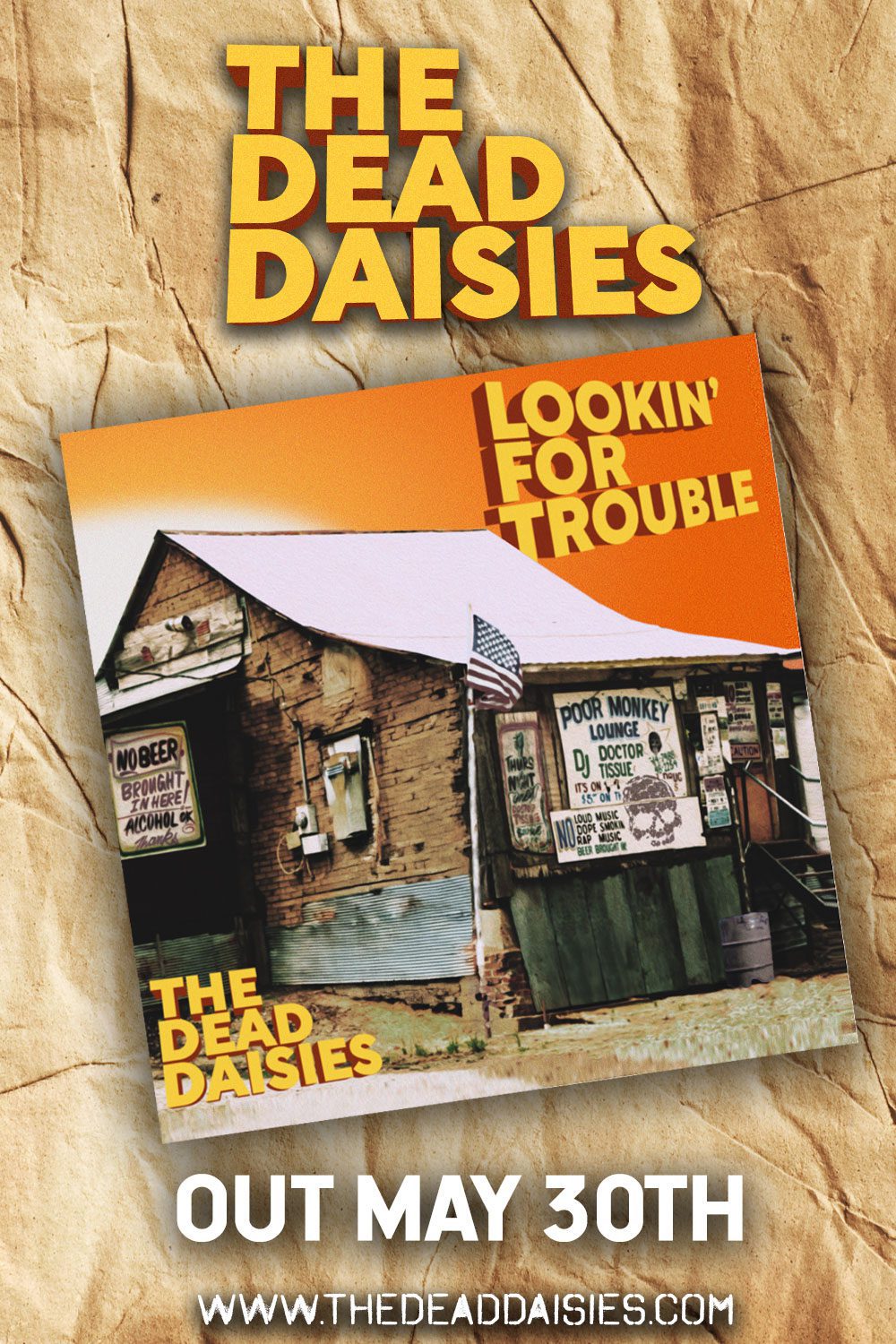Uomo di cultura e sensibilità non comune, Pierre Lacocque parla volentieri di sé, riflettendo un’indole analitica e creativa al tempo stesso. Lo aiuta la chiarezza acquisita, probabilmente, in anni di studi di psicologia. Cominciamo chiedendogli delle condizioni di salute della cantante Inetta Visor, assente dalla formazione del festival di Lucerna. «Pochi giorni prima di partire, Inetta mi ha detto che non sarebbe riuscita a venire; ha subito un intervento chirurgico e non ha recuperato in tempo. Così abbiamo dovuto trovare una sostituta alla svelta; ne ho parlato con Kenny (Smith, batterista della band n.d.a.), lui conosceva Carla (Stinson), l’ha chiamata e lei era disponibile a venire. Ha imparato le nostre canzoni in due giorni e penso che ieri abbia fatto un ottimo lavoro. Ora resterà con noi fino ai primi di dicembre, poi tornerà Inetta appena starà bene. Carla è di Chicago, e sta cercando di farsi strada; personalmente non la conoscevo, ci siamo sentiti al telefono e abbiamo parlato del repertorio, ma a dire il vero ci siamo incontrati solo in aeroporto! Non c’è stato proprio tempo. Di solito mi piace fare qualche prova, ma stavolta mi sono fidato completamente di Kenny. Ed è andata bene, è una ragazza giovane e simpatica, che ha voglia di lavorare».
Come sta tuo fratello Michel?
Sta bene ora, ha avuto un problema di salute, al cuore, ma ha recuperato e si occupa sempre dei Mississippi Heat, della pagina Facebook, firma persino a mio nome ogni tanto. Poi mi chiama e mi dice che c’è questo o quel messaggio per me…
Cosa avevi in mente quando hai messo insieme la band, oltre vent’anni fa?
Volevo avere creatività, la possibilità di mettere in pratica le mie idee musicali, la libertà di seguire la mia strada, di scrivere canzoni. Non essendo un cantante, mi serviva qualcuno che fosse disposto a cantare il mio materiale e che fosse a suo agio nel farlo e non avesse problemi con i testi o con altri aspetti. Con gli anni ho imparato a scrivere per qualcuno, per esempio a farlo da una prospettiva femminile, ovviamente pensando che sarà Inetta a cantare; è una sorta di esercizio che apre un angolo differente sulla storia che voglio raccontare. Ad esempio la canzone Warning Shot, l’ho adattata per lei e poi ne abbiamo discusso insieme; per me la band è come una famiglia ed è importante che siano tutti coinvolti, Inetta o Kenny sono di famiglia, non penso affatto a rimpiazzare Inetta che è con me da tredici o quattordici anni. Sono molto leale con i miei musicisti e ci tengo che le cose siano decise insieme. Poi ci possono essere problemi di salute, famiglia, soldi, di ego, capisco che ognuno abbia le proprie ambizioni, anch’io ho le mie. Per me avere i Mississippi Heat è motivo di grande soddisfazione, è l’occasione di essere creativo, di esplorare cose diverse con musicisti eccezionali, e la chiave di tutto è l’ascolto reciproco. Spero di continuare il più possibile con la formazione attuale.
All’inizio eravate tu Jon McDonald e Robert Covington?
Esatto. C’era anche Bob Stroger, eravamo noi quattro. Covington voleva cantare ed era molto bravo in effetti, stava invecchiando ed era anche un po’ stanco di suonare la batteria. Morì, in effetti, qualche anno dopo, aveva avuto un trapianto di rene, aveva un bel problema col bere e purtroppo continuò a farlo anche dopo il trapianto, senza dare retta ai dottori. Comunque siccome Covington non voleva suonare la batteria, prendemmo Bob Carter, un bravo musicista e una bella persona, che purtroppo è morto non tanto tempo fa. Con Covington eravamo amici, scrivevamo insieme e abbiamo inciso il primo album, Straight From The Heart, però ad un certo punto mi disse: «Sai Pierre, ho un ingaggio fisso al Kingston Mines e mi pagano bene, non posso mollarlo». Così ho dovuto rimpiazzarlo, ma siamo rimasti amici e ripeto non ci ha lasciato per contrasti o perché non gli piacesse la band, tanto è vero che qualche volta è venuto in tour con noi, quando era in vacanza. Da allora, sarà destino o no, ma ho sempre avuto cantanti donne, prima Deitra (Farr n.d.a.), per tre o quattro anni, questo mi ha dato una nuova angolatura nello scrivere. Mi trovavo molto bene con lei, siamo ancora molto amici.
Oltretutto il disco che realizzasti con lei al canto, Learned The Hard Way, è uno dei vostri dischi migliori.
Me lo dicono in tanti, era un disco molto puro, tradizionale. Dopo un po’ Deitra mi chiamò dicendo che aveva altre offerte…come dicevo prima le ragioni per gli avvicendamenti sono state di soldi, famiglia, ego o salute. Diversi musicisti hanno avuto problemi di salute, anche Steve Howard, ha avuto un grave problema al sistema immunitario, è quasi morto al ritorno da un tour in Europa e dovette essere ricoverato per parecchio a New York. Mio fratello Michel rimase con lui in ospedale. Spurling Banks un altro bassista che abbiamo avuto, gran persona, è morto qualche anno fa, sono legato ai miei musicisti, non è una questione di contratti. Con Kenny Smith ad esempio siamo molto amici e so benissimo che è uno dei batteristi più richiesti in circolazione, perciò ogni tanto gli dico «Kenny non ti preoccupare se non puoi, trovo un sostituto» e lui ogni volta mi risponde, «ma no Pierre, non dire così…». Per questo è ancora con me, per amicizia, anche se ogni tanto ho bisogno di un sostituto, anche se nell’ultimo disco in qualche pezzo c’è Andrew Thomas che a sua volta è piuttosto richiesto, perciò ci sono concerti in cui devo fare appello ad un terzo batterista. In ogni caso penso che i Mississippi Heat abbiano il loro suono, facciamo attenzione a come sono presentate le canzoni nel loro insieme.
Anche i chitarristi con i quali hai collaborato hanno determinate caratteristiche.
Si, ma dipende anche da chi ho a disposizione, di conseguenza il tipo di repertorio. All’epoca di Learned The Hard Way avevo James Wheeler, Billy Flynn, oltra a Deitra, Stroger e Kirk, sapevo cosa potevano dare. Ora però se avessi quello stesso gruppo non so se sceglierei di suonare alcune canzoni che abbiamo inciso su Warning Shot, che è forse il mio preferito, anche se, come si suol dire, sono tutti miei bambini. Mi piace molto anche Footprints On The Ceiling. Giles Corey è spesso in tour con noi e Michael Dotson è con noi a tempo pieno da due anni. Michael ha famiglia in Grecia, ma lì non ci sono molte opportunità di suonare, perciò è con noi circa dieci mesi all’anno, poi torna in Grecia nei mesi invernali, gennaio, febbraio.
Come nasce il nome Mississippi Heat?
Ci sono diverse ragioni. In primo luogo l’armonica è una parte importante della band e come sapete è detta anche Mississippi Saxophone. Inoltre il mio primo amore musicale è il Chicago Blues degli anni Cinquanta, che è ovviamente musica amplificata originaria del Mississippi Delta, perciò volevamo omaggiare nel nome quella tradizione, una forma di rispetto. La parola ‘Heat’ la dobbiamo a mio figlio Jonathan, che all’epoca aveva nove anni, stavamo cercando un nome per la band e la parola Mississippi veniva fuori spesso quando ne parlavo con Stroger, Jon McDonald e Covington. Covington in più era nativo del Mississippi. Mio figlio venne fuori appunto con Mississippi Heat ed è subito piaciuto a tutti. Devo dire che nel corso degli anni, ho sempre ricevuto molti complimenti per il nome della band, credo che si adatti perfettamente anche da un punto di vista poetico alla nostra musica. Preferisco i suoni amplificati, anche se nell’ultimo disco facciamo un blues acustico Too Sad To Wipe The Tears, ma il nome è appunto anche una forma di rispetto verso le radici della musica che amo.
Potresti parlarci della tua famiglia, vi siete trasferiti a Chicago dal Belgio?
Siamo sempre stati stranieri! Mio padre era uno studioso della Bibbia, soprattutto del Vecchio Testamento. Ha ottantasette anni è vive ancora a Chicago, mia madre invece è morta qualche anno fa. Siamo sempre stati stranieri come dicevo prima, io sono nato in Israele, a Gerusalemme dove abbiamo vissuto per due anni, ma poi abbiamo vissuto in Germania, in Francia. Prima di vivere in Belgio ero già stato in tre paesi diversi; in Belgio sono andato in una scuola ebraica ma noi non eravamo ebrei, perciò mi sentivo già allora un po’ fuori posto. Anche nella mia famiglia, mi sentivo un po’ incompreso. Uno dei miei primi ricordi è legato all’armonica, mio padre me ne regalò una di plastica, quando avevo due anni e mezzo o tre, quel suono mi piaceva molto. Crescendo ho ascoltato i Beatles, i Rolling Stones e c’era l’armonica qua e là, ma la cosa non mi interessava più di tanto. Non abbastanza da mettermi a imparare. Quando avevo sedici anni, mio padre ha avuto un offerta per andare ad insegnare teologia a Chicago e perciò ci siamo trasferiti. Vivevamo vicino alla University of Chicago e alla fine della prima estate lì, un giorno me ne andavo in giro a Hyde Park e sentii un suono in lontananza che mi attraeva come un magnete. Seguii quel suono, i battiti del mio cuore accelerarono, era un concerto gratuito per gli studenti al rientro dalle vacanze e c’erano quattro musicisti che suonavano. All’armonica c’era Big Walter Horton! Aveva un amplificatore Fender Princeton e produceva un suono incredibile, la mia vita cambiò in quel momento.
Ricordo solo una canzone che fece quella sera, La Cucaracha, il resto delle canzoni non le avevo mai sentite in vita mia. Ascoltavo Aretha Franklin, Ray Charles, Otis Redding, ma eravamo piuttosto poveri e non avevamo dischi a casa, ascoltavamo più che altro la radio o da amici. Dopo aver ascoltato Horton quel giorno sono andato a comprarmi un’armonica il lunedì successivo, diventò la mia passione, la suonavo ossessivamente per ore. I miei curiosamente, nonostante fossero persone molto serie, intellettuali, mio padre con due dottorati, non mi hanno mai ostacolato o detto di lasciar perdere. Ancora oggi i miei familiari sono sinceramente fieri di quel che ho combinato con la musica. Certo poi ho continuato gli studi e sono andato all’Università. Però nella musica, il blues, e nella comunità afroamericana ho trovato una seconda famiglia, sono subito stato accolto con grande affetto. Junior Wells è stato il primo a farmi capire che appartenevo a quel mondo, che quello era il mio posto. Ricordo che mi regalò un’armonica cromatica da sedici fori, andavamo spesso al Theresa’s a sentirlo, mi faceva suonare con lui anche se stavo appena imparando. Mi sentivo compreso, ben accetto.
Conoscevi Paul Butterfield, Charlie Musselwhite o altri armonicisti bianchi?
Butterfield aveva dieci anni più di me ed ha frequentato la mia stessa High School. Non l’ho mai incontrato però. Ho conosciuto Junior Wells, James Cotton, Carey Bell…Little Walter era purtroppo morto nel 1968 e noi arrivammo a Chicago nel 1969. Vidi molte volte Muddy Waters, con lui c’era Paul Oscher, che avrei conosciuto meglio qualche anno dopo quando vivevo a Montreal. Mi ricordo inoltre di Jeff Carp. Seguivo quasi tutti gli armonicisti, anche Lester Davenport, ma ero piuttosto timido e ad esempio non ho mai incontrato Big Walter, eppure l’ho visto diverse volte, ne ero quasi intimidito anche se ero amico di Steve Freund che suonava con lui. Conoscevo Sam Myers, Snooky Pryor, Billy Flynn e Bob Stroger hanno inciso con lui…il mondo del blues è una comunità ristretta, perciò dopo un po’ ci si conosce tutti.
Little Walter è quello che ti ha più influenzato?
Senza dubbio. Di Big Walter mi piaceva il fraseggio e l’apparente semplicità del suo stile, in realtà molto difficile. Little Walter è stato il mio punto di riferimento, aveva una creatività unica, suonava davvero come un sax e aveva un tono incredibile. Big Walter una volta lo vidi immergere l’armonica nella birra per ottenere quel suono. Quel che mi colpì era proprio il suono simile ad un sassofono, amplificato, la profondità delle note, l’atmosfera che si crea, note pulite, distinguibili seppur con un leggero riverbero o effetto eco.
Ieri avete suonato The River’s Invitation di Percy Mayfield, come mai? E’ per via del riferimento alla malattia contenuto nel brano?
No, a dire il vero non conosco nemmeno molto bene il testo della canzone, non è un pezzo che facciamo come Mississippi Heat. L’ha proposta Carla. Le avevo mandato una lista di canzoni nostre, ma abbiamo dovuto scegliere anche canzoni che lei conosceva già, mi ha mandato una lista e quel brano era su quella lista.
In ogni caso per alcuni anni hai messo da parte la musica e ti sei dedicato agli studi e poi al lavoro in ambito universitario.
Esatto. Ora in prospettiva capisco meglio le cose, le emozioni che avevo in me sin da bambino non erano semplici da capire. La mia era una famiglia di intellettuali, leggevano e discutevano di Camus, Jean Paul Sartre o Dostoevskji…li seguivo, ma non era proprio il mio interesse, da bambino amavo giocare a calcio e la musica. Sentivo qualcosa ma non riuscivo ad esprimerlo, non avevo le parole forse. Durante l’adolescenza ero quasi sopraffatto dalle mie emozioni, mi serviva tempo per capire chi ero, formare la mia identità. Come dicevo, sono nato a Gerusalemme e poi io, mio fratello e mia sorella, dall’asilo all’età di sedici anni, abbiamo frequentato una scuola di ebrei ortodossi, studiato l’ebraico antico, latino, greco…E’ stata una buona formazione, filosofica e teologica, ma piuttosto pesante. Suonavo da qualche anno e mi piaceva, giuro che non bevevo né fumavo o prendevo cocaina, però non funzionava, non ‘guarivo’, anche se pensavo che suonare mi avrebbe aiutato. Avevo l’opportunità di andare al College, studiare all’Università e perciò decisi in un certo senso di seguire le orme dei miei genitori esistenzialisti. Sapevo che ne sarebbero stati contenti e per dodici anni ho studiato, mi sono laureato e poi ho preso un dottorato in psicologia, cominciando a lavorare in quel settore.
Ero direttore di dipartimento, avevo quel che si dice una carriera. Sono stato a Montreal per sei anni per conseguire un Bachelor e poi un Master, ma mi mancava la mia famiglia e così sono poi tornato a Chicago. Ho lavorato come psicoterapeuta per qualche anno e poi ho preso un dottorato, sempre stando a Chicago. Pubblicavo libri, articoli, mi piaceva il mio lavoro, ma ad un certo punto ho avuto una specie di crollo, di blocco. Sentivo che il bambino dentro di me, il piccolo Pierre, era diventato troppo serio, il che non è per forza un male, però io sentivo che mancava qualcosa, dovevo esprimermi in qualche modo. Ne parlai anche con mia moglie Vickie, siamo sposati da trentacinque anni, e abbiamo avuto due figli; decisi di ricominciare a suonare, a partecipare ad alcune jam sessions. Ho anche fatto parte di alcune band come armonicista. Tutti i miei familiari erano felici per questo, vedevano che la musica mi faceva stare bene. Michel, mio fratello, era particolarmente contento e poi nel 1991 ci fu la svolta, quando cominciai con Jon McDonald e Robert Covington. Però devo dire che non mi piaceva troppo suonare cover, Got My Mojo Working…per carità fanno parte della tradizione, lo rispetto, ma volevo fare altro, la mia musica. Ricordo che Michel un giorno mi disse: «Pierre, anzi Manu che è il mio soprannome, perché non formate una band, vi rappresento io come manager». Stroger all’epoca suonava con Jimmy Rogers, James Wheeler per Otis Rush e Jon McDonald aveva un gruppo suo, così come Covington al Kingston Mines. Però in generale il tempismo era perfetto per tutti.
Come hai imparato ad essere un band leader negli anni, dato che tutti i musicisti che hai menzionato erano più esperti di te.
Bella domanda. All’inizio mi sentivo un po’ il sideman nella mia stessa band! Però suonavamo le mie canzoni, restavo umile e non ho mai finto di essere quello che non sono, rispettavo molto i musicisti. Deitra, come anni prima Junior Wells, mi prese in un certo senso sotto la sua ala, parlavamo spesso della band, delle dinamiche tra i musicisti, di tutti questi aspetti. Era una forma di protezione, non in senso fisico beninteso, da alcuni membri della band (non farò nomi!), da alcuni proprietari dei club e tutte le situazioni che si possono venire a creare in tour. Ho avuto quindi buoni amici che mi hanno aiutato sin dall’inizio, ho imparato dall’esperienza, osservando. Oggi non potrei avere quella stessa band, anche se voglio bene ad ognuno di loro, diciamo che non accetterei più alcune cose che all’epoca non sapevo come gestire. E’ una bella storia comunque. Ora ho sessantadue anni ed ho una consapevolezza diversa, posso prendere posizione più nettamente, cambiare musicisti se voglio, anche se non è una cosa che intendo fare.
Cosa ne pensi della presidenza Obama e delle difficoltà che incontra con le recenti elezioni di mid-term.
Senza pensarci due volte dico che amiamo Obama! Siamo arrabbiati, stupefatti come cittadini e musicisti per quel che succede nella politica americana, dal punto di vista della discriminazione e dall’ostracismo nei suoi confronti. Non dico che sia perfetto, ma confrontandomi con persone diverse che incrociamo durante i tour, tutti sono un po’ stupiti che ci sia una resistenza così forte al tentativo di occuparsi dei meno fortunati, penso a Obamacare, o persino a sostenere le arti e la musica. I musicisti afroamericani con cui ne discuto, seppur a volte abbiano prospettive diverse, la pensano come me. Mi spiace solo che Obama non sia riuscito del tutto a trasferire la sua visione politica, perché è molto carismatico e apprezzato a livello internazionale. Qualcosa mi sfugge, è una dinamica che non riesco a capire fino in fondo.
Tornando alla musica, come è cambiato il blues a Chicago nel corso degli anni, dal tuo punto di vista.
Non è facile rispondere e si potrebbe farlo in modi differenti. Penso che molte band che si definiscono blues, non studiano, non conoscono a fondo il vocabolario, la tradizione. Non vanno davvero alla fonte. Io come armonicista cerco di suonare fraseggi originali, ma ascolto ancora i maestri degli anni Cinquanta, coloro che hanno posto le basi per un linguaggio, una eredità culturale. Molti poi suonano per i turisti un repertorio abusato. Poi per fortuna ci sono ancora persone come John Primer, Jon McDonald, Lurrie Bell, Jimmy Johnson che è qui a Lucerna e la lista potrebbe continuare. In ogni caso non credo che si estinguerà. La cosa curiosa è che viaggiando hai occasione di vedere band ottime, in Scandinavia, Germania, Francia, California…che hanno un profondo interesse per il Chicago Blues. A Chicago si suona parecchio rhythm and blues e sento anche un ritorno di musicisti molto appariscenti, alla Hendrix, per qualche ragione.
Cosa pensi di Bob Koester?
Koester è un uomo che vive nel suo mondo, pieno di passione, devoto alla sua creatura. Molto fortunato ad avere una moglie straordinaria, Susan, che lo ha aiutato molto negli anni, insieme fanno una bella squadra. Quel che è stato in grado di mettere in piedi è semplicemente incredibile, specie se si considerano i mezzi che ha avuto a disposizione. Lo rispetto enormemente per questo.
Molti dischi che ha realizzato sono ormai parte della storia di questa musica.
Ah certamente, se pensi a Junior Wells, Magic Sam, Roosevelt Sykes, Jimmy Dawkins e dozzine di altri…del resto è la ragione per la quale sono stato attratto dalla Delmark. Ci conoscevamo da anni con Bob Koester e un certo punto, all’inizio della band, avevamo un offerta da una grossa etichetta, prestigiosa, ci proponevano un accordo per cinque anni e tre dischi. Però c’era una condizione, avrei dovuto licenziare un membro della band. Io non l’ho fatto, ovviamente, così abbiamo inciso i primi tre dischi per la Van de Linden. Poi siamo passati alla Crosscut ed è andata molto bene con loro. Siamo rimasti in contatto con Koester e sapevo che era interessato, mio fratello Michel lo conosce meglio di me. E il resto è storia recente, abbiamo cominciato dal DVD e ora siamo al quinto CD con Delmark, siamo stati accolti magnificamente. Ho completa libertà dal punto di vista artistico e musicale, questo fa sì che la musica resti fresca e vibrante. E’ un rapporto molto bello, lavoro benissimo con Steve Wagner e sono particolarmente orgoglioso dell’ultimo disco, mi fa piacere quindi che siamo in vetta alle classifiche di Living Blues. Warning Shot ha il suono che preferisco, tradizionale ma con qualche elemento diverso, mi trovo a meraviglia con Dotson e Corey, perché hanno stili abbastanza diversi, Michael più tradizionale e Corey più versatile.
Come mai hai sempre avuto voci soliste femminili?
E’ una buona domanda, è vero che ho avuto Deitra, poi Katherine Davis e ora Inetta…penso che abbiamo un suono che mi piace con la voce femminile. Sostituirei Inetta con un uomo se lei non potesse proseguire? Non so, credo dipenderebbe anche dal candidato. Ma in generale preferisco una donna, perché aggiunge una dimensione umana particolare, un equilibrio.
Ultima curiosità, hai mai adottato la musicoterapia per i tuoi pazienti?
No, di solito non parlo mai del fatto che sono un musicista. Qualcuno lo scopre digitando il mio nome su Google e a quel punto, non mento su chi sono. Ogni tanto la gente dopo un concerto mi avvicina e mi dice che la musica li ha toccati, cose così, però cerco di tenere separate le due cose anche se in realtà sono molto interconnesse. Il blues parla della vita, la psicologia parla della vita! La psicologia anzi mi aiuta a scrivere canzoni, a trovare una prospettiva per raccontare storie, basate su episodi veri o anche su musicisti che conosco.
(Intervista realizzata a Lucerna, Svizzera, il 15 novembre 2014)
Matteo Bossi, Silvano Brambilla, Marino Grandi, fonte Il Blues n. 129, 2014