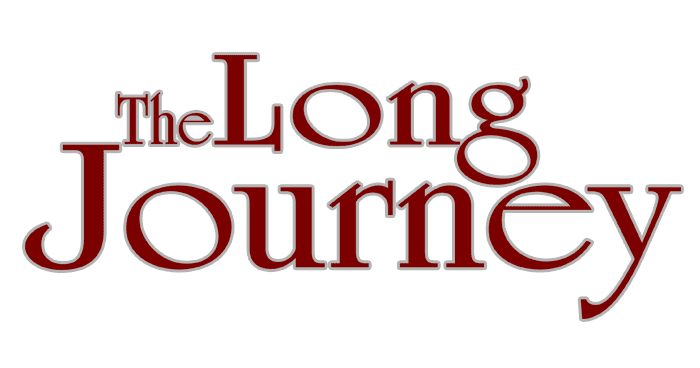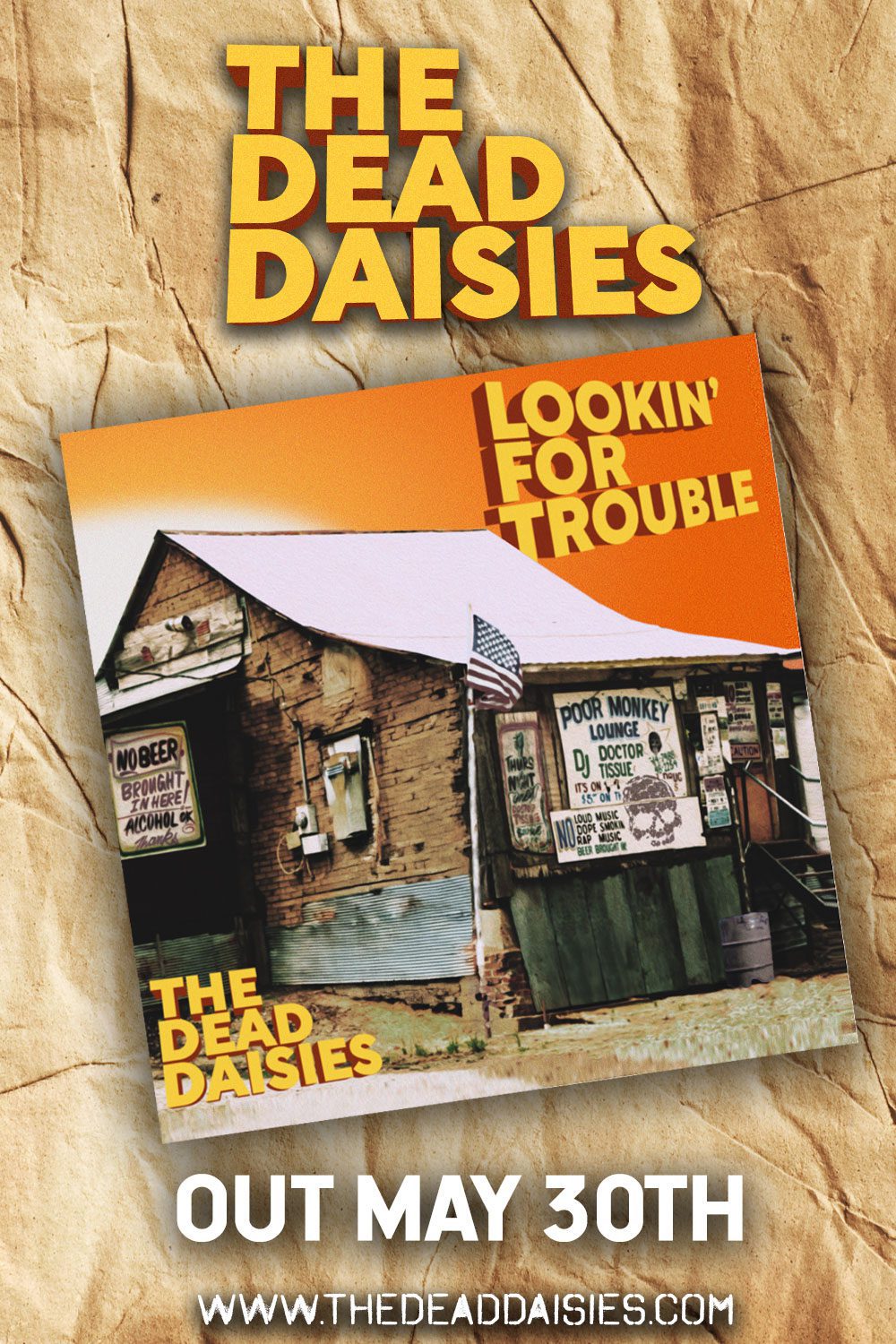Country Store nr. 30, un’uscita molto speciale: mai fino ad oggi questa pubblicazione ha avuto il piacere di ospitare al suo interno un così alto numero di recensioni di produzioni italiane, sembra incredibile. Ma non finisce qui. Sul prossimo numero di Gennaio/Febbraio leggerete dei Red Wine e dei Bluegrass Stuff, e presto avremo il piacere di parlare di altri dischi che, al momento, sono in fase di registrazione o ‘post produzione’. Che cosa è successo? E’ una semplice coincidenza? Probabilmente si. I costi di produzione di un CD o, meglio ancora, di una cassetta sono oggi piuttosto ragionevoli, e per un gruppo che nell’arco dell’anno si esibisce con una certa frequenza far fronte ad un investimento del genere (perché d’investimento anche trattasi) non risulta essere così sacrificante in termini economici.
E poi. che senso ha per una formazione ultra decennale proporsi in maniera più o meno ‘professionale’ se al proprio attivo non ha un prodotto discografico da esibire?
In campo blues e jazz, per non parlare di rock, la produzione nostrana indipendente consta ormai di centinaia di LP, CD e cassette; il country italiano, invece, si è dimostrato fino ad oggi piuttosto avaro in quanto a realizzazioni sonore.
Il primo disco del genere risale alla prima metà degli anni ‘80 e fu inciso dai romani Old Banjo Brothers, poi, dopo anni d’attesa, giunsero gli Erba Blu Style, Beppe Gambetta, Red Wine, Buffalo Ramblers, George McAnthony, Stefano Tavernese, più qualche compilation…
La qualità dei dischi prodotti fino ad oggi è molto varia, qualche cosa è veramente buona, in altri casi si rimane su di un livello dilettantistico, in altri ancora il livello è piuttosto scarso, ma non per questo meno interessante, almeno dal punto di vista di un appassionato del genere.
Produrre un disco, per un gruppo musicale non professionista, è una avventura impegnativa, perché tutto grava sulle spalle dei componenti della band. Perciò, pur tenendo presente le mille difficoltà a cui bisogna far fronte, compresa l’inesperienza, il risultato finale lo si valuta spesso partendo proprio da questa considerazione, che i musicisti, cioè, non sono professionisti. Conseguentemente, gli eventuali punti deboli presenti nell’incisione vengono compresi e quindi giudicati con un parametro meno inflessibile. Ciò nonostante, con tutte le motivazioni che il gruppo può dare alla sua esigenza di incidere, e al risultato di ciò che in seguito è stato inciso, è il prodotto finito che parla, tutto il resto non conta.
Un disco viene giudicato bello o meno sin dal suo primo ascolto se la musica in esso registrata è di buona qualità (banalissima riflessione…), ma quali sono i fattori che determinano principalmente la riuscita di un prodotto discografico, a prescindere dai gusti personali di chi lo andrà ad ascoltare? Sono molti, l’utilizzo di un valido ingegnere del suono, ad esempio è uno dei principali.
Altro dato che bisogna ben tenere in considerazione è il tipo di suono che si desidera riprodurre.
Argomenti, questi, sui quali si è scritto anche libri, ve ne sono parecchi sul tema, e la loro lettura non può che giovare al musicista che intende provare l’esperienza di studio, soprattutto per quanti, per questioni economiche, sono costretti ad avvalersi di piccoli studi spesso gestiti da personale di dubbia professionalità.
Il gruppo deve prestare moltissima attenzione a questi aspetti, poiché può anche succedere che il prodotto finale non vada a rappresentare al meglio la personalità della band.
Certo, si può anche fare a meno di un produttore esterno, ma ciò è possibile solo a condizione che almeno uno dei componenti del gruppo sappia esattamente quale tipo di suono deve uscire, in termini di missaggio e sonorità, e come farlo uscire.
Ora. sappiamo bene che l’esperienza live non è sufficiente in questo senso, idem dicasi a riguardo dell’esperienza media dei musicisti non professionisti in quanto a studi di registrazione. Proprio per questo, solo dopo aver ben individuato quale tipo di sonorità devono avere gli strumenti, prendendo in esame e come punto riferimento produzioni di alto livello del genere, ritengo sia necessario l’apporto di un amico esperto che dall’esterno possa filtrare le esigenze della band e trasmetterle a chi sta dietro al mixer.
Altro discorso andrebbe fatto rispetto all’approccio del gruppo nei confronti del progetto discografico. Essere una ‘copy-band’ è quanto mai cosa normale per un gruppo italiano, eppure, ritengo, il margine di accettabilità nei confronti di una tal band in situazione live va a ridursi se ascoltata in una produzione discografica. In parole povere, mi chiedo, perché mai un chitarrista elettrico che riesce a riprodurre un difficile assolo di Albert Lee, John Jorgeson o Vince Gill, e che quindi dimostra di essere padrone di tecnica a sufficienza, non cerca di cimentarsi in qualcosa che possa essere ritenuto più personale?
Lo stesso lo si può dire per un buon numero di banjoisti di casa nostra: se si è in grado di riproporre Bela Fleck in maniera dignitosa, presumo, vuoi dire che lo Scruggs-style e il Reno style siano un bagaglio sufficientemente acquisito…
E allora, da costui vorrei tanto attendermi un assolo diverso da quello di Fleck se la sua band vuole farmi ascoltare un pezzo dei Newgrass Revival. Questi sono solo due esempi, e nessuno, per cortesia, si senta chiamato in causa.
Tutte queste premesse, che ai più possono sembrare inutili o quantomeno atte a raggirare l’ostacolo, personalmente mi sembrano opportune poiché questi tipi di problemi risultano essere piuttosto comuni alla maggior parte delle produzioni italiane di country e bluegrass, pur considerando che la quasi totalità delle formazioni musicali non sono professioniste, e quindi generalmente mosse da uno spirito legato alla pura passione e voglia di divertimento.
Aggiungo, infine, che il livello dei musicisti italiani di bluegrass è uno dei più alti al di fuori dagli USA (in campo country, purtroppo non è così), e quindi prego i lettori a non fraintendere questa mia introduzione alle recensioni: il problema è legato esclusivamente alle incisioni, tant’è che tutti i gruppi, o quasi, di quelli che hanno finora registralo, si esprimono meglio in un contesto live piuttosto che in studio.
Hocus Pocus – After Waitìng (Cassetta)
Il sestetto genovese molti di voi lo conosceranno già, in quanto si esibisce in lungo ed in largo per il Nord Italia da una decina di anni. Esibizioni che hanno creato una buona fama alla band, sempre grintose e ben curate, fossero incentrale principalmente in un repertorio west coast, come in un passato ormai quasi remoto, o in sonorità decisamente new country, come da qualche anno a questa parte.
Attualmente gli Hocus Pocus hanno la seguente line-up: Paolo Donnini (chitarra elettrica e cori), Luca Beneventi (basso elettrico e cori), Andrea Marti (chitarra acustica, armonica e voce), Giorgio Bettocchi (chitarra acustica e voce), Stefano Alpa (batteria) e Andrea Gamba (violino).
Alle registrazioni hanno partecipato anche il bravissimo chitarrista Paolo Bonfanti (anche vocalist in due pezzi) e Martino Coppo (mandolino e voce nel brano di chiusura).
Le undici canzoni sono state registrate in presa diretta, questo ad ulteriore dimostrazione di quanta compattezza abbia la band. e quanto già rodate fossero le canzoni proposte. Il suono è buono, ben bilanciato e, nello specifico, gli strumenti che devono possedere quel sound, quel timbro tipicamente country, soddisfano anche l’orecchio più esperto, in modo particolare l’elettrica di Donnini.
Uniforme è anche il livello individuale dei musicisti… a parte, ahimè, il violinista che in alcuni pezzi si dimostra a suo completo agio, mentre in altri forse un poco limitato (stiamo parlando di country music naturalmente…).
Aggiungerei, giusto per completare il quadro delle cose a cui prestare attenzione, una costruttiva critica all’aspetto vocale, non tanto del cantato in sé o delle armonie, perché da questo punto di vista i vocalist, tutti, sono davvero ottimi, ma riguardo alla pronuncia dell’inglese. E non mi riferisco solo all’accento…
Le canzoni funzionano, sono tutte ben eseguite e ben selezionate, così anche le due originali (Marti/Bonfanti), delle quali Michael In The Rain si rivela un vero e proprio gioiellino e una delle migliori cose dell’intera raccolta. Particolarmente piacevoli mi sono sembrate Guitars And Cadillacs, Callin’ Baton Rouge, Highway 40 Blues e Guitar Town.
Insomma, un inizio più che promettente. Il prossimo prodotto dovrà essere un CD, contenere più originali, e sulle cover la band dovrà investire più energia in quanto ad arrangiamenti.
Stampede – Kokopelli (Dies Irae Records CHM 009)
II gruppo è relativamente giovane, ed è formato da Fabio Ragghianti (chitarre, mandolino e voce), Alessandro Arrighini (chitarre, accordion e voce), Dino Ferrari (basso), Cinzia Ramacciotti (voce), Massimo Togni (batteria).
A soli due o tre anni dalla formazione, gli Stampede producono un CD d’esordio, che tempismo! Entusiasmo e voglia di concretizzare certo non mancano. L’obiettivo, ritengo, sia quello di proporsi come band di ‘American Music’, piuttosto che ‘semplicemente’ di country music; infatti, si possono ascoltare più influenze in questa raccolta, e il taglio generale è quello di certo country rock d’autore, una musica che sta a metà strada tra Texas, Nashville e Alabama.
Cinzia Ramacciotti è decisamente valida come lead vocalist, anche se mi piacerebbe sentirla più aggressiva, più ‘in avanti’, meno ‘seduta’; Alessandro Arrighini ha un timbro vocale che ricorda da vicino quello di Rodney Dillard e, mediamente, si dimostra anch’egli validissimo vocalist, in maniera particolare nella bella Time Passes By; infine, sempre nel ruolo di lead vocalist, Fabio Ragghianti è il più limitato del trio, non tanto perché possiede una voce poco potente, ma perché poco dinamica.
Strumentalmente il disco offre un livello medio, anche se dal punto di vista solistico forse gli strumenti non emergono in maniera decisiva, e il disco si fa apprezzare più per certe scelte d’arrangiamento e per la piacevole atmosfera generale che per la voglia di dimostrare l’individuale livello tecnico dei musicisti.
La registrazione a tratti risente di un missaggio poco preciso e il suono è moderatamente compatto. Kokopelli propone tre brani originali di Ragghianti, due dei quali scritti in coppia con il noto Luciano Federighi, il Leon Redbone di casa nostra. Luciano e Cinzia duettano in Another Lonely Sunday, uno degli episodi più interessanti del compact.
Anche Wild One, Catch The Wind, la difficile Rhythm Of The Blues di Mary Chapin Carpenter e la già citata Time Passes By sono ben eseguite dalla band e contribuiscono a rendere Kokopelli un dischetto che fa ben sperare sul futuro dei toscani Stampede.
In definitiva, gli aspetti più criticabili del prodotto, che comunque ritengo di dover consigliare senza alcun dubbio, mi pare vadano ricercati nella mancanza di sufficiente esperienza di gruppo piuttosto che nella responsabilità individuale dei suoi componenti
Dobro – One (SPCRCS010)
Il disco è uscito nel 1993, e mentre noi siamo qui a parlarne, il gruppo sta già pensando di cominciare a lavorare al numero Due. Questa opera prima degli emiliani Dobro sfortunatamente è stata mal distribuita, probabilmente a causa di problemacci nati tra il gruppo ed alcuni personaggi che hanno collaborato alla sua realizzazione. Peccato, perché One è un bel dischetto, suonato e registrato con professionalità. Non mi stupisce, infatti avevo sentito parlare un gran bene di questa formazione. Una conferma dunque.
I Dobro sono: Eugenio Poppi (pedal steel, dobro, armonica, chitarra e voce), Claudio Pelù (chitarre e voce), Vittorio Alfieri (basso), Franco Morari (batteria), Maurizio Panizza (chitarre e voce), Giovanni Daolio (chitarre, banjo, mandolino e voce), Roberto Alfieri (tastiere), Stefano Onofrio (violino).
Con una strumentazione simile è difficile immaginare che i Dobro non abbiano ricevuto alcuna influenza dalla Nitty Gritty Dirt Band; e infatti, il riferimento è più o meno continuo, e non solo perché vi sono Keepin The Road Hot, Cosmic Cowboy e Workin’ Man tra le 12 canzoni proposte. Ascoltandoli anche in maniera superficiale, immediatamente riaffiora un buon numero di gruppi che tutti abbiamo amato, che fanno parte del nostro passato. I Dobro riescono bene a coniugare certo country rock anni ’70 con il nuovo country e il bluegrass; anche se, devo dire, la prima di queste componenti è quella preponderante.
La registrazione è sufficientemente buona e il prodotto, in generale, si presenta professional. L’unico aspetto che mi lascia perplesso, se mi si consente, è quello della partecipazione emotiva nell’esecuzione: se l’obiettivo di creare un disco dai suoni puliti e ben bilanciati, di canzoni piacevoli e accessibili a tutti, è stato indubbiamente raggiunto, è anche vero che questo forse è andato a discapito del ‘soul’, componente di cui un’opera discografica non può fare a meno, e senza la quale inevitabilmente rischia di risultare asettica, un semplice ‘’esercizio’ di musica che entra nelle orecchie ma non riesce a raggiungere il cuore.
Aggiungo un’altra piccola cosa che vale anche per i due precedenti prodotti: non sento fervore, tantomeno rabbia. Ho assistito recentemente all’esibizione di un buon gruppo con un amico il quale, una volta conclusasi, l’ha commentata con un… “Miseria, questi sono proprio incazzati…”. Escludo che i soggetti in questione lo fossero veramente, e ciò che l’amico intendeva dire naturalmente si riferiva alla forza, all’aggressività che questi trasmettevano al pubblico. Non è necessario aver raccolto cotone per due terzi della propria vita per eseguire il blues come si deve… E anche il country lo si può suonare senza essersi rotta la schiena in una miniera del Kentucky (…o della Sardegna). Eppure…
One, comunque la veda il sottoscritto, contiene una buona manciata di belle canzoni della quale i Dobro possono andar fieri. Hanno fatto un buon lavoro di riproposizione con The River di Springsteen, e hanno scritto pure un paio di interessanti pezzi. E il disco è consigliatissimo a tutti…
Maurizio Faulisi, fonte Country Store n. 30, 1995