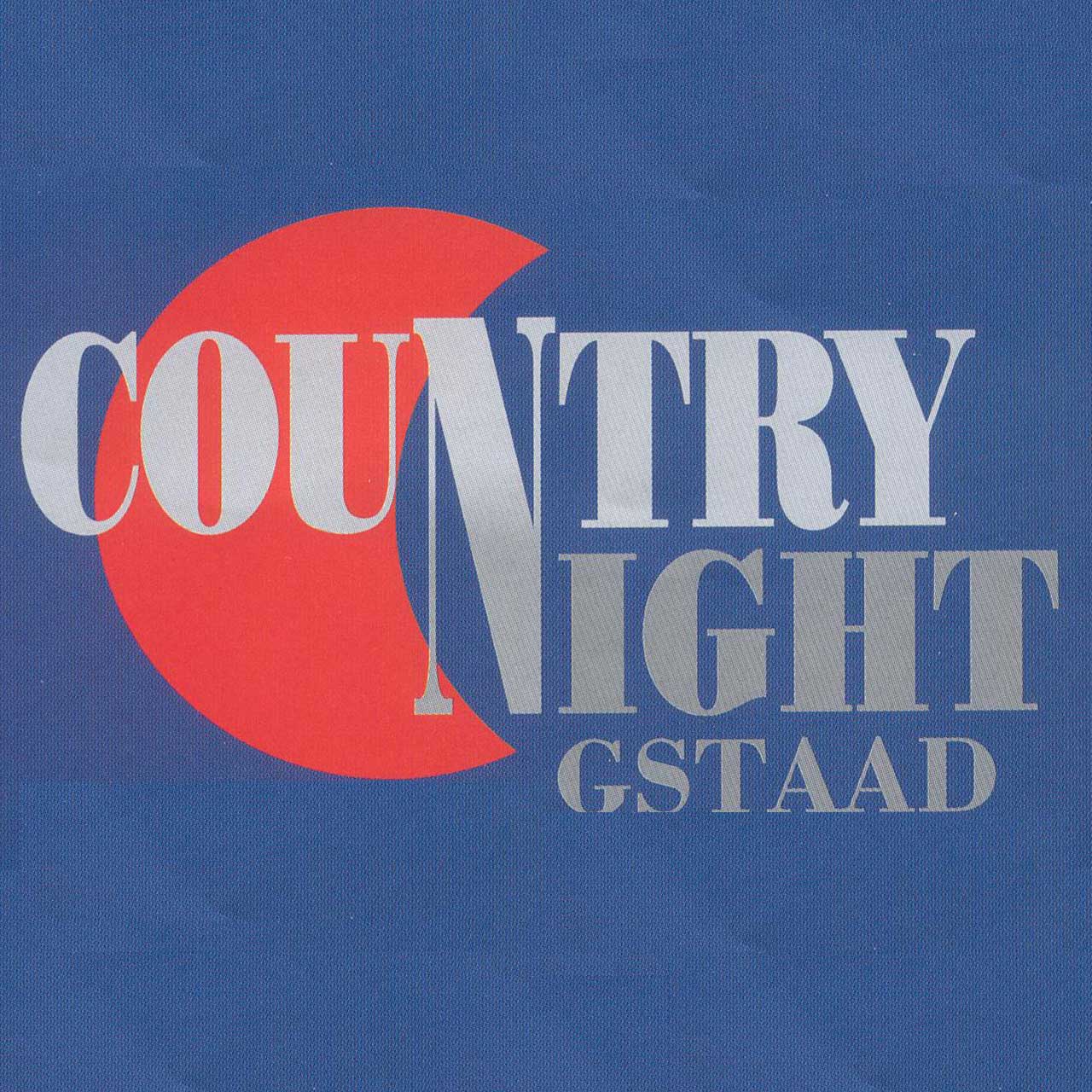Quante speranze variamente riposte e quante sorprese in quel di Gstaad, edizione 2000! Rileggendo il mio articolo di presentazione, sul numero scorso di Country Store, non posso fare a meno di rilevare le differenze tra aspettative e realtà del dopo concerto. Non è un divario negativo, anzi, la Country Night è sempre un bel regalo di fine estate per gli (ancora) scarsi fans italiani che vi accorrono annualmente e sempre suscita umori e discussioni. Tanto più quest’anno cruciale in cui a Nashville infuria la battaglia di posizioni tra tradizione e ‘innovazione’.
Ma dicevamo di speranze e sorprese. Be’ nel caso di quelle ben riposte, e chi poteva dubitarne, rientrano gli Asleep At The Wheel nell’ennesima formazione della loro lunga storia, reduci da un’annata di tour americani con George Strait, Bob Dylan e Kathy Mattea, trainati da un irresistibile Ray Benson in stivali di serpente, nelle sue tante identità: virtuoso, istrione, egocentrico, spiritoso, autoironico, sempre strepitoso.
Pilastri dell’attuale gruppo, i più recente acquisti Jason Roberts a fiddle e harmonies, John Michael Whitby al piano e l’affascinante veterana Cindy Cashdollar a steel e dobro. Relativamente veterani pure David Miller al contrabbasso elettrico, David Sanger alla batteria e Michael Francis al sax il cui apporto, tutt’altro che marginale in una western swing band che si rispetti, si fa ancor più decisivo quando si tratta di sostenere i riffs del boogie (Route 66, Boogie back to Texas, House of blue lights).
Cosa aggiungere che non si sappia già delle Ruote e del loro repertorio? Una band di veri musicisti che si divertono a rincorrersi con preziosismi tecnici e virtuosismi mostrando spontaneità e naturalezza strabilianti. Per gli appassionati di pedal steel un’attrattiva in più: le mani affusolate di Cindy sono state uno spettacolo nello spettacolo: c’era di che restare ipnotizzati nel seguirne i movimenti. Tocchi secchi ed allo stesso tempo delicati e flessuosi sulla tripla tastiera ad estrarre stacchi, solo, licks, ricami, ed a svolgere un lavoro ritmico che non ci si aspetterebbe dallo strumento più avvezzo a creare atmosfere, a strappare cuori che a farli ballare.
Fin dalle prime battute si respira a pieni polmoni aria di Texas e c’è da scommettere che chi viene di là si ritrovi immediatamente a casa. Vedere un concerto dei Wheel è come percorrere in poco più di un’ora tutte le backroads della Stella Solitaria (Miles and Miles of Texas), tornare indietro nel tempo di qualche decennio con Bob Wills in un Sud-Ovest ancora semirurale (Milk Cow Blues, Rory Poly, Big Ball’s In Cowtown, una trascinante versione del Cotton-eyed Joe nel concerto del Venerdì), come sognare i grandi spazi con i Sons of the Pioneers (Tumbling Tumbleweeds, dedicata lì per lì a tutte le mucche svizzere), come affacciarsi in Oklahoma da una finestra sul Fiume Rosso (Cherockee Maiden, con cui si è aperto il concerto).
A dare respiro al leader pensa occasionalmente Jason Roberts prendendosi carico della parte vocale o di trascinare gli strumentali.Tra i suoi numeri, una The End Of The Line rispolverata in omaggio al vecchio Johnny Gimble, coautore con ‘Re’ Wills. Poi Benson riprende il volante con una estesa versione di Georgia On My Mind, ma la ‘chicca’ dell’intero concerto è una lunga inedita versione di Red River Valley che scatena gli applausi. Dall’impianto tradizionale prende il via un cambio di ritmo sul quale intervengono a turno tutti gli strumenti a dipingere un quadro in cui elegia della frontiera, spiritualità e celebrazione della natura incontaminata si fondono magicamente con il tessuto musicale in una sorta di versione western delle indimenticabili Isole dei King Crimson.
La voce di Ray Benson tocca toni di struggente nostalgia, vola insieme al falco e subito dopo corre con l’antilope, ci fa sentire la pace dello scenario naturale e la meraviglia umana di fronte alla grandezza possibile degli orizzonti. Alla chiusura, il pubblico di Gstaad esplode nell’applauso più lungo della serata. Credevo che la versione di George Strait (nella colonna sonora di Horse Whisperer) fosse ottima ma questa, personalizzata, delle Ruote è insuperabile. C’è solo da sperare che la registrino.
Il consueto bis, House of Blue Lights, chiude lo show tra il tripudio generale.
Un concerto standard per le Ruote, ma non per questo poco coinvolgente. Ritmo e solidità insieme alla bravura individuale ne sono gli aspetti fondamentali. A cercare il pelo nell’uovo, un secondo fiddle e una seconda voce solista, come negli anni di Chris O’Connell e Larry Franklin, ne potenzierebbero ulteriormente il già notevole impatto.
La serata era cominciata bene con il bravo Chad Brock ed il suo repertorio personale di new country con recuperi d’autore (Big City di Merle Haggard, I Guess You Had To Be There dal repertorio di Lorrie Morgan) e qualche ‘furbata’ trascinapopolo come Sweet Home Alabama.
Il ragazzone è assolutamente gradevole, ha un limpido timbro di voce tenorile e una palpabile sincerità nel proporsi. Ha ancora un numero limitato di proprie canzoni ma quelle che ha gli calzano a pennello: la similcajun Evangeline con cui apre lo show, il suo primo Numero Uno Ordinary Life, tipica ballata new country, le atmofere semiacustiche di ‘Til I Fell For You (solo al venerdì) ed il suo secondo hit Yes con cui, dicono, si sia dichiarato sul palco alla futura moglie.
A perenne testimonianza, gli inequivocabili dialoghi del testo (She said Yes/I said Wow!/she said When?/I said What about right now?)! Tra le piacevoli divagazioni, un hard country dal buon Hank Williams Jr. (A Country Boy Can’t Survive) ed un salto nel più vicino honky tonk con Unbreakable Heart. Una canzone autobiografica (The Visit), un paio di non grande rilievo (Lightening, She does), e via con il bis (Keep Your Hands To Yourself) introdotto da una ‘gustosa’ scenetta in complicità con il chitarrista albino (Rod Jensen) che finge di non voler lasciare il palco contro il volere del ‘capo’. Tutto qui, semplice, ingenuo, downhome e onesto, proprio come la country music. Per questo, malgrado l’acerbità artistica, è piaciuto. L’impressione è che sentiremo ancora parlare di lui.
Chi invece ha purtroppo ‘toppato’ è stata Jo Dee Messina, attesa come si attende un Horizon Award ma decisamente deludente nell’insieme. Pervasa da strana agitazione, nervosissima già nei camerini ed alla conferenza stampa dove esibiva una risata innaturale che voleva sembrare spontanea, sul palco cercava di dissimulare il suo stato d’animo esibendo quell’eccessiva vivacità che appare immediatamente fuori luogo: una successione di espressioni facciali equivalente al numero degli accordi, ammiccamenti reiterati, mossette e sorrisi a raffica, continui cenni di saluto ad un immaginario ‘qualcuno’ tra il pubblico che non dava motivo di tanto calore e la cui attenzione sfumava col passare dei minuti.
Neanche il repertorio sembrava aiutarla a superare quella strana concitazione. L’aggettivo che più mi è ricorso in mente per la durata del suo concerto è ‘banale’, fin dal brano d’apertura, Closer, un pop, appunto, banaluccio a cui seguivano subito, quasi a voler rientrare nei ranghi, Heads Carolina, Tail California, Single of the Year 1977 per i Country Radio Awards, e The One Who Stands Beside Me, brano lento e suggestivo dalle belle sonorità acustiche impreziosite dai ricami della steel. Quelli i momenti più alti dello show.
Da quel momento in poi è stato un susseguirsi dei brani che hanno determinato il suo successo (That’s The Way, Burn, Rain, I’m Alright, Dare To Dream, ecc. ), tutti di scarso rilievo e purtroppo corredati da commenti introduttivi di filosofia da soap opera a spiegare le personali motivazioni per la scelta. Un breve colpo di coda con il brillante recupero dagli anni ’70 di Lessons In Living della brava Dottie West, poi di nuovo una palpabile noia (Come On, Bye Bye, These Are The Days) ed il bis di prammatica (Nothing) il cui appeal era pari al titolo.
Avremmo voluto augurarle di superare, magari con l’aiuto di qualche ansiolitico, il brutto momento che sta vivendo e vogliamo credere che si tratti solo di un momento. Peccato, pensavo, perché la voce ed il talento ci sono. Non ci sono però le canzoni, come del resto per la maggior parte delle nuove leve femminili di Nashville, e non ci sono le emozioni. E le emozioni nella country music sono quasi tutto.
E se tutti a questo punto aspettavano Wynonna, nessuno certamente si aspettava il vero colpo di scena: un gran concerto di rhythm&blues tradizionale! Preceduta da un riassetto del palco che faceva presagire la star (gran viavai di tecnici, numero dei microfoni, agitazione nel backstage) e da una dichiarazione inequivocabile in conferenza stampa, solo un’ora prima, (“Mi sento come un ambasciatore della Country Music, vorrei che tutti al mondo ascoltassero e suonassero country music…”) niente faceva pensare che sarebbe piombata sul palco una Wynonna completamente trasformata sul piano artistico e su quello umano rispetto al passato: incedere alla Van Morrison (malgrado l’attuale sovrappeso), grande comunicativa con il pubblico (dialoghi e giochi inaspettati con interlocutori occasionali dalla platea, disponibilità addirittura a fermarsi immobile per lasciarsi fotografare), una voce più ricca e potente, ma soprattutto, spettacolo nello spettacolo, quel trio di vocalisti neri di eccezionale bravura, in perfetto stile Motown anni ’70 con tanto di coreografia e gestualità coordinata.
Nomi da ricordare: Robert Bailey, Kim Fleming e Vicki Hampton. Da associare nella memoria, per bravura e simpatia, ai mitici Bobby King e Willie Greene jr. , compagni di strada di Ry Cooder per un decennio.
Accanto a loro, due chitarre (John Conley, Tom Hemby), due tastieristi (Mark Jordan, Harry Sharpe), basso (Steve Mackey) e batteria (Steve Potts) , per un avvio decisamente energetico, Tuff Enough, presa in prestito da Kim Wilson, anima e armonica dei gloriosi Fabulous Thunderbirds, seguita a ruota dalla altrettanto impetuosa Somebody To Love e dalla sinuosa, intrigante Rock Bottom.
Chitarra a tracolla, giacca lunga argentata, gran disinvoltura, dinamicissima, Wynonna sembra veramente un’altra persona rispetto ai giorni passati (ve la ricordate quasi statica, sorrisi al risparmio, intabarrata in vestiti larghi, vicino a mamma Naomi che se la guardava tenera e compiaciuta?).
Matrimonio, figli e abbandono delle scene da parte della madre, tutto nell’arco di qualche anno hanno probabilmente influito positivamente su una personalità che attendeva di liberarsi e di liberare un talento sensibile ma evidentemente soffocato, frenato nelle potenzialità. Una fede cercata, ritrovata ed esternata con gran gusto artistico nelle atmosfere gospel che pervadono il suo show (To Be Loved By You, Baby King, How Great Thou Are) è stata complice e artefice, a suo dire, di questa sua rinascita. Ora è veramente una star, in grado di muoversi con consapevolezza in ogni meandro della musica popolare americana e di darle una propria impronta.
New Day Dawning, titolo del suo nuovo CD, che ci fa ascoltare quasi per intero, è solo il riferimento più evidente alla sua nuova condizione.
Già, ma dov’è il country in tutto ciò? E’ senza dubbio in quel breve set unplugged, con i musicisti che le si stringono intorno, chitarre acustiche e voci, a ricordare i momenti passati (Mama He’s Crazy, Good Old Days), è nel bis con l’attesissima Noone Else On Earth, è nella voce che si spezza nel raccontare il travaglio della mamma malata, è inequivocabilmente nel modo di dialogare ed interagire con il pubblico, ed è nell’anima bianca con cui interpreta, passionale ed ispirata, l’altra grande musica delle radici, nel rispetto incondizionato della sua tradizione, nell’evidente onestà di tale scelta (il grande successo commerciale oggi non passa per il R&B).
La nuova Wynonna riesce con la spontaneità e la naturalezza di una figlia del Sud americano a identificarsi allo stesso tempo con le emozioni della country music, l’intensità del gospel e l’esuberanza del rhythm&blues.
Quindi, tutto considerato, non rimpiangeremo la Wynonna country; a partire da oggi sposteremo semplicemente i suoi dischi nello scaffale accanto, insieme a Delbert Mc Clinton, a Van Morrison, a Bonnie Raitt, a Marcia Ball, al Doug Sahm della Last Real Texas Blues Band, e ce li terremo altrettanto cari.
Fabrizio Salmoni, fonte Country Store n. 54, 2000