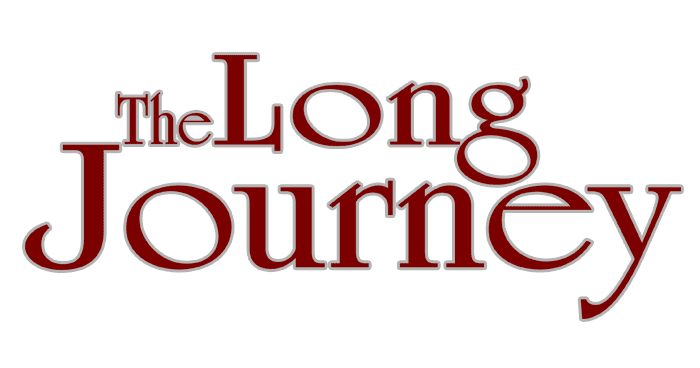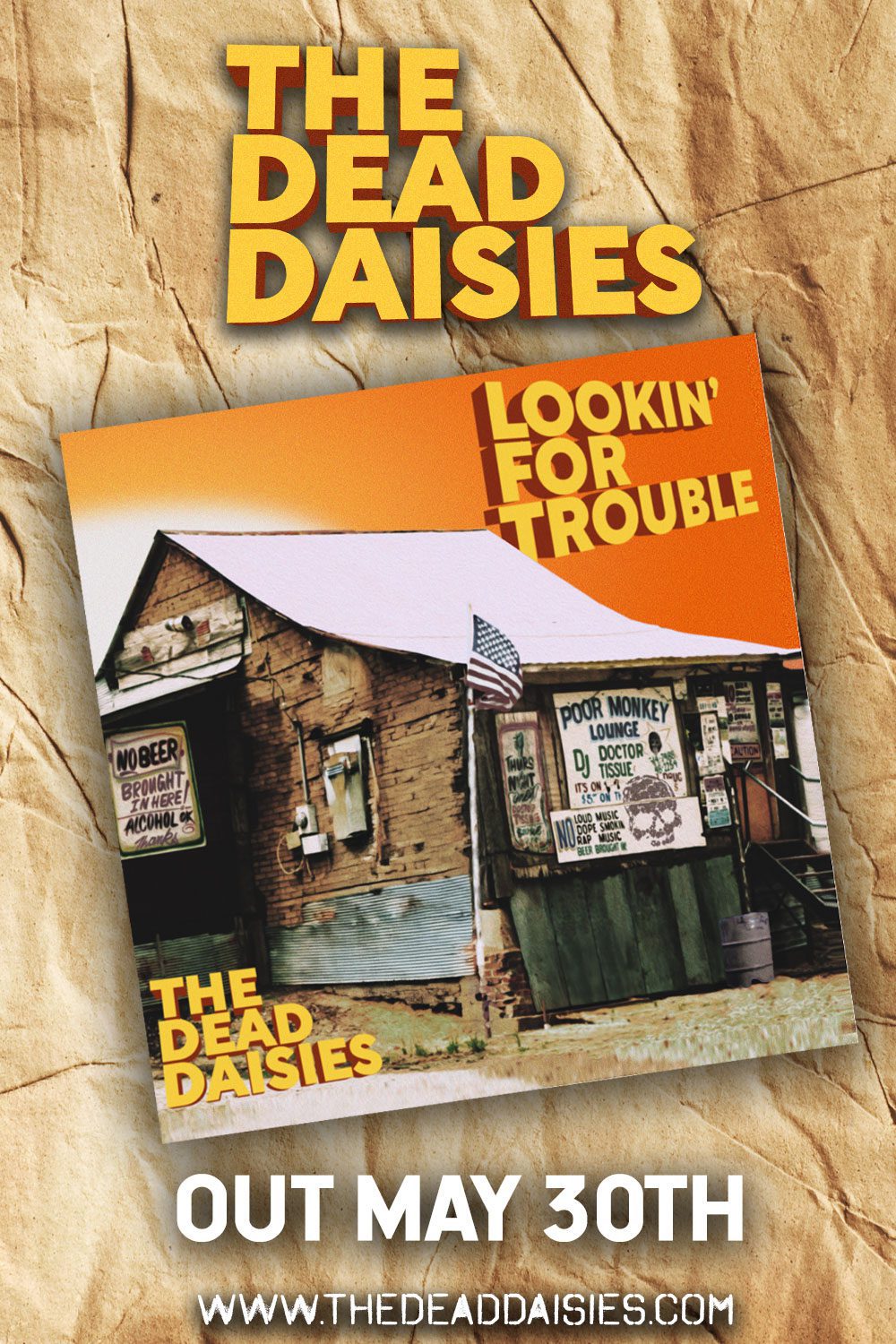Potrei cominciare questa cronaca in termini canonici dicendo che, come sempre, la Country Night di Gstaad ci ha regalato un grande concerto, tre grandi voci che farebbero invidia a tanti ‘cantanti’ nostrani e che indubbiamente ci riconciliano, sia che le ascoltiamo dal vivo o da CD, con la musica e con i criteri che dovrebbero regolarne i meriti.
Gli stessi lamentati tagli al budget non hanno inciso in modo percepibile sull’organizzazione se non per il fatto che le suddette tre voci potessero essere quattro come negli anni precedenti. E non ce ne voglia il vecchio John Brack, onesto enterteiner svizzero, interprete per qualche casualità di scampoli della nostra musica preferita, se non lo conto tra i grandi: la sua presenza scenica ed il suo repertorio datato (da anni ’60, direi) potrebbero forse interessare agli executives delle nostre case discografiche per una nuova compilation sulla country music da rivolgere al mercato italiano.
Vorrei però non pensare che si sia voluto risparmiare sul servizio di amplificazione, vera bestia nera, protagonista in negativo, di questa edizione. Se gli anni scorsi il concerto del venerdì fungeva quasi da prova generale per musicisti e tecnici e le magagne si aggiustavano entro il secondo act della serata, quest’anno le magagne sono rimaste fino all’ultimo incidendo in misura sostanziale sulla qualità complessiva della manifestazione.
Steel, fiddles e harmonies (e dite voi se è poco) sono stati quasi totalmente annullati ma sovente persino gli assolo di chitarra elettrica erano impercettibili. A sovrastare tutto, batteria (un grazie a Collin Raye che probabilmente accortosi del problema le sistemava davanti un pannello assorbisuono), rimbombo di bassi e voci soliste, l’unica prevalenza di cui non ci si potesse lamentare. Anzi, ci si chiedeva come potessero mantenersi intatte, potenti e prive di stecche.
Solo Gary Allan dava segni di impazienza, togliendosi e rimettendosi auricolari e gettando occhiatacce e gesti imperiosi al mixerista di palco, segno che anche lì le cose non andavano per il meglio. Ma tant’è, e segnalato per dovere di cronaca il problema ai lettori e agli organizzatori, passiamo alla cronaca vera e propria che registra l’avvento di Sara Evans sul palco, al suo debutto europeo, accompagnata da six-piece band più una vocalista solitaria (le fanno con lo stampino a Nashville: brave, niente da dire, e carine ma con quell’irritante sorriso estasiato permanente e gli ammiccamenti continui con la titolare della scena).
L’incipit è sostenuto con The Great Unknown, lei è molto graziosa ed ha una potenza vocale da far volar via i parrucchini dalle prime file. La canzone è bella, vagamente sixties e trascinante e potrebbe esserlo addirittura di più se venisse ulteriormente sviluppata nei breaks strumentali.
Segue a ruota la più ‘normale’ The Crying Game ed alcuni brani dall’ultimo Born To Fly, poi la romantica No Place That Far dedicata al marito.
La sala si è ormai scaldata e segue il concerto affascinata da una vocalità così raffinata e, diciamolo, così poco twangy da rendere meglio nelle canzoni più orientate al pop (vedi soprattutto I Could Not Ask For More) che negli episodi più prettamente country come la coinvolgente Three Chords And The Truth e Saints And Angels.
Il sensibile allontanamento dalle radici viene mitigato da una versione personalizzata di Sweet Dreams, solo per voce e piano, lentissima, ad evidenziare ulteriormente le capacità vocali non senza indulgere però a qualche leziosità, da un siparietto con sfondo Tiger By The Tail e dalla scherzosa Cupid che senza George Jones alle harmonies non esce dalla banalità. Il bis è purtroppo sprecato con un’insulsa versione di Long Train Running, talmente fuori luogo ed edulcorata da far rivoltare nel sonno, dall’altra parte del mondo, i Doobie Brothers.
A fine show si raccolgono i giudizi e risultano vincere comunque ai punti la bravura e la voce. Che dire del repertorio? Le canzoni, perché no, sono belle ma ahimè, le corde del cuore al sottoscritto vibrano soprattutto con quelle della steel guitar che si sentiva così poco ma che avrebbe potuto anche non esserci.
Il cambio di stagione si avverte dai piccoli segni. Infatti, la risistemazione del palco rivela posizioni preminenti per steel e violino la qual cosa mi predispone l’animo al meglio. Ci sarebbe da stupirsi del contrario con il neocampione del Bakersfield sound, uno che riesce a fare magistralmente country music anche con brani non country (Smoke Rings In The Dark, Man To Man) o meglio a trasformare in country music anche ciò che non lo è (Runaway), cosa comunque non da poco.
Attesissimo e accolto da grande applauso, Gary Allan sale sul palco vestito con lo stesso gessato sfoggiato sulla cover di Smoke Rings ma senza cappello. E’ belloccio, come da fotografie ufficiali, ma più basso del previsto. La differenza in positivo la fanno il portamento, e naturalmente la voce: fascino, intensità ed una misurata nasalità in un contesto stilistico decisamente più tradizionale della Evans.
La band è sempre di sei elementi ma con una chitarra in più e la vocalist in meno. Buon segno.
I risultati si sentono subito perché si parte da lontano con Living In A House Full Of Love e Send Back My Heart.
Seguono i pezzi forti Smoke Rings e la title track dell’ultimo CD Alright Guy che convince meno ma l’atmosfera è positiva, dunque quanto mai tollerante. Il vuoto tematico che sta tra cuori spezzati e cerchi di fumo nel buio viene riempito con naturalezza da una vivace versione di I’ll Just Stay Here And Drink e dalla bottiglia di birra stabilmente accomodata sul vassoietto avvitato all’asta di microfono, ma le citazioni non sono finite perché il nostro ci regala una entusiasmante Swinging Doors ed una superba Her Man.
Sarebbe tutto perfetto se i suoni dell’impianto assecondassero la qualità della musica. Ma lo show continua e si tocca il cielo con una Loving You Against My Will resa inaspettatamente meglio che su CD: una solida front line delle tre chitarre a dettare e riempire la ritmica, l’ipnotismo della voce a creare un’atmosfera struggente, quasi onirica prima che il ritornello risolva il contrasto dei sentimenti, gli echi di fondo costruiti dalla steel che si intreccia con la chitarra elettrica e si impadronisce poi di un finale che vede il pubblico in piedi a spellarsi le mani e a danneggiarsi le tonsille.
Ci si rilassa per un sensibile calo di tono su un paio di brani nuovi, Man To Man appena discreta e Man of Me, quantomeno discutibile, e poi finalmente la canzone che aspettavo dall’inizio, quella It Would Be You che non smetterò mai di celebrare come una delle migliori, per i miei gusti. Lo strascico finale di steel afferra letteralmente cuore e dintorni, li sbatacchia, li frulla e li rimette bene o male al loro posto solo con l’ultima nota. E maledizione agli svizzeri che pretendono di stare sempre seduti e protestano se ti attardi in piedi davanti a loro!
Il fiddle imperioso di Right Where I Need To Be riporta ad una dimensione più ritmica per il finale di concerto mentre il bis è affidato ad una Runaway sempre divertente ma un po’ carente nel sostegno fondamentale del coro. E con quella, Gary Allan ci lascia tra applausi e ululati a prepararci già mentalmente a Collin Raye. Ci lascia appagati e più che soddisfatti con solo qualche perplessità sul nuovo CD che ad un ascolto completo, salvo pochissime eccezioni (What Would Willie Do, per esempio, è spassosa oltre che strepitosa, ma è di Bruce Robison), sembra allontanarsi dalle matrici tradizionali per addentrarsi in meandri meno definiti. E questo è un brutto segno per noi che cerchiamo certezze.
Un Collin Raye in buona forma emerge da una cortina di voci registrate dal passato: JFK, Martin Luther King, Jesse Jackson che ci ricordano di aver avuto un sogno e di averci provato. Collin ci crede e non smette di dircelo con le sue canzoni, quelle ‘impegnate’ e quelle sentimentali perché ci ha spiegato in conferenza stampa che una canzone è bella ed è ricordata se tocca in profondo le corde delle emozioni. Non possiamo dargli torto, noi popolo del country, e per questo lo rispettiamo fortemente malgrado qualche eccesso di zucchero nei testi.
Sul palco della Country Night quest’anno Collin Raye ha offerto un ampio excursus del suo ampissimo repertorio, comprimendo in diverse medleys anche quattro brani per volta. Mai calando di tono, di ritmo e di energia e spaziando, tra vecchio e nuovo, tra new country ballabile (Anyone Else, in apertura, My Kind of Girl), country classico (Someone You Used To Know, Man of My World, If I Were You, What The Heart Wants, The Gift), ballatone sentimentali (In This Life, That Was a River, One Boy One Girl, Dreaming My Dreams With You, Love Me), nuove proposte (i singles Ain’t Nobody Who’s Gonna Take That From Me e Couldn’t Last A Moment che nel ritornello riprende lontani echi Motown), ‘impegnate’ (Little Rock, Not That Different) ed un po’ di soft rock (She’s all Mine, I Want You Bad).
Per farsi poi prendere la mano dall’entusiasmo, nel bis, e trascinare anche gli svizzeri sulle sedie per versioni vibranti di Hot Legs e Brown Sugar (!). Ma a quel punto non lo fermava più nessuno. Ha dovuto mettercisi il gelido Jurg, MC ufficiale della Country Night, per farlo andare via tra lanci di fiori e di asciugamani (molto) sudati. Avete mai visto una rock star che non vuole andarsene dal suo pubblico? Be’, gente, anche questo è country music.
Fabrizio Salmoni, fonte Country Store n. 60, 2001