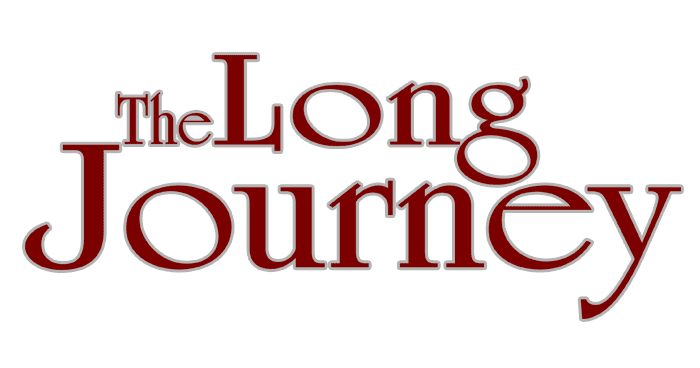Deryl Dodd è un personaggio di cui è importante parlare, per la sua musica, le sue canzoni, il suo credo artistico e anche per la sua vicenda personale, così fondamentale.
Deryl viene dal Texas, nato in un paesino chiamato Comanche cresce in una famiglia in cui musica e religione sono due valori fondamentali.
Le prime esperienze musicali si consumano proprio in questo ambiente fatto di sermoni tenuti dal nonno pastore pentecostale, ma anche di tanta musica gospel e bluegrass.
All’età di sette anni Dodd suona già la chitarra, a tredici impara a pizzicare il banjo e a sedici la pedal steel. Frequenta il college a Waco e in quegli anni diventa una sorta di star locale esibendosi nei club della cittadina, è in questo periodo che la sua volontà di intraprendere la carriera di musicista si consolida definitivamente.
Si trasferisce a Nashville nel 1991 e dopo soli sei mesi ottiene il suo primo vero lavoro come chitarrista nella band della giovane Martina McBride e con lei parte per una lunga tournee come opening act di Garth Brooks.
Le sue capacità vocali, il suo modo di suonare e presentarsi al pubblico viene notato dai dirigenti della Columbia che gli offrono un contratto discografico che nel 1996 gli regala il disco di debutto One Ride In Vegas il cui singolo That’s How I Got To Memphis scala le classifiche con velocità portando il nome di Dodd all’attenzione dei media.
Succede tutto molto e forse troppo rapidamente per un ragazzo texano fondamentalmente timido e restio a parlare troppo di sé piuttosto che della sua musica.
Ci vuole un po’ perché Deryl si abitui a questo nuovo tipo di vita, fatto di continua promozione presso i media ma il suo amore, il desiderio di suonare e cantare lo convincono a riprendere la sua attività e così nell’ottobre del 1998 viene pubblicato il secondo self titled album Deryl Dodd.
Un disco che ripropone con successo lo stile del texano all’attenzione dell’industria discografica e del pubblico. Buoni riscontri per un CD che conferma le impressioni dell’esordio, canzoni di qualità, dal gusto tradizionale interpretate con grande sentimento. Poi accade l’inaspettato.
Durante gli ultimi mesi del 1998 Dodd comincia a soffrire di un pesante affaticamento, cosa che lì per lì non desta molte preoccupazioni; col passare del tempo i sintomi si fanno più pesanti, fatica a sollevare le braccia sopra la testa e numerose bronchiti mettono spesso in crisi la voce del cantante. Nel febbraio del 1999 dopo una infezione interna all’orecchio arriva la notizia che avrebbe sconvolto la vita dell’artista: una diagnosi impietosa di encefalite virale, malattia che colpisce il sistema nervoso centrale.
Per fortuna la scoperta fatta in tempo, impedisce la crescita del male ma i danni subiti dal fisico restano comunque rilevanti. La convalescenza potrebbe durare mesi o anche anni, nessuno può dire se la ripresa potrà essere piena e in grado di consentire a Dodd di vivere una vita normale, figurarsi la carriera di cantante.
Tante domande e nessuna certezza, ma già in quei giorni la convinzione e la volontà di farcela a qualunque costo e per quanto lunga sarebbe dovuta essere l’attesa. 18 mesi passati a curarsi e ristabilirsi completamente con l’obbiettivo di tornare in pista, con l’esempio di Lance Armstrong che proprio in quel periodo torna alle corse e stravince il Tour De France.
Finalmente nell’estate del 2000 Deryl si sente pronto a ricominciare, chiama i componenti della sua vecchia band, riprende in mano la chitarra e comincia a esercitarsi su cose che fino a due anni prima gli riuscivano istintivamente. Una nuova attitudine verso la vita e verso la musica, chiede ed ottiene di essere spostato dalla Columbia alla affiliata ma minore Lucky Dog proprio per poter lavorare con più libertà e così nel 2002 la rinascita di Dodd si completa con l’uscita di Pearl Snaps un disco che è lo specchio fedele della maturazione e della forza d’animo dell’artista.
Anche questa volta fedele al sound classico, al credo artistico che lo pone alla ricerca di pezzi che parlino al cuore del pubblico. Ottima musica che ci insegna come bello può essere il compromesso tra nuovo e tradizionale. Ballate lente di grande intensità emotiva si alternano a honky tonk ironici e scherzosi, come nel caso del primo singolo Honky Tonk Champagne.
Quattro pezzi presi dai primi due album per fare da ponte tra il passato e la nuova carriera che il nostro Deryl si appresta a ripercorrere con nuovo entusiasmo, tra questi la più significativa sembra proprio essere One Ride In Vegas un vero e proprio manifesto di come l’amore per qualcosa che si desidera fare può far superare qualunque ostacolo. Un disco che ci fa riscoprire un artista eclettico che guarda al panorama musicale con mente aperta e pronto a ricevere contaminazioni di diversa ispirazione, mantenendo ferma la coscienza delle proprie radici culturali.
Ecco allora Cows dal sapore blues, Sundown una cover di Gordon Lightfoot, On Earth As It Is In Texas omaggio alla sua terra e la finale Where The River Flows dal gusto decisamente gospel-bluegrass.
Un lavoro dietro al quale c’è un anima, quella forte genuina e sincera di un ragazzo semplice ed onesto che da subito ha rinunciato al ruolo di star, ha vinto battaglie ben più importanti e con evidente entusiasmo si è rilanciato all’inseguimento del suo sogno. Tutto questo l’ho ritrovato incontrandolo e conoscendolo di persona, una chiacchierata di mezz’ora nel centro di Nashville che mi piace presentarvi così come si è svolta senza tralasciare nulla.
Come ti senti ad essere tornato sulle scene musicali?
Sono felice, mi sento come rinato. La cosa che mi ha fatto più piacere è l’aver incontrato molta gente che mi ha chiesto cosa fosse successo in questi anni di assenza e cosa avevo in progetto per il futuro. Mi riconoscevano ancora, erano interessati a me e al mio lavoro nonostante il periodo di inattività, mi dicevano che gli ero mancato. A me piace raccontare la mia vicenda, la malattia e come sono guarito e tornato a fare quello che facevo prima.
Ho letto che durante la malattia, Lance Armstrong e la sua storia, sono state di grande ispirazione per te. Credi di poter rappresentare lo stesso per chi si trova nelle condizioni in cui ti sei trovato tu?
Credo di sì, è per questo che appena posso raccontare la mia storia lo faccio volentieri. Nei giorni in cui mi trovavo in ospedale, guardando spesso la televisione, ho potuto seguire le imprese di Armstrong. Anche lui aveva dovuto smettere il suo lavoro a causa di una grave malattia, aveva lottato, era guarito ed era riuscito non solo a tornare in bicicletta ma addirittura a vincere il Tour De France.
La sua figura mi ha ispirato molto e quando sono guarito ho pensato subito che anche la mia potesse essere una storia in grado di ispirare altra gente. Sono convinto che sia importante per qualcuno sapere che altri ce l’hanno fatta e sono tornati alla vita.
Nuova vita e finalmente un nuovo album dal titolo ‘Pearl Snaps’, come hai lavorato a questo disco? Sei contento del risultato raggiunto?
Direi di sì. Il mio approccio alla musica è estremamente semplice, genuino e onesto.
Le grosse case discografiche di Nashville hanno un modo di lavorare ai dischi che tende ad ottenere un prodotto perfetto soprattutto dal punto di vista del lavoro minuzioso svolto sui suoni. E’ così che lavorano ed il risultato ovviamente trova grande successo tra il pubblico.
Io cerco un tipo di musica che abbia un’anima, non mi importa se ci sono alcune imperfezioni o qualche errore, quello che mi interessa è che sia musica in grado di suscitare emozioni proprio perché nata da forti sentimenti. Un tipo di musica che poi è quella che ascoltavamo nei dischi con cui siamo cresciuti, non voglio suoni troppo perfetti che facilmente risultano stereotipati, la vita reale non è mai perfetta e credo che il sound della vera musica debba rappresentare, anche sotto questo punto di vista, la realtà.
Per questo e con questo intento ho riunito un buon gruppo di musicisti che mi aiutasse ad esprimere al meglio quello che volevo dire con queste canzoni, con questa musica. Vorrei che la gente ascoltandolo pensi che si tratta di un disco diverso dagli altri, magari meno alla moda ma comunque sincero con un anima.
Ti ha aiutato in qualche maniera l’aver cambiato casa discografica ed essere passato ad una etichetta più piccola rispetto a quella dei tuoi primi due album?
Esattamente, non avevamo le stesse possibilità economiche e altri vantaggi che può dare una major ma si sa che se vuoi guadagnare qualcosa da un lato, devi rinunciare a qualcos’altro.
Io sono convinto del fatto che se credi in ciò che fai e ci lavori duramente riesci ad ottenere buoni risultati, magari ci vorrà più tempo ma arrivi comunque.
Non potrei mai vendermi a qualcuno per poter essere una star, non ci riuscirei proprio. E’ così che la vedo, tutti dobbiamo piegarci a qualcosa per far sì che certe cose succedano ma quello che voglio è rimanere il più possibile genuino andando avanti con la mia carriera. Così ha fatto Willie Nelson, Frank Sinatra e tutti i grandi che rimarranno per sempre nella storia della musica. Essere onesti con il proprio cuore, è così che la vedo.
Quali sono state le influenze o quale l’episodio che ti ha spinto a pensare di voler intraprendere questa carriera?
Sono cresciuto in una famiglia in cui la musica ha sempre occupato un posto di grande importanze. Sia mia madre che mio padre cantavano e suonavano, frequentavamo molto l’ambiente della chiesa. Mio nonno infatti era un pastore e la musica aveva un ruolo di primo piano durante le nostre funzioni, si trattava di classici del così detto southern gospel e bluegrass. Così fin da piccolo ho potuto vivere a contatto con la musica, ogni strumento che avevamo in casa era qualcosa che volevo prendere e suonare, avevamo le chitarre di mio padre e anche un piano.
Si ascoltavano le trasmissioni alla radio e poi si cercava di suonarle a orecchio senza bisogno di spartiti da leggere. Col passare degli anni ho ovviamente imparato a suonare la chitarra e imparavo canzoni da cantare. Soprattutto durante gli anni del college la mia passione ha avuto una svolta. Era ancora un hobby ma per me diventava sempre più importante, gli amici mi chiedevano di cantare per loro, alle feste, piano piano ero diventato una specie di star nell’ambiente scolastico, anche perché non erano in molti quelli che suonavano e cantavano.
Si radunavano amici, si chiamavano le ragazze e organizzavamo feste in cui io mi esibivo. Poi una sera andai con un gruppo di amici in un bar ristorante dove c’era anche un musicista dal vivo. Ad un certo punto i ragazzi seduti ai tavoli cominciarono a chiamarmi a gran voce dicendo cose del tipo “ Vogliamo Deryl Dodd a cantare!”. Io facevo segno di stare zitti, sai sono un tipo ancora abbastanza timido. Comunque, chiesi il permesso al tipo che stava suonando, presi la chitarra e mi misi a cantare qualche canzone, alcune che avevo scritto io e un paio di Gorge Strait, era il 1984 o 85…Alla fine la gente sembrava impazzita e così il padrone del locale mi offrì di tornare a suonare dal vivo per altre 30 serate pagandomi 25 dollari.
Lui fece una fortuna perché per sei mesi il locale fu sempre gremito mentre io continuavo a prendere i miei 25 dollari suonando tutta la sera, allora non ci facevo per niente caso, non mi interessavano i soldi, ciò che mi importava era esibirmi di fronte ad un pubblico.
Dopo le esperienze giovanili sei venuto a Nashville e hai cominciato a suonare in situazioni sempre più importanti. Hai anche partecipato a tournee con Garth Brooks, come erano quegli anni?
Sì quello fu in pratica il primo lavoro che ottenni una volta arrivato in città. Ero nella band di Martina McBride che in quegli anni seguiva Garth aprendo i suoi concerti.
Da quella esperienza ho imparato sicuramente molte cose, era la prima volta che mi trovavo di fronte a migliaia di persone, girammo gli stadi di tutto il paese, fu un grande inizio.
Poi ho avuto la possibilità di trovarmi a stretto contatto con una star del calibro di Brooks e ho potuto conoscerlo e vedere come si comportava, la sua professionalità, le sue intuizioni, la cortesia e la capacità di ascoltare.
C’è un motivo per cui è arrivato a quei livelli, molti artisti diventano delle star solo grazie ad una hit che vende tanto, Garth è una macchina, un artista dai mille volti, una persona brillante che ama la musica e la vita e sa come toccare il cuore del pubblico e come intrattenere.
Durante quella esperienza ho cercato di studiare qualche segreto, senza cercare di voler essere qualcun’ altro ma ho imparato molto su come lavorare in questo ambiente. Soprattutto però è stato importante essermi esibito di fronte a così tanta gente, questo mi ha insegnato come comunicare con il pubblico.
Ascoltando i tuoi dischi si sente subito che il tuo è un country moderno ma fedele ai suoni tradizionali, è questo il tuo intento?
Totalmente. Credo che la musica country evolva col passare degli anni, dei decenni. Una musica che è sempre nata dalla gente comune, dagli agricoltori, dagli abitanti delle campagne.
Oggi sicuramente la vita è cambiata e di conseguenza anche le canzoni sono cambiate e non possono essere più quelle di allora.
Io sono cresciuto ascoltando quella musica ed inevitabilmente ne sono stato influenzato, ecco perché il mio resta un sound che tende allo stile tradizionale.
Nello stesso tempo non dimentico di vivere in un’era in cui comunichiamo via internet, non posso parlare delle stesse cose, i gusti e le abitudini sono cambiate. Mi viene in mente Dwight Yoakam, credo che lui sia un altro bell’esempio di artista che sa da dove viene e resta fedele alle sue origini e contemporaneamente ci mette un po’ di quel rockabilly twist che piace a giovani e meno giovani di oggi.
Torniamo al nuovo disco ‘Pearl Snaps’, il primo singolo si intitola ‘Honky Tonk Champagne’, come è nato questo pezzo?
Quando vivevo in Texas la Miller faceva una pubblicità il cui slogan chiamava la sua come lo champagne delle birre. Un giorno stavo parlando di questo con il mio produttore Shane Decker, fu proprio a lui che venne in mente il titolo della canzone. Ci segnammo quella frase che poi è diventato il titolo del pezzo.
Non la scrissi subito, poi una sera mentre viaggiavo sull’autostrada attraversando Amarillo tra un concerto e l’altro, mi fermai a pensare a tutti quei camion con diciotto ruote che passavano ed a come facessero quei camionisti a sopportare quella vita. Pensai che gli aiutava il pensiero di raggiungere il prossimo honky tonk per un bicchiere del loro champagne.
E’ un pezzo spiritoso che in qualche modo mi è stato ispirato anche da alcune canzoni di Hank Jr. che possiedono questa attitudine al puro divertimento. Se poi la Miller mi volesse offrire un ingaggio pubblicitario, sarei ben felice.
Vorrei approfondire altre due canzoni dell’ultimo disco. La prima è ‘Where The River Flows’, un pezzo in stile bluegrass come già ‘John Roland Wood’ nel precedente ‘Deryl Dodd’. Come è nato e che rapporto hai con la musica bluegrass?
E’un pezzo che nasce da una doppia influenza, bluegrass e gospel music. Erano le sonorità che si ascoltavano nella chiesa del paesino da dove vengo, mandolino, banjo, chitarra e violino erano gli strumenti che accompagnavano canzoni come I’ll Fly Away e altre del genere.
Ho seguito la musica bluegrass, compravo i dischi di Flatt & Scruggs, sono impazzito per Dueling Banjos e tutt’oggi amo molti artisti che suonano questo genere.
Questa canzone l’ho scritta pensando a mio nonno. Era nato nel 1910 e spesso parlava di quegli anni e di quella realtà, un’epoca che mi affascina moltissimo, quei valori e quella semplicità d’animo. Mi è venuto subito in mente il fiume, una cosa pura che ha in sé anche un qualcosa di spirituale, un luogo dove ci si abbevera e riposa. Posso dire che parole e musica vengono dagli insegnamenti che mi sono stati tramandati dalla mia famiglia.
Come è nata l’idea di inserire ‘Sundown’, una cover di Gordon Lightfoot?
Sono stato teen ager durante gli anni 70, un periodo in cui andavano molto artisti folk\rock come Janis Joplin, James Taylor, Lynyrd Skynyrd e così via.
Io amavo la musica di Lightfoot, non mi bastava mai ascoltare il suo sound così particolare. Quando fu il momento di registrare il mio secondo album, pensai che sarebbe stato bello incidere un suo pezzo per il disco, provammo prima a suonarla dal vivo per capire come reagiva il pubblico. La risposta fu buona e così la registrammo.
Purtroppo la mia casa discografica di allora decise di togliere il pezzo dal prodotto finale perché già altri artisti dell’etichetta avevano cover nei propri dischi. I dischi promozionali inviati alle radio prima dell’uscita nei negozi contenevano ancora la canzone. Senza nessuna promozione i dj cominciarono a far passare la mia versione di Sundown ricevendo consensi dagli ascoltatori. Poi anche le radio furono costrette a interrompere la messa in onda del pezzo che avrebbe causato problemi legali alla casa editrice.
Nel momento di scegliere il materiale da inserire nel nuovo album, ho voluto che Sundown entrasse a tutti i costi in scaletta, sperando che piaccia ancora.
C’è una tua canzone che amo particolarmente, è ‘On Any Given Day’ e fa parte del tuo secondo disco. Qui l’influenza è più sul swing, sei davvero così di larghe vedute riguardo alla musica?
E’ vero, amo ascoltare diversi generi musicali e trarre ispirazioni diverse da essi.
Questa canzone ha quel sound di swing lento che si sposa benissimo con il testo romantico e sentimentale.
Molte persone amano questa canzone e questo mi fa pensare al mio rapporto con l’industria musicale. Ho scritto canzoni e le ho incise pensando che sarebbero piaciute alla gente, ma spesso la realtà del music business è diversa.
Ero convinto che On Any Given Day sarebbe potuto essere un ottimo singolo ma mai i dirigenti della casa discografica non mi hanno parlato di un’ ipotesi del genere.
Comunque è un pezzo che considero un classico, capace di emozionare il pubblico, molta gente si commuove quando la ascolta e anche io a volte mentre la canto. E’ bello quando una canzone può fare questo.
In ‘Pearl Snaps’ hai inserito anche quattro canzoni dai precedenti due album. Come si inseriscono nel progetto?
Sono state messe in questo album in parte perché sia A Bitter End sia One Ride In Vegas hanno avuto un buon successo radiofonico negli anni passati e questo mi permetteva di farmi riconoscere dal pubblico che da due anni non aveva mie notizie e poteva aver dimenticato il mio nome.
One Ride In Vegas è un po’ la mia canzone, è diventata quasi profetica. Pensavo alla vita di un mio amico che era un rodeo cowboy, i lunghi viaggi, le notti nella stanza di un motel, i sacrifici per cercare di arrivare ed emergere.
Ora è diventato il tema della mia vita, c’è una frase che si ripete nel testo e che dice “…ci vuole più di quello che pensava di poter dare, ma resiste e continua…”. Oggi che sono di nuovo in pista, sento che potrei dare ancora tanto, non mi spaventano i sacrifici e la fatica, certo guardando indietro chiunque potrebbe chiedermi come ho fatto e cosa mi ha spinto a continuare…direi che l’amore per la musica mi ha fatto andare avanti, non ne ho mai fatto una questione di soldi, non ne potrò mai guadagnare tanti, si tratta di un sentimento profondo, una cosa spirituale.
Roberto Galbiati, fonte Country Store n. 65, 2002