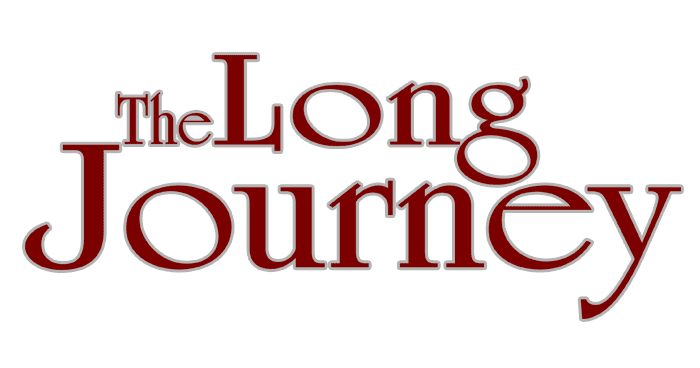Una delle ultime cover dedicate da Guitar World a Stevie Ray Vaughan è quella del settembre 1988; l’intervista a cura di Bill Milkowski, senior editor della rivista e nome sicuramente prestigioso nell’ambito dell’editoria chitarristica, non verte tanto sulla musica del bluesman texano, quanto sul suo stato di salute. E’ stato proprio grazie a quell’articolo che in molti hanno saputo che Stevie Ray Vaughan era appena uscito da una clinica dove avevano tentato, e sembra con successo, di disintossicarlo non solo da un uso massiccio di cocaina, ma anche da un alcolismo ormai datato negli anni, che aveva minato profondamente lo stato psico-fisico del chitarrista. Sicuramente una grande intervista, che lasciava però interdetti per alcune valutazioni di Milkowski il quale, nella presentazione del suo articolo scriveva: «Stevie Ray Vaughan ora può suonare il blues».
Il blues è stato anche rivoluzione e trasgressione, e la valutazione del giornalista americano è apparsa un po’ forzata; naturalmente, da un punto di vista umano, il recupero fisico di Vaughan non può che essere accolto come una notizia positiva, eppure già da allora attorno a questo recupero si sviluppava un’aura di santificazione che è poi proseguita nel tempo fino alle dichiarazioni più recenti di Vaughan, rilasciate in occasione dell’uscita del nuovo album in studio, In Step. Se Milkowski aveva forse esagerato lo stesso Vaughan non scherza affermando e confermando il suo recupero ed una sorta di rifiuto, tra l’altro giustissimo, per gli anni in cui era stato ‘vittima’ di alcool e droghe varie. Semmai è discutibile il modo in cui oggi il chitarrista parla di rinascita, e si fa voce di una sorta di crociata contro la trasgressione riproponendo un problema ormai annoso, scatenato già negli anni sessanta dal noto processo contro Mick Jagger e Keith Richards in cui le due rock star furono condannate più per il fatto di essere dei simboli per i giovani che per l’uso di droghe.
Entrare in questo tipo di argomentazioni è sempre pericoloso e può dare adito ad interpretazioni sbagliate e valutazioni scorrette, però repentini pentimenti e successive crociate anti-droga da parte di alcuni musicisti lasciano affiorare anche dei dubbi di carattere politico, soprattutto se arrivano da personaggi ‘pubblici’ americani in un momento di evidente restaurazione. Non è certo il caso di indagare sul perché del coinvolgimento di Stevie Ray Vaughan con l’alcool che a detta dello stesso chitarrista risale all’età di sei anni, o dell’avvicinamento alla droga: sono problemi da sviluppare in altre sedi; sta di fatto che si celebra soltanto l’uscita dal tunnel senza mai dichiarare, sottolineare e chiarire il perché dell’iniziale abbandono. Musica e droga sembrano camminare di pari passo; almeno la tradizione (non solo) del rock porta a questa valutazione.
Che la creatività cammini con la droga è un aspetto sicuramente ancora non ben chiarito, ma certo, almeno moralmente, una crociata a favore della ‘pulizia’ di anima e di corpo fatta da Vaughan può lasciare dei dubbi perché oggi lui è riconosciuto come uno dei migliori musicisti di blues bianco e questo suo status è indubbiamente legato alla droga, a quegli additivi più o meno chimici che gli hanno permesso ad esempio di sopravvivere a tour interminabili, strazianti; forse l’uso di droga e alcool è il prezzo che troppi musicisti hanno pagato al successo sottostando a leggi terribili che regolano lo show business, ma anche questo non viene detto e Stevie Ray Vaughan, come tanti altri, diventa il simbolo positivo della purificazione dopo aver pagato volontariamente e di persona un prezzo altissimo per il proprio successo. Ed allora le loro prediche non convincono, o comunque anche se lette sotto un segno positivo, lasciano dei sospetti perché arrivano da personaggi che certo non si sono tirati indietro quando si trattava di sopravvivere grazie alle droghe per ottenere denaro e rispetto, fama e riconoscimenti, benessere ed esplosione dell’ego: in sintesi, il successo ottenuto rispettando le regole del business della musica scavalcando sentimenti e condizioni fisiche, sostenute artificialmente. In sintesi, e la storia del blues lo insegna, anche Stevie Ray Vaughan sembra aver chiuso a suo vantaggio quel contratto col diavolo di cui già ci parlava Robert Johnson, uno che probabilmente non si è mai tirato indietro. Il blues è anche rivoluzione e trasgressione ed allora arriviamo a Vaughan, che del blues ha pienamente interpretato queste regole certo non scritte ma ampiamente praticate.
Nel non troppo lontano 1983 esordiva con un Texas Flood che lo imponeva immediatamente all’attenzione di pubblico e critica grazie ad una tecnica chitarristica grezza quanto efficace e nuova, una tecnica che portava certo a citare Hendrix, Winter ed un gruppo di ormai citatissimi bluesman di colore tra cui spicca senz’altro Buddy Guy. Ma anche il suono era coraggioso, coraggiosa la scaletta dei brani con classici come Testify già cavallo di battaglia del primo Hendrix, Mary Had A Little Lamb di Buddy Guy, e poi brani dello stesso Vaughan che rendevano giustizia ad un chitarrista di ventotto anni che suonava in giro per gli States da quando ne aveva poco più di tredici.
Nato a Dallas nel ’55 e con un fratello maggiore di nome Jimmie ben conosciuto per essere il chitarrista dei Faboulous Thunderbirds, Stevie Ray non poteva che seguire le pesanti orme del fratello e quindi inserirsi in quel filone blues bianco che nel Texas è sempre stato particolarmente stimolante ed ha dato i giusti stimoli a gente come Johnny Winter, Billy Gibbons degli ZZ Top, Bugs Henderson ed Eric Johnson. A sedici anni già dedito all’alcool e probabilmente alle droghe, Stevie Ray comincia a suonare in piccoli club a ritmi massacranti, arrivando a suonare almeno in tre locali diversi per notte. Come insegna la storia del blues o del rock-blues, il ‘piccolo’ Ray forma una piccola band e si va così dai The Cobras ad un trio acustico, i Triple Thest Review, con cui oltrepassa con alterni risultati i confini del Texas; certo prima c’erano state svariate indicazioni musicali, ma il blues letto anche attraverso l’insegnamento di Hendrix era sempre stata la sua unica passione.
E’ dell’80 l’idea di mettere in piedi un gruppo che dia sicurezza, e naturalmente Steve Ray va a ripescare nel passato e trova, o meglio ritrova il bassista Tommy Shannon, con lui già nei The Cobras, e collaboratore di Johnny Winter. A completare il trio arriva Chris Layton, un batterista estremamente duttile quanto energico.
Con questa sezione ritmica denominata Double Trouble, Steve Ray Vaughan punta diritto al successo: esce dai confini texani, mette a punto il ‘tiro’ del trio girando su e giù per gli States, riesce a farsi notare e finalmente affronta la grande occasione. L’occasione non è tanto un concerto aperto a migliaia di persone ma la possibilità di suonare a New York ad una serata esclusiva in un noto locale, richiamo preferito del jet-set musicale.
Ad ascoltare Vaughan tra gli altri ci sono Ron Wood e Mick Jagger. Il nome di Vaughan comincia a girare nei posti giusti e nel luglio dell’82 troviamo i Double Trouble a Montreaux in Svizzera, prima apparizione del gruppo in Europa proprio a quella prestigiosa manifestazione che è il Montreaux Jazz Festival; Vaughan ancora non ha all’attivo prove discografiche, ma il successo della sua proposta è notevole, il suo blues appare immediatamente nuovo, sempre nei limiti in cui il blues lo può e potrà essere… sono nuovi i suoni, il fraseggio è personale, e dopo anni ed anni di stasi, dopo Clapton, Duane Allman, Johnny Winter, finalmente il concerto di Montreaux, dove Vaughan esegue una versione di oltre dieci minuti di Flood Down In Texas (ripresa con il titolo Texas Flood nell’omonimo album), presenta qualcosa di nuovo, di ‘giovane’ e fresco, presenta uno Stevie Ray Vaughan che ad oggi è l’ultimo musicista che abbia saputo trattare la materia blues, rapportandola al presente, inserendo stilemi che pur non togliendo nulla all’energia originale del blues, lo rendono più vicino al presente musicale.
Anche questa volta tra il pubblico c’è gente importante e con un potere non indifferente, David Bowie ad esempio, che dopo il concerto invita Steve Ray ad incidere alcune cose per il suo nuovo LP Let’s Dance. Il destino musicale è ormai segnato e nell’83 ecco finalmente Texas Flood, album densissimo, che comunica forti emozioni. A produrlo sarà lo stesso Vaughan, ma come le note di copertina chiariscono ampiamente, l’executive producer è John Hammond, il compianto produttore che aveva scoperto personaggi come Bob Dylan e Bruce Springsteen. La storia di queste incisioni non è mai stata molto chiara, ma sembra con una certa approssimazione che i nastri di Texas Flood dopo l’incisione definitiva siano stati missati in un periodo di tempo molto lungo e che da questa ‘elaborazione’ sia nato quel sound originale che caratterizza l’album. L’operazione di incidere e poi rifare totalmente i suoni (basso e batteria compresi) non è certo comune, eppure anche il live dell’86, Live Alive, ha subito un processo simile. In realtà ascoltando la versione di Flood Down In Texas dell’82 a Montreaux ci si rende conto di quanto fosse diverso il sound ottenuto dal vivo in quell’occasione in rapporto a quello che appare in Live Alive pubblicato nell’86 ma inciso nell’85.
Da buon bluesman, Steve Ray Vaughan non è un ipertecnico e non ama usare effetti, salvo un whawha e pochi altri aggeggi. Parlare della sua tecnica strumentale potrebbe essere riduttivo, il suo è un blues canonico e reinterpretato, costruito sul suono, sul timbro, ma che sempre si muove sulla pentatonica. Vaughan ha un vibrato energico ed una fluidità impressionante che lo porta con estrema facilità ad operare sulle corde basse, i suoi assolo sono istintivi e coinvolgono l’intera tastiera, anche se una delle caratteristiche è quella di ‘spezzare’ gli assoli con accordi o bicordi. L’uso della leva e l’uso progressivo del pollice sulle corde basse possono anche essere considerati come marchi di fabbrica, ma in verità quello che rende diverse le proposte di Vaughan è l’energia che riesce a mettere nel suo chitarrismo, una energia che si fonde perfettamente ad una eleganza musicale straordinaria.
Le corde che monta sulla sua chitarra sono durissime, si parte da un 0.14 per arrivare ad un 0.60; ultimamente le sue tre chitarre preferite montano invece corde che partono da 0.11 per arrivare a 0.58, questo per il lavoro in studio, dal vivo lo ritroviamo con calibri grossi come lo 0.12 o lo 0.13, i tasti montati sono i Jumbo e l’action è molto alta.
Va comunque detto che invece di essere accordate in MI le chitarre di Vaughan sono tutte accordate in Mib, quindi mezzo tono sotto, il che chiaramente va a giustificare quella specie di tronchi che monta come corde.
Anche se possiede svariate chitarre, i suoi strumenti preferiti sono tre Fender Stratocaster denominate: Number 1, Charley e Lenny. Number 1, lo dice il termine stesso, è la prima chitarra di Vaughan in ordine di importanza e preferenza, è una Strato del ’59 a cui solo recentemente il tecnico delle chitarre del texano ha sostituito il manico con un `pezzo’ del ’61, sempre proveniente da una Strato. Caratteristica di questo strumento è il ponte mancino che permette a Vaughan di avere sempre la leva sotto mano (parole sue, naturalmente).
Charley è invece una Strato bianca che monta pick-up Denelectro, mentre Lenny è una Strato del ’62 con un manico in acero. Sempre Strato è una rossa ‘innominata’ che ha il corpo dei primi anni sessanta ed il manico mancino del ’64. Infine, sempre tra le ‘innominate’, una Strato che monta un maple-neck (manico in acero) di una Telecaster. Naturalmente il set di Steve Ray prevede altre chitarre tra cui una Gibson ES – 335 del ’58, una National del ’28 ed una Gibson Charlie Christian con cui per la prima volta su vinile ha inciso delle parti slide sul recentissimo In Step. La doppio manico Denelectro con cui a volte si è esibito dal vivo e che aveva una tastiera di chitarra e una di basso, è stata recentemente elaborata ed il manico del basso è stato convertito verso un sei corde.
Parlare di amplificatori a proposito di Stevie Ray Vaughan è molto difficile, basti pensare che per le incisioni di In Step si è portato in studio ben 32 amplificatori per poi usare esclusivamente Marshall e Dumble. Questo fa capire l’ossessione vera e propria che Vaughan deve avere per il suono, un’ossessione però giustificata che gli ha permesso di ricreare (sicuramente più in fase di missaggio che durante le incisioni) un sound ‘vero’, ‘caldo’, un sound da locale, ma con qualche cosina in più, sicuramente un sound che ha caratterizzato la storia del blues e del rock-blues degli anni ottanta, un suono duro, un suono macho che conferma una tradizione purtroppo tradita anche di recente da personaggi che propongono una musica ed un suono quanto meno edulcorati, sicuramente falsi (vedi Robert Cray).
Ad oggi la discografia di Stevie Ray Vaughan non è certo ricca: quattro LP in studio ed un doppio dal vivo datato 1986. Dall’86 ad oggi un solo LP, In Step, che ripropone uno Stevie Ray a livelli di grande musica; malgrado siano pochi, tra i suoi lavori in studio c’è una costruzione profondamente diversa. I primi due LP Texas Flood e Couldn’t Stand The Weather (1984) sono tipiche incisioni da trio e quindi la chitarra sostiene i brani, la tessitura è affidata completamente alle costruzioni ed alle invenzioni del chitarrista texano.
I primi due album rappresentano forse la migliore tradizione del blues elettrico bianco; poi a partire da Soul To Soul il progetto sembra cambiare: sempre una musica da trio, con il ‘tiro’ del trio ma con l’inserimento di un tastierista, Reese Wynane, e del sassofono di Joe Sublett; il risultato è sconcertante, un album sicuramente diverso dai precedenti, più curato, forse più soft eppure ancora denso di un umore blues, ed un brano come Sexy What! sta a dimostrarlo.
L’episodio live tuttora vive una dimensione a sé: il suono, come già detto, non è quello ‘reale’ del live, perché la sala di registrazione con le sue alchimie l’ha trasformato. Arricchito o impoverito cosa importa, comunque Live Alive è un album discusso e discutibile, come discutibili possono essere non soltanto il missaggio, ma anche le sovraincisioni, le ‘correzioni’ che hanno tenuto in studio Vaughan per parecchi mesi. Discutibile in questo disco non è solo la scelta di intervenire pesantemente sui nastri, ma per i puristi del blues discutibile è una sorta di tradimento operato da Vaughan verso una musica che ancora oggi si nutre di istintività, di improvvisazione e tensioni emotive.
Durante tre anni passati nel tentativo di recuperare una disastrosa situazione fisica che molto spesso l’aveva portato molto vicino alla morte e poi nel tentativo di ristabilire un contatto con la musica, Stevie Ray Vaughan è tornato al disco con un In Step che lo riporta ai fasti di Texas Flood. Ma le cose sono cambiate nella struttura musicale voluta dal texano, ora la musica nasce non più per trio ma per quartetto e la chitarra di Vaughan non assolve più a quel lavoro di definizione del brano, ma, sostenuta dalle tastiere di Reese Wynans, affronta in parte schemi più liberi ed in In Step sin dalle prime note questo risulta evidente; è come se i brani avessero una loro autonomia musicale sulla quale Vaughan è libero di costruire non soltanto i suoi assoli, ma anche una tessitura armonica non più obbligata.
La differenza tra un trio ed un quartetto sta proprio nell’approccio che un chitarrista può avere: nel trio il ruolo di Steve Ray Vaughan era più preciso e determinante, quindi concentrazione, energia sempre costante, impegno massimo, risultati grandiosi (almeno nel suo caso).
Con l’arrivo delle tastiere a supportare una situazione armonica, anzi a definirla, l’intervento del chitarrista texano diviene meno essenziale in termini di costruzione musicale, ma più libero, se vogliamo più aperto, verso soluzioni diverse, nuove, verso sperimentazioni.
Certo il blues è una musica monolitica difficilmente interpretabile al di là di alcuni schemi collaudatissimi, ed anche In Step segue la direzione del blues bianco impostata ormai da anni ed anni, percorsa da moltissimi musicisti; il tentativo, peraltro riuscitissimo, di Vaughan è stato quello di operare una sintesi tra aspetti solo apparentemente lontani tra loro. Spesso non si considera Hendrix come un ‘aspetto’ del blues ed invece lui è stato un elemento nello sviluppo di questa musica; la sua originalità o genialità compositiva ha sempre avuto un grosso debito con il blues, e proprio studiando e riproponendo la musica di Hendrix Steve Ray Vaughan è riuscito ad intuire e focalizzare quegli elementi ‘grammaticali’ che sembravano essere prerogative dell’invenzione hendrixiana.
Oggi Vaughan rischia di essere considerato uno dei tanti eroi del blues bianco ormai da accantonare nell’attesa del nuovo `messia’, purtroppo le leggi del mercato e dello show business dettano queste soluzioni inumane, eppure anche se il personaggio Vaughan ormai è stato ‘digerito’, sfruttato e storicizzato, la sua energia non viene a mancare. Quel sapore hendrixiano, quelle tinte e quelle sfumature prese da Albert King, da Freddie King e una innata propensione verso il blues ed il rock, fanno di questo chitarrista texano una delle migliori espressioni nate negli ultimi anni.
L’influenza che Vaughan ha avuto su alcuni nuovi chitarristi di blues, ed anche di rock, è enorme, insostituibile, incalcolabile. Certo in un periodo caratterizzato da una corsa folle verso l’appropriazione di soluzioni tecniche sempre più complesse, e quindi verso una sorta di neo-virtuosismo, la pentatonica vaughaniana a molti potrà sembrare riduttiva, povera, eppure lui può essere senz’altro considerato come uno dei chitarristi blues tecnicamente più significativi, non solo per l’originalità del fraseggio e della costruzione degli assoli, ma proprio per l’aver portato la pentatonica verso soluzioni (o forse semplici spostamenti?) che hanno dato una sorta di nuovo idioma ad una musica immortale come il blues.
In Step chiude con un brano di Vaughan, Riviera Paradise, che risale all’84, ma solo adesso vede la luce, è un pezzo che cammina nella stessa direzione di Lenny (Texas Flood) ma porta Vaughan ancora più lontano, verso sentieri ambigui. Se Lenny era un omaggio a Hendrix, questo Riviera Paradise sposta completamente l’area d’azione del texano inserendo elementi spuri che offrono quasi un sapore fusion (!) al brano. Lo stesso Vaughan ha recentemente dichiarato che questo tipo di sonorità e questo tipo di ‘emozioni’ su di lui hanno un potere particolare, lo aiutano a guarire e, sempre a detta di Vaughan, hanno il potere di guarire anche altra gente; tutto questo in verità preoccupa non poco perché se aggiungiamo a queste considerazioni altre parole di Vaughan sull’amore per gli altri e sulla necessità di aiutarsi l’un l’altro, sorgono immediatamente alcuni dubbi sul suo futuro musicale, che nell’immediato prevede finalmente e fortunatamente un disco inciso assieme al fratello Jimmie, in cui i due faranno tutto da soli ‘esibendosi’ su tutti gli strumenti.
Che Jimmie fosse un pluristrumentista lo si sapeva da tempo, per Stevie Ray le cose saranno un po’ più difficili. Comunque il punto interrogativo rimane, Riviera Paradise sarà pure un episodio, ma quello che più preoccupa è la posizione quasi mistica che alcune parole di Vaughan lasciano intuire, e non vorremmo sinceramente che succedesse a lui quello che è già accaduto ad altri musicisti che una volta recuperati dal punto di vista dell’integrità fisica e dalla dipendenza psichica, hanno cominciato ad avere degli atteggiamenti ‘pastorali’ che in termini musicali si sono tramutati ben presto in sonorità dalle emozioni ‘deboli’.
Tra le dediche in copertina, in In Step c’è naturalmente quella a John Hammond e poi una frase: “Thank God that the elevator is still broken!”. Ogni interpretazione è possibile, ma soltanto il prossimo album di Vaughan darà una risposta.
Giuseppe Barbieri, fonte Chitarre n. 43, 1989