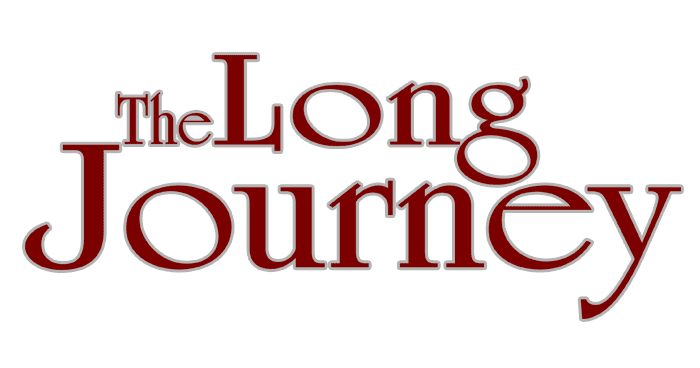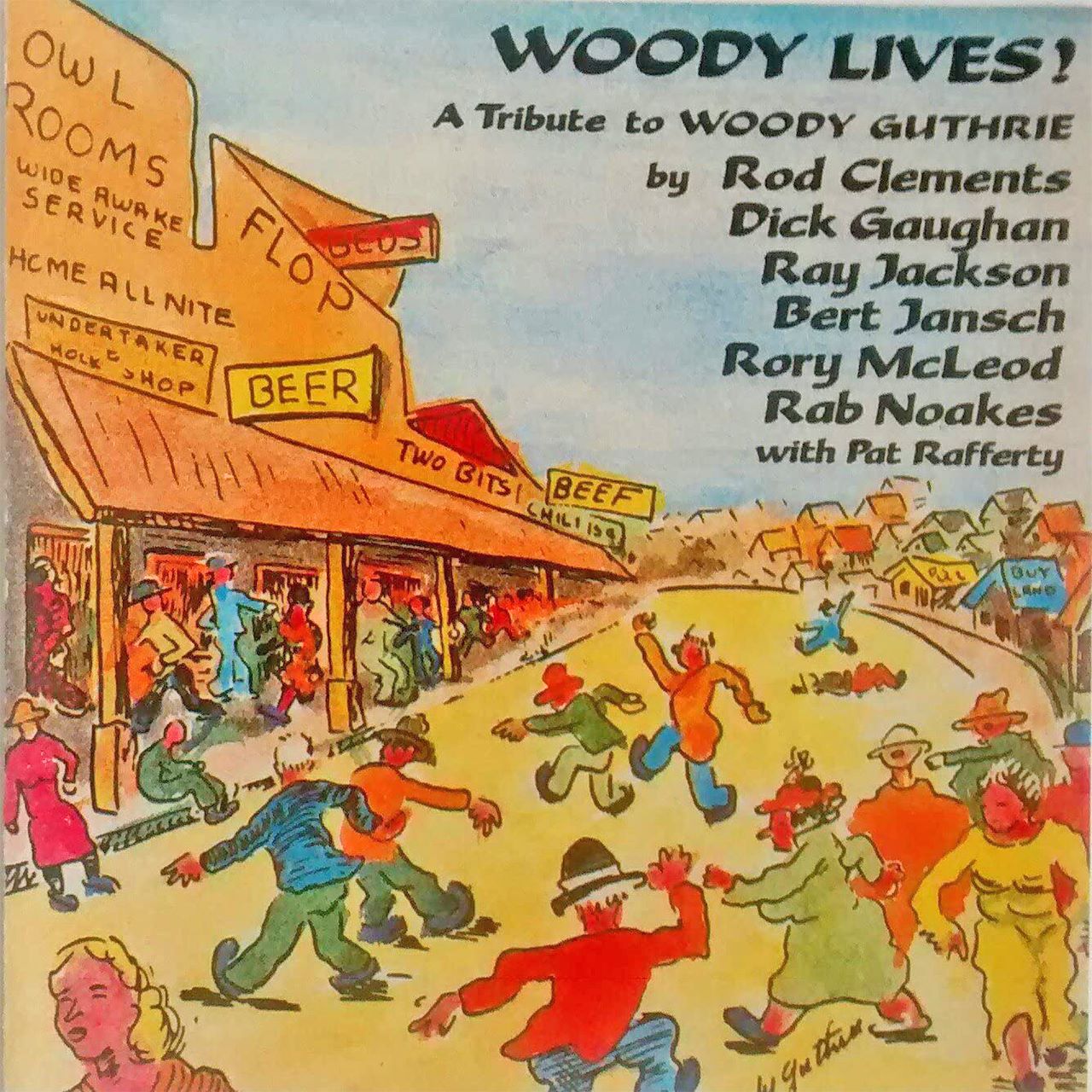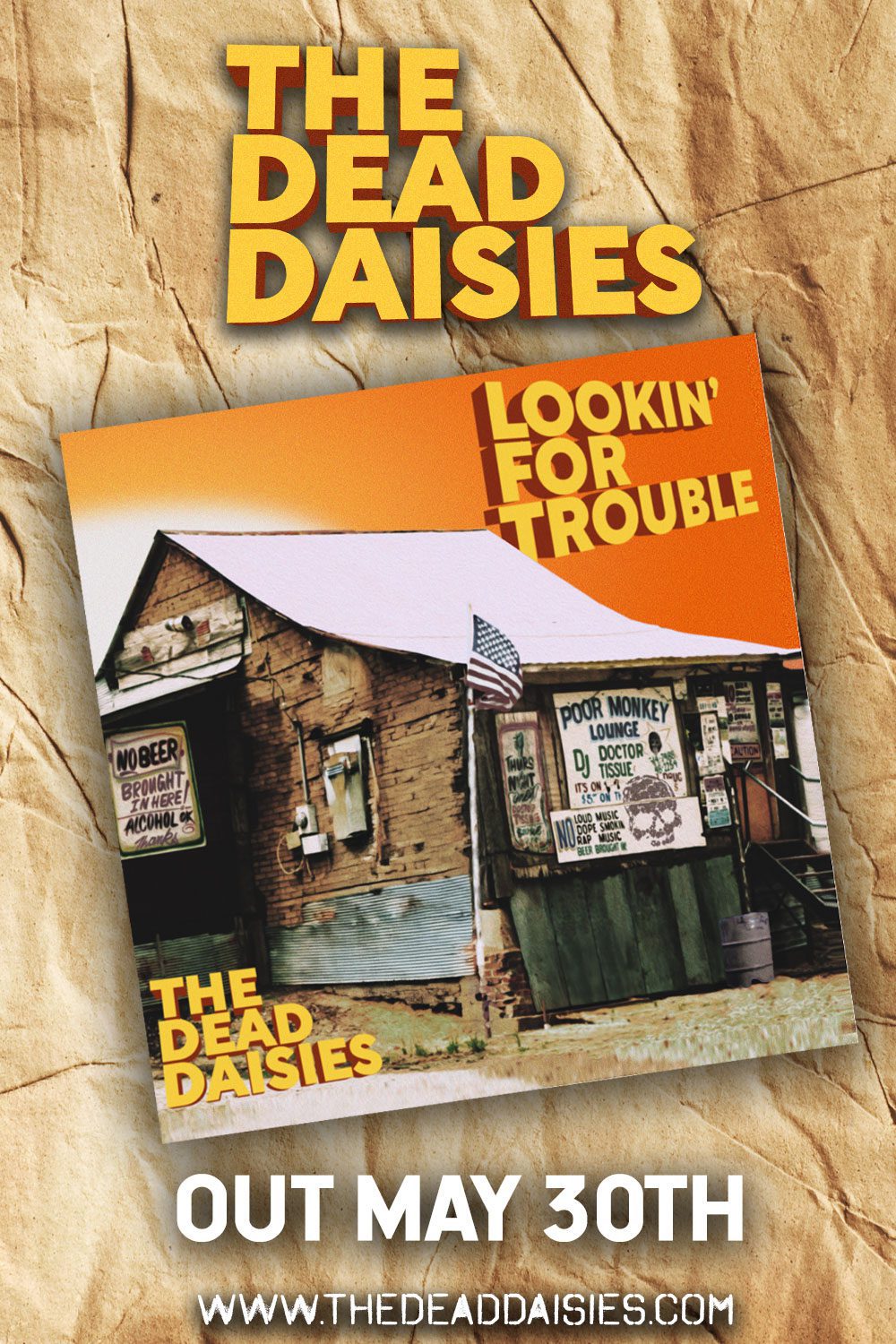L’uscita di A Vision Shared, tributo discografico della Folkways all’opera di Woody Guthrie, ci ricorda una volta in più la costante attualità di un personaggio che ha avuto un impatto enorme nel determinare stile e direzione della musica folk americana diventando il punto di riferimento di artisti come Pete Seeger, Bob Dylan, Ramblin’ Jack Elliot, Cisco Houston.
Trovarsi a parlare di Woody Guthrie può presentare una difficoltà iniziale apparentemente insormontabile: come si fa a spiegare, commentare, illustrare, introdurre qualcosa che, come la sua opera, si presenta alla prima occhiata ed al primo ascolto con tali caratteristiche di semplicità e di concreta evidenza da rendere così superflua qualunque altra parola di commento?
“Qualunque imbecille – scrive Pete Seeger nel 1961 nell’introduzione ad una raccolta di ballate di Woody (1) – è capace di complicare le cose, ma ci vuole genio per raggiungere la semplicità”. Intesa con tale disarmante chiarezza, la patente di genio non è senz’altro sprecata o attribuita alla leggera ad un artista come Woody Guthrie che per di più non ci ha solo lasciato una messe di canzoni, ma anche sostanziosi volumi autobiografici (Bound For Glory, Seeds Of Man) e centinaia di pagine di pensieri e riflessioni varie in parte pubblicate (Born To Win) il tutto condito da una gran quantità di disegni, sketches ed illustrazioni deliziosi e tutt’altro che irrilevanti.
Musica, letteratura e immagini dunque che si commentano e si connettono l’una all’altra, scoraggiando così in partenza l’opera di chi volesse mettersi a spiegare l’evidente. Il senso di queste righe allora è innanzitutto quello di un doveroso ed affettuoso omaggio ad un grande artista ed alla sua opera (in occasione anche, come vedremo, dell’uscita dell’album Folkways a lui in massima parte dedicato) nonché di invito ed incitamento, a chi ancora non l’abbia fatto, a leggere, ascoltare, ‘incontrare’ Woody Guthrie. Ma lasciamogli la parola.
“Mi sono calcato il cappello all’indietro” – dice Woody – “e mi sono incamminato verso ovest da Redding attraverso le foreste di abeti lungo la costa vagabondando di città in città con la chitarra appesa sulle spalle. Ho cantato nei bassifondi di quarantadue stati: la Reno Avenue di Oklahoma City, la Lower Pike Street di Seattle, il tavolo del giudice di Santa Fé, le baraccopoli infestate da mosche intorno alle discariche di rifiuti delle città. Ho cantato negli accampamenti che chiamano ‘Little Mexico’, nella parte lercia dei verdi pascoli della California. Ho cantato sulle chiatte di ghiaia della costa Est e lungo la Bowery di New York guardando i poliziotti dare la caccia agli ubriaconi di rum.
Mi sono chinato lungo la curva del Golfo del Messico e ho cantato fra il sale e il catrame di Port Arthur, fra gli operai dei pozzi e delle raffinerie di Texas City, fra i fumatori di marijuana di Houston. Ho seguito gli itinerari di fiere e rodei per tutta la California settentrionale, Grass Valley, Nevada City. Ho seguito le piste delle albicocche e delle pesche intorno a Marysville e le colline sabbiose dei vigneti di Auburn bevendo il vino fatto in casa dagli amici contadini. Ovunque, ho messo il cappello in terra e cantato per gli spiccioli.
A volte sono stato fortunato e mi sono trovato dei buoni lavori. Ho cantato alle radio a Los Angeles, e ho avuto lavoro da zio Sam per andare nella valle del fiume Columbia e registrare ventisei canzoni sulla diga del Grand Coulee. Ho inciso due album di dischi chiamati Dust Bowl Ballads per la Victor. Ho perso di nuovo la strada ed ho attraversato altre due volte il continente sulle carrozzabili e sui treni merci. La gente mi ha ascoltato nei programmi nazionali CBS e NBC ed ha pensato che fossi ricco e famoso, ed invece non avevo neanche un soldo in tasca al momento di riprendere il cammino (2).”
Che aggiungere?
La storia della sua vita, di quella che per noi conta, è tutta qui, in una sintesi che non manca di tratteggiare la sua concezione del proprio ruolo di ‘artista organico’ e dei suoi rapporti anche economici con l’establishment (zio Sam, la Victor, le radio): lasciamo ad altri di indagare sulle luci ed ombre di una vita privata certamente turbolenta ed intemperante con i suoi corollari di fallimenti coniugali e di numerosissima prole.
Manca semmai la storia della sua lunga battaglia con la malattia dì Huntington che lo inchioda per anni in un letto d’ospedale a New York fino alla fine, nel 1967, lasciandogli però ancora l’energia di reagire per l’ennesima volta all’ingiustizia con l’ultima canzone, una delle più belle, Deportees (Espulsi): la vicenda di un gruppo di braceros messicani rimpatriati con foglio di via su un’aereo che si schianta: la radio dirà che a bordo c’erano ‘solo degli espulsi’, ‘just deportees’, appunto.
Come in tutte le sue altre ballate, il punto di partenza era il dato oggettivo della cronaca: un annuncio della radio, un titolo di giornale e soprattutto la testimonianza diretta dalla viva voce della gente con cui si trovava in totale simbiosi e sintonia intellettuale conoscendone con immediato istinto aspirazioni e frustrazioni e dividendone espressioni e linguaggio: fossero emarginati o emarginatori, guardie o ladri, capoccia o braccianti, bianchi o neri, vagabondi o capotreni, trovano tutti posto con le loro vicende nella sua galleria di personaggi lunga, a quel che si dice, più di mille canzoni. Prendiamo ad esempio la lunghissima Tom Joad, in cui Woody racconta il film Furore tratto dall’omonimo romanzo di Steinbeck e sentiamo cosa ne dice lui stesso:
“Ho scritto questa canzone perché la gente laggiù in Oklahoma non poteva permettersi di spendere due dollari per comprare il libro, e neanche i trentacinque cents per vedere il film; ma così la canzone li potrà raggiungere per dire loro quello che disse Casey il predicatore” (3). E quello che disse Casey il predicatore è li, a conclusione della canzone: Mi sembra che tutti siano come una grande unica anima: è li che io sarò, dove i bambini piangono affamati, dove non c’è libertà, dove ci sono uomini che lottano per i loro diritti, è li che io sarò, è li che io sarò. Ma vale la pena di ascoltare ancora dalla viva voce di Guthrie cosa pensa della canzone in generale e del processo creativo che ne è all’origine:
“Finora non sapevo che differenza ci fosse fra una ballata ed una folk-song: ma ora potrei dire che una ballata racconta una storia successa a qualcuno in qualche luogo mentre una folk-song magari non ti racconta una storia vera e propria ma piuttosto dice come la pensi su una persona, su una questione, su un argomento politico”.
Poi, continua Woody, una canzone può essere “….in parte una ballata che racconta una storia in parte una folk-song che dice cosa mi sta passando in testa: e così ci si può imbattere in un sacco di tipi di canzoni e ballate che sono metà e metà, un quarto e tre quarti… oggi non c’è più differenza fra una folk-song e una ballata di quanta ve ne sia fra ‘street’ e ‘avenue’. Per me, ho sempre chiamato canzone e non ho mai sentito la parola ballata e la parola folk finché non sono arrivato a New York nel ’41. Una canzone per me è una canzone e basta: non ho mai neanche sentito una canzone che fosse definita folk-song: in fondo ogni canzone è cantata dalla gente (folk, n.d.r.) e per la gente.
Non mi sembra di aver scritto canzoni per animali, mucche, galline, pesci o scimmie. Nella mia testa una canzone è solo una canzone: canzoni allegre e tristi, da ballare o da ascoltare seduti, per tenerti compagnia mentre lavori, per proporre indovinelli, blues, ragtime, valzer, canzoni da osteria e tutto il resto… Domande, prego. Dove prendo le mie idee per canzoni e ballate? La risposta è: dovunque guardi, su un libro, una rivista, un giornale, al cinema, per strada, su autobus e treni, anche volando su un aereo o la notte, a letto: ovunque. Come mi vengono le idee? Risposta: arrivano così in fretta che non ce la faccio a finirle tutte: vedo nuove idee in ogni libro che leggo, un libro di storia mi da idee su canzoni che parlano della storia, come Biggest Thing (The Great Historical Bum, n.d.r.).
Sui giornali leggo di disastri, incidenti, alluvioni, incendi, uragani, nubifragi, stupri, omicidi, liti familiari, drammi della gelosia, rackets, gangsters, case chiuse, epidemie nei ghetti, tragedie di ogni genere, esplosioni. Ogni genere di disastro. Ogni volta che si perdono delle vite, cerco di scrivere una canzone che spieghi perché è successo e cosa potremmo fare tutti quanti perché non succeda più. Come per quell’esplosione di gas nella miniera n.5 a Centralia che si portò via un centinaio di vite: Goodbye Centralia. Come per il siluro che affondò la famosa nave americana prima che fosse dichiarata guerra ad Hitler e Mussolini: The Sinking Of The Reuben James. Oppure questa che ho scritto perché non ci si dimentichi ciò che accadde a quel soldato negro appena tre ore dopo essere stato congedato con onore ad Atlanta, Georgia: Isaac Woodard “(4).
A parte la sottile personalissima distinzione fra folk-songs e ballads che, anche se affascinante, temo faccia rizzare i capelli in testa a più di un etnomusicologo, è questa la ricetta a cui Woody Guthrie è sempre stato nelle sue canzoni: una ricetta che traeva vantaggio dall’essere praticata in un momento storico in cui i mass media non avevano il potere che noi oggi conosciamo (la televisione negli anni quaranta muoveva i suoi primi timidi passi) e lasciavano spazio sufficiente a forme di comunicazione più personali e dirette – oggi potremmo dire ‘alternative’ – quali la canzone così come concepita da Woody: egli si trovava così a rappresentare, piuttosto che l’uomo di spettacolo coinvolto nel music business, una sorta di ‘giornalista del popolo’ o cantastorie senza avere però di quest’ultimo la popolaresca ingenuità: semmai una certa dose di retorica, nel più nobile senso del termine, che lo portava a scolpire frasi memorabili che avevano la forza del titolo giornalistico o dello slogan pubblicitario e che, come questi, si radicavano tenacemente nell’ascoltatore. Frasi come “The gamblin’ man is rich, and the working man is poor” (“Il giocatore d’azzardo è ricco, mentre povero è chi lavora”), “Some will rob you with a six-gun, some with a fountain pen” (“C’è chi ti rapina con una pistola a sei colpi, chi con una penna stilografica”), “We come with the dust and we’re gone with the wind” (“Arriviamo con la polvere e ce ne andiamo col vento”).
Ma qual’era l’attaggiamento di Woody Guthrie nei confronti del lato più strettamente musicale delle sue canzoni? Da quanto si è detto fin’ora appare scontato un solidissimo legame con tutta la musica tradizionale americana: una scelta naturale per chi come lui aveva l’esigenza di un linguaggio comune alla gente della quale e alla quale cantava. Né va dimenticato che gli anni ’30 sono quelli che vedono il successo di Jimmie Rodgers e della Carter Family, pionieri della Country Music e ‘innovatori nella tradizione’ ai quali Guthrie deve molto stilisticamente: sarà facile quindi comprendere come la musica di Woody fosse assai più vicina alle orecchie dell’americano medio di quanto verrebbe oggi da pensare. Ma lasciamo che sia ancora una volta egli stesso a parlarci della genesi musicale delle sue canzoni:
“In genere l’idea per una melodia viene prima delle parole: è così che succede anche a me per la mie ballate. Decido quale miscuglio di melodie usare e poi trovo assai più facile fare entrare il mio gregge di parole dentro la musica che ho costruito in precedenza per loro. Non spreco mai il mio preziosissimo tempo per chiedermi o minimamente domandarmi se ho già sentito da qualche parte l’intera melodia o un suo frammento. Ci sono dieci milioni di modi di alterare una melodia che suoni come una mia creatura: posso cantare una nota un’ottava sopra, posso sostituire una nota dell’armonia ad una della melodia, posso tenere una nota lunga al posto di altre più brevi e piazzare pause e misure d’attesa qua e là in modo da adattare l’essenza di ogni melodia all’idea per una nuova ballata” (4).
Detto con tale sincerità e candore l’espediente sembrerebbe un trucchetto di bassa lega, ma basta ascoltare Woody Guthrie interprete delle sue ballate per sentire come una prorompente personalità artistica restituisca piena credibilità all’operazione: del resto la confessione resa potrebbe essere elevata a enunciazione del principio – che ci trova abbastanza d’accordo – per cui se si prende una vecchia canzone e le si cambia il testo, il contesto, l’espressione, il fraseggio, l’intenzione, ci si trova alla fine di fronte a qualcosa di intimamente diverso dal punto di partenza; e così è quando si ascoltino canzoni nelle quali l’operazione di contaminazione è avvenuta con maggiore trasparenza, e valgano per tutti gli esempi di Reuben James/Wildwood Flower o Jesus Christ/Jesse James.
E arriviamo ora a parlare del disco che ci ha fornito pretesto e occasione per queste righe. Innanzitutto il titolo: Folkways: A Vision Shared. A Tribute To Woody Guthrie And Leabelly (CBS 460905); e già nascono alcune perplessità, la stessa macchinosità del titolo rivela una genesi editoriale sofferta. Né è del tutto chiaro perché Leadbelly sia stato accostato a Guthrie, soprattutto considerando il ridotto spazio dedicato alle sue composizioni, solo cinque su un totale di quattordici, che non rende giustizia alla statura artistica del grande Huddie Leadbetter che avrebbe meritato maggiore e più autonoma parte all’interno del disco.
Se anche i due hanno più volte collaborato in vita e sono stati legati da reciproca amicizia e stima – Woody Guthrie: “Il cantante migliore e dalla voce più potente in cui mi sia mai imbattuto era Huddie Leadbetter e tutti lo chiamavamo Leadbelly ( Panciadipiombo, n.d.r. ): le sue braccia sembravano tubi di stufa, aveva una faccia dai lineamenti marcati e suonava la chitarra a 12 corde. Una volta a casa sua mi disse: comincio a cantare presto al mattino perché mi tira su. Non potrei cantare in modo che vada bene per te, se prima non faccio in modo che vada bene per me..!” – (4), le loro vicende, la loro musica, il senso stesso della loro opera non sembrano riconducibili sugli stessi binari malgrado ciò che Anthony Seeger scrive nella copertina interna dell’album.
E’ vero, entrambi sono stati registrati da Lomax per la Folkways e ne sono stati gli artisti più di spicco, ma l’operazione andava a mio avviso condotta con maggiore equilibrio e meglio sarebbe stata addirittura l’uscita di due distinti album. Ammettiamolo: siamo incontentabili. Le perplessità del resto vengono a cadere considerando il fine, che come al solito giustifica i mezzi, altamente meritorio: cioè rendere economicamente possibile l’acquisizione da parte della Smithsonian Institution della Folkways, la benemerita etichetta nata dall’amore, dal lavoro e dalla dedizione del compianto Moses Asch. Considerato questo e tenendo presente che l’operazione ha coinvolto un ente culturale (Smithsonian Institution), una casa discografica (CBS) e gli artisti tutti che hanno devoluto le loro royalties alla causa, è già troppo che il pranzo non sia stato guastato, come si suoi dire, dai troppi cuochi, e non sarebbe giusto andare a cercare, come si suoi dire, il pelo nell’uovo.
Fra i musicisti coinvolti qualcuno sicuramente fa sentire la sua mancanza (e penso a Ramblin’ Jack Elliot, vecchio compagno di strada di Woody e sublime interprete delle sue canzoni), qualcun altro è forse di troppo: ci sarebbe voluto comunque un intero cofanetto per raccogliere tutte le cover degne di interesse dei pezzi di Guthrie e Leadbelly e la scelta effettuata ci trova, a parte l’iniziale perplessità, abbastanza d’accordo.
Folkways… è senz’altro un ottimo punto di partenza per chi oggi voglia accostarsi al mondo di Woody Guthrie e in qualche misura di Leadbelly lasciando poi a ciascuno l’opportunità di proseguire il cammino attraverso altre compilation e soprattutto gli album in cui li si può ascoltare in prima persona: soprattutto è un’ottima occasione per capire come un mondo musicale che alcuni vorrebbero morto o demodé eserciti ancora un profondo fascino non solo su tradizionalisti del folk e del country, ma anche su Dylan (e questo dovrebbe essere risaputo, visto che già decine d’anni fa cantava in Song To Woody: “Hey, hey Woody Guthrie, I wrote you a song / ‘Bout a funny old world that’s a comin’ along: / It’s tired and it’s hungry, it’s sick and it’s thorn / It looks like it’s dyin’ and it’s hardly been born”) e su attualissime forze del rock come Springsteen e gli U2.
Nessuno oggi, né Woody Guthrie ai suoi tempi – credo – si sognerebbe di dire che le canzoni cambiano il mondo: ma se c’è ancora qualcuno che fa qualcosa per rendere migliore la nostra esistenza, se pensa che il mondo può ancora cambiare in meglio, queste canzoni gli possono ancora tenere buona compagnia.
(1) Woody Guthrie Folk Songs, New York, Lodlow Music lnc, 1963,
(2) W. Guthrie – Bound For Glory, J.M. Dent & Sons, 1969,
(3) Dustbowl Ballads, RCA Victor LPV 502, note di copertina,
(4) W. Guthrie – Born To Win, Collier, 1967.
Luigi Grechi, fonte Hi, Folks! n. 32, 1988