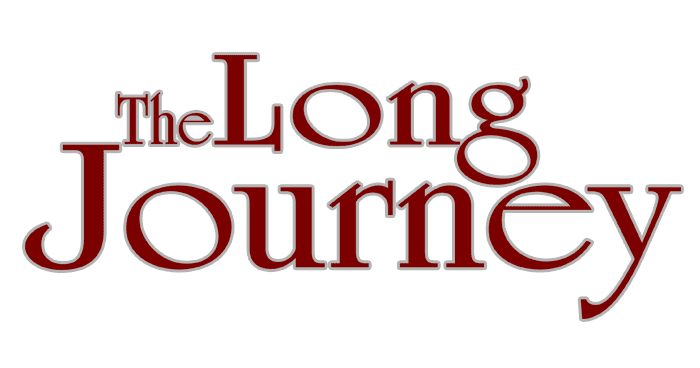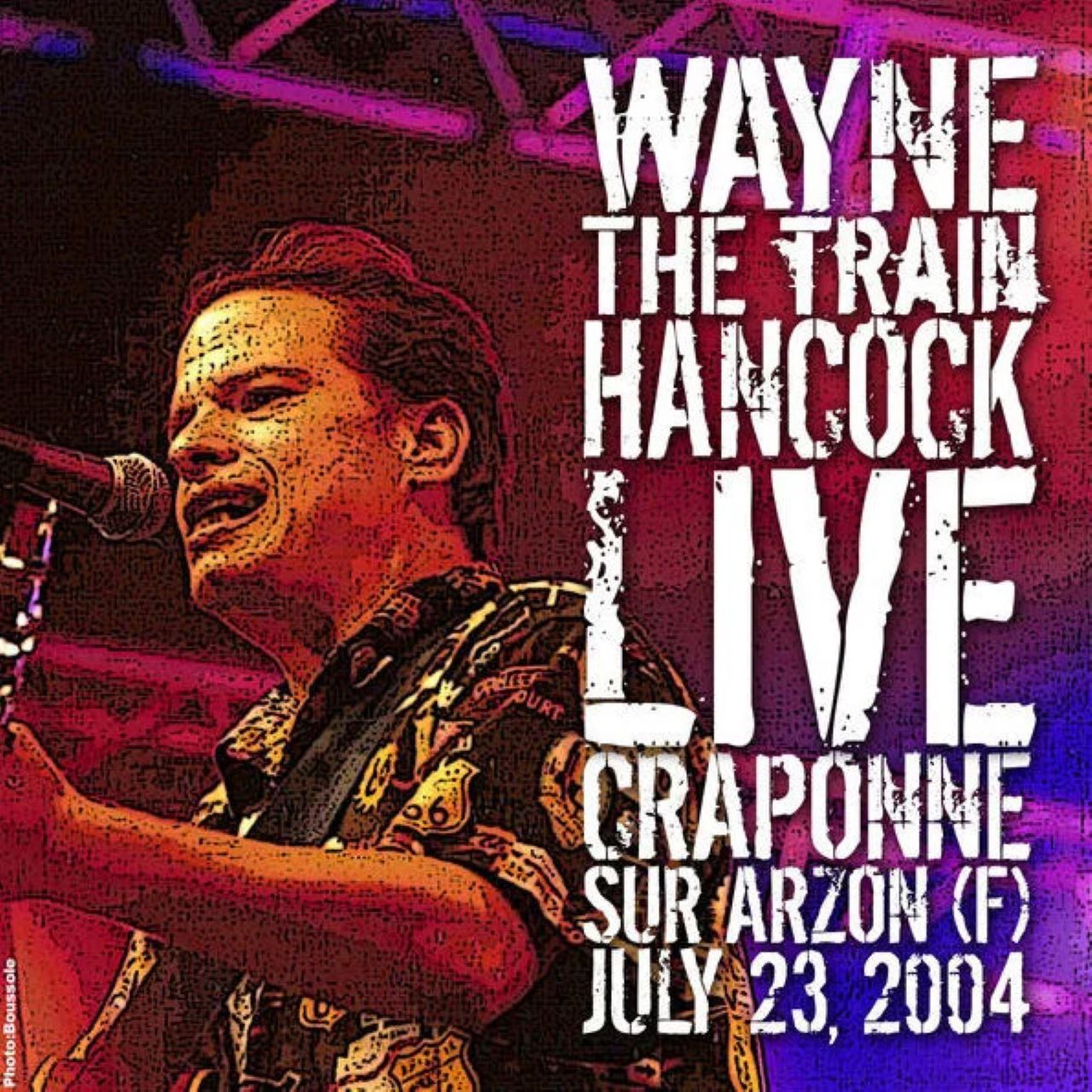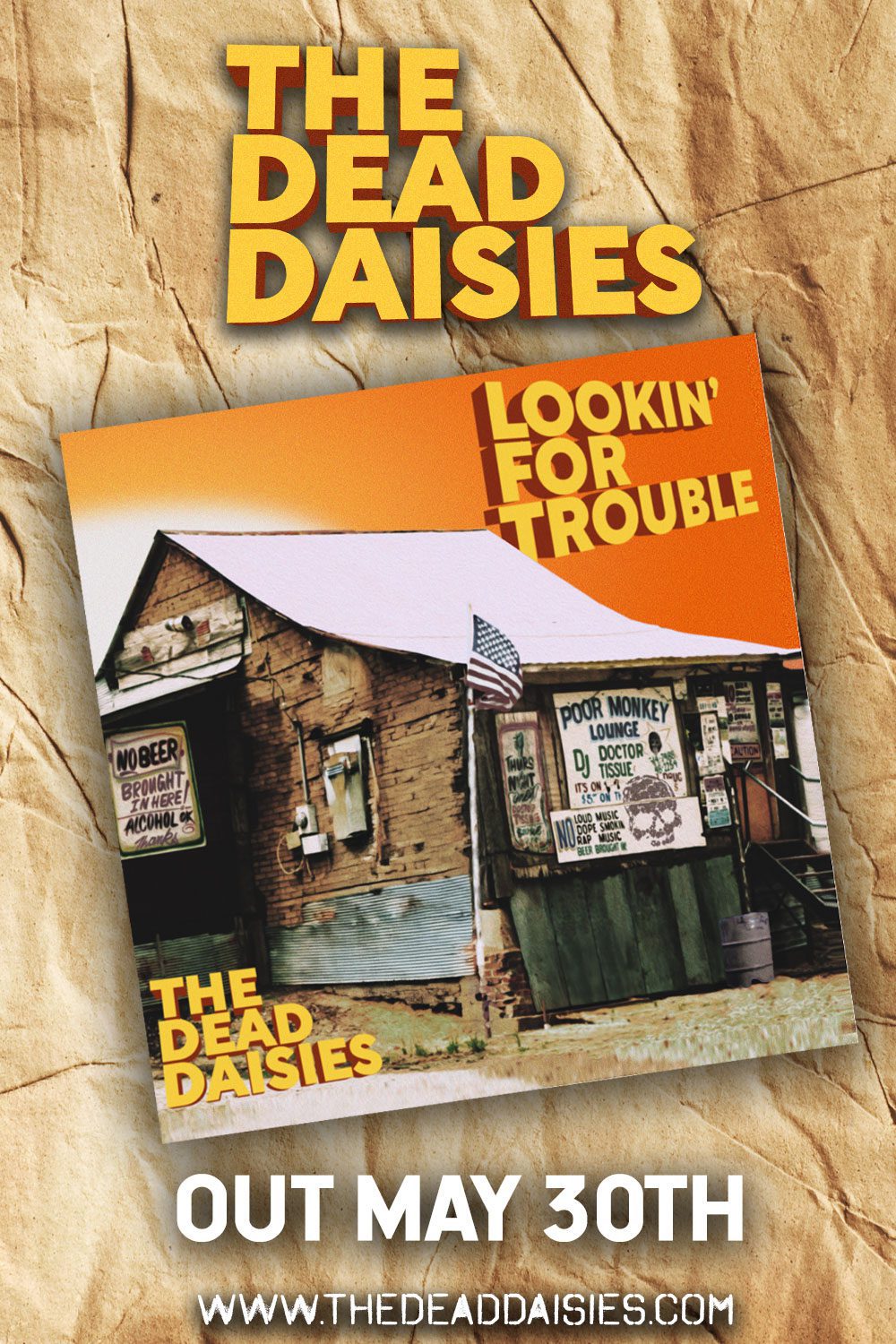I pellegrini che dal santuario di Santiago di Compostela da secoli fanno della Haute Loire una meta, da diciassette anni a questa parte hanno previsto probabilmente una tappa in più in quel di Craponne sur Arzon per il Country Rendez-Vous. Noi abbiamo saputo solo di recente di questo appuntamento annuale, il 17mo, e ci siamo precipitati non appena abbiamo saputo del programma: una bonanza di bei nomi della Texas music arricchita dalla presenza illustre di Marty Stuart e della esordiente ‘extraordinaire’ Jill King, attesissima in Europa per una verifica del successo del suo primo album, entrambi ambasciatori dell’amata/odiata Nashville. Una potente mistura di tequila e di Jack Daniels, per chi sa apprezzare i sapori della grande musica.
Ma la Rivelazione non sarebbe stata completa se non ci avesse anche incantato l’ambiente di contorno all’evento: boschi di pini, prati verdi di mezza montagna (Craponne è a 1000 metri di altezza), cavalli al pascolo e, contrasto da knock out, abbazie medievali.
In questo ‘quadro’, il nostro pellegrinaggio ha superato tutte le aspettative. Arrivando a Craponne ci si rende subito conto della portata dell’evento: l’area del festival è un enorme prato in posizione elevata che permette una vista panoramica sulla vallata e che può contenere diverse migliaia di persone. A cornice dell’area, una distesa di stand di ogni bene che un cowboy nostrano possa desiderare più altri stand di varia gastronomia. Gli spazi di abbeveraggio sono distribuiti sapientemente su tutta l’area in modo da non avere mai code. Piccolo neo: un solo chiosco di dischi, e pure poco fornito: per favorire gli artisti in programma gli organizzatori hanno previsto l’accentramento della vendita del merchandising in un unico punto. Lì, dopo ogni concerto, sul modello Fan Fair, gli artisti firmano autografi agli acquirenti e si fanno fotografare con loro.
L’atmosfera a Craponne è gradevole, informale, come si confà al naturale ambiente country. Vi contribuisce l’elasticità delle regole di accesso all’area che consentono di assistere, volendo, anche ai soundchecks e di incontrare diversi artisti che, mescolati alla folla, assistono agli show dei colleghi (!). In tali condizioni di rilassatezza anche il personale di sicurezza è particolarmente cordiale. Due grandi pedane sono sistemate ad uso dei tanti line dancers. Il palco è spazioso e sullo sfondo campeggia uno schermo a forma di cassa di banjo. Nel complesso, un setting ed un’atmosfera in perfetta armonia con l’evento, un’indigestione di musica che dura tre giorni e che ci trasporta nella nostra dimensione preferita.
Ecco quindi che si aprono le danze con il bluegrass d’epoca (tutti strumenti acustici, unico microfono per tutte le voci, repertorio Bill Monroe, Flatt&Scruggs, Hylo Brown, Buck Owens) degli olandesi Bluegrass Boogiemen che si trasformeranno il giorno dopo negli Hillbilly Boogiemen per uno show elettrico di vintage country, a coprire tutto il range delle radici. Bravi e divertenti, ma ci vuole altro e non è certo lo show senza infamia e senza lode del canadese Lee Dinwoodie ad esaltarci.
Tempo di cambiare la strumentazione e finalmente vediamo farsi strada sul palco un Jason Boland un po’ perso nei fumi dell’alcool ma ben sorretto dagli Stragglers (ai fans della steel guitar segnaliamo lo strepitoso Roger Ray) rinforzati da Peter Black, fiddle man di Randy Rogers. Boland percorre con noi la sua ruvida pista di Tennessee Whiskey, di Pearl Snaps e di Shot Full Of Holes. Sembra ombroso, con il cappello sugli occhi e la barbetta sul volto da ragazzo. Canta un po’ svogliato Dirty Fightin’ Love, My Baby Loves Me When I’m Strong ma quando canta di Texas si lascia andare: Somewhere Down In Texas è una corposa elegia del nostro Stato preferito che il fiddle di Peter Black fa sconfinare nel romantico quando trascina il finale sulle note di Dixie. Il pubblico ‘confederato’va in delirio, bandiere al vento. Il pieno preventivo di birra che sembrava quasi tarpargli le ali ora gli dà la carica: invita sul palco Kevin Fowler e insieme si lanciano in una versione di Copperhead Road da far invidia all’autore. Poi ecco Mexico Or Crazy ed un paio di ruvidi sentimentali e, a seguire una scatenata rivisitazione del classico talkin’ boogie Hot Rod Lincoln che tocca il picco dello show.
E’ poi la volta dell’hillbilly boogie d’autore di Wayne Hancock, un malinconico che si sforza di essere allegro, un folletto solitario che canta di juke joints e di amori adolescenziali, una voce che sembra quella di Hank Sr. ed un look anni ‘50 che coinvolge la band al completo.
I tostissimi Cross Canadian Ragweed tradiscono sul palco la loro predilezione per il rock piuttosto che per la country music. E’ un rock piacevole, ben schitarrato seppur non impostato sulle tre chitarre del southern rock classico ma di sudista ha l’anima, le sonorità, l’armonia (niente dissonanze), le influenze country e country blues. La voce di Cody ricorda quella di Roger McGuinn ma chi segue con attenzione riesce a ritrovare echi di Doobie Brothers e qualche nostalgia di marca Neil Young. Aspetto da bikers buoni, tatuaggi e giubbotti di cuoio ma facce da angeli biondi, rallentano il ritmo solo con Sick & Tired. Il pubblico apprezza ma è diviso. E’ solo un attimo: quando Cody Canada chiama sul palco Randy Rogers e Wayne Hancock per Boys From Oklahoma la gente si ricompatta e festeggia fino nel cuore della notte (le 2 am).
Randy Rogers è il più giovane nel cast del Rendez-Vous ed anche presumibilmente sulla scena dei cantautori texani. Cresciuto a gospel nella chiesa del padre predicatore battista e ascoltando Merle Haggard e Waylon Jennings, è al suo primo disco ma la sua vena compositiva gli ha già guadagnato un seguito. Lui è semplice, simpatico e disponibile ma già dimostra leadership e disinvoltura. Lo stile è sostenuto, personale. La band di coetanei altrettanto promettenti gli sembra dipinta addosso. Diverse canzoni sono decisamente belle (Tonight’s Not The Night For Goodbyes, I’d Still Be Losing You, Tommy Jackson) e gli promettono un buon futuro. Lui non fa fatica a coinvolgere il pubblico solo con la forza della musica. Da segnalare la sua Lost & Found, Next Time Around, l’omaggio a Billy Joe Shaver con Black Rose e la suggestiva love song di chiusura fatta solo di voce, chitarra e fiddle. Poche parole e pochissimi complimenti, il suo scopo è presentarsi all’altezza dei più illustri colleghi, e la coda al botteghino dei dischi e degli autografi conferma che è sulla buona strada. Lo risentiremo volentieri ed intanto compriamo il suo nuovo CD Rollercoaster per prepararci al prossimo appuntamento.
Ma ecco arrivare il momento (attesissimo dai più) di Kevin Fowler, nuovo profeta del redneck lifestyle, che ci regala lo show più divertente e coinvolgente. Definisce la sua musica ‘Country Music with a Bad Attitude’ (o anche Country Music with Balls) facendosi però del torto vista l’ironia che lo rende speciale. Il pubblico canta insieme a lui quasi tutte le canzoni dei suoi primi CD e si scatena in un delirio di identificazione con Beer, Bait & Ammo e con 100% Texan. Lui, sornione, se la gode un mondo anche perché sta vivendo un momento felice e decisivo della sua carriera: l’ha appena scritturato la Equity di Clint Black, e Mark Chesnutt ha registrato la sua Lord Loves The Drinkin’ Man per cui salta e strabuzza gli occhi e annuncia : “I’m gonna be a rich son-of-a-bitch!”. E intanto divertimento e sentimento si dividono una buona ora di honky tonk music: feste, tequila e border con Senorita Mas Fina, My Little Butterbean, Loud & Crazy (nuovo single), Speak Of The Devil, I Ain’t Drinkin’ Anymore (…But I Ain’t Drinkin’ Any Less) qualche lacrima nella birra (Penny For Your Thoughts, If These Old Walls Could Talk, Not Lovin’ Anymore), due covers: la classicissima Is Anybody Going To San Antone, e The Devil Came Down To Georgia in memoria del suo passato da rocker sudista. Spensierato e scatenato ma appassionato quanto può esserlo un redneck col cuore spezzato, Fowler è un artista sulla rampa di lancio.
Dopo gli eccessi giovanili di Fowler viene l’ora di togliersi il cappello di fronte alla classe di Marty Stuart. Una platea stremata ma eccitatissima accoglie con un boato quello che a Nashville è un po’il guardiano della tradizione, una garanzia di serietà per chi diffida del New Country. Già la presenza di scena è significativa: tutti (tre + Stuart) in tuxedo bianco con riporti neri (una tenuta discreta vista la celebre collezione personale di Stuart di vestiti di scena a dir poco…originali), la compostezza dei grandi professionisti ed una bravura sconfinata! Tutti cantano ed il chitarrista (già visto con Mary Chapin Carpenter) fa correre le dita sulle corde alla velocità di un roadrunner.
L’allarme per la mancanza di violino e steel (sul palco, oltre a Stuart, ‘solo’ chitarra, basso e batteria) dura pochissimo perché Mr. Stuart in un’ora ci racconta la storia della country music: parte dall’oggi con un brano dall’ultimo CD (Back To The Country), svaria sul rockabilly (Too Much Month At The End Of The Money), ripropone i due hits che aveva avuto in duetto con Travis Tritt (The Whiskey Ain’t Working Anymore, This One’s Gonna Hurt You), visita il country vintage (Homesick) a quattro voci, imbraccia il mandolino e introduce una Slow Train tutta acustica e tutt’altro che slow, cantata dal batterista che Dio-solo-sa-come-fa-a-cantare-e-tenere-il-tempo. Si lancia in un omaggio a Johnny Cash con Luther Plays The Boogie poi si concede un break affidando al chitarrista una Country Music Got A Hold On Me.
Uno strumentale in stretto bluegrass style con ancora il mandolino a fare da apripista precede una versione da pelle d’oca di Long Black Veil cantata ancora a quattro voci. Poi le chitarre elettriche riprendono il sopravvento con l’omaggio a Carl Perkins (Everybody’s Trying To Be My Baby) e l’immancabile Hillbilly Rock. Un grande applauso accompagna i musicisti nel backstage e la sensazione che riusciamo meglio ad esprimere è l’ammirazione per uno show impeccabile e per la bravura individuale e collettiva di ognuno dei protagonisti. Incontentabili, avremmo sperato di vedere sul palco Connie Smith, una sorpresa che sovente arricchisce ulteriormente i concerti di Stuart, ma questa volta la sorpresa non c’è stata. Alla prossima.
Reckless Kelly, family band incentrata sui fratelli Braun che la critica texana ha elogiato e premiato per la produzione più recente, si presenta rumorosamente per l’ultimo set del sabato dopo un intro bluegrass degli svizzeri Groundspeed. Il contrasto è aspro e lo è tanto più perché lo show dei Kelly è di puro rock senza neanche le interazioni roots/sudiste dei Cross Canadian Ragweed. L’evoluzione che ha trascinato la band dal country eclettico delle origini al rock d’autore di oggi ha completato il cammino e non è il sopravvissuto fiddle in formazione a dissimulare il radicale cambiamento. Il rock che ne esce è un buon prodotto ma non eccessivamente originale. Non per niente l’accoglienza è stata calda quasi solo presso l’area di pubblico più vicina al palco, più coinvolta. Ammosciati, i line-dancers smettevano di sgambettare. Da segnalare in scaletta, oltre ai brani tratti dal CD che li ha innalzati di categoria (Under The Table & Above The Sun), una buona versione sostenuta di Folsom Prison Blues in omaggio all’Uomo Nero e una Vancouver dalla linea melodica più evidenziata che altrove.
A Jill King, dopo un’ora interminabile dei Kelly, è toccato recuperare l’atmosfera da festival country. Unica rappresentante insieme a Marty Stuart di mamma Nashville in questa edizione del Rendez-vous, la King ha confermato quanto di bene si è detto e sentito di lei ma ha denunciato limiti di repertorio (e forse qualche difficoltà creativa) quando ha dovuto rimpolpare in concerto l’esiguo numero di brani del suo pur egregio album di esordio con troppi standard da cover band (Kawliga, Jambalaya, Son Of A Preacher Man, Walking After Midnight, Once A Day, Two More Bottles Of Wine, Better Things To Do, Just Call Me Lonesome, il bis Me & Bobby McGee interpretata alla Janis Joplin ). Particolarmente gradevoli la resa di You Belong To Me, il boogie Country After All, e l’unica nuova sua canzone, Tootsie’s Orchid Lounge, dedicata al più celebre bar di downtown Nashville. Sembra che dovremo aspettare a lungo il prossimo album perché non è neanche ancora in gestazione ed è incerta la destinazione discografica.
Un gran tramestio di tecnici sul palco precede il concerto di Billy Joe Shaver mentre la folla sottopalco si fa via via più folta. C’è attesa e curiosità per il ritorno in Europa di un artista amato ed apprezzato, che si è guadagnato un posto importante solo con la forza delle sue canzoni e del suo carisma. Per destino o per coerenza personale, la via del successo non gli ha mai riservato onori ufficiali sebbene la sua pista abbia incrociato anche quella di Elvis (You Asked Me To) e innumerevoli tracce di outlaws texani, Willie, Waylon, Johnny Paycheck tra i più assidui, a cantare le sue canzoni. Il riconoscimento più concreto gli è venuto dai tantissimi che hanno scelto e cantato le sue canzoni. Se Willie Nelson è il Texas, Billy Joe ne è il cuore pulsante, ma più ancora di Willie è poeta di frontiera che racconta di vita vagabonda, di rodeo, di strade infuocate dal caldo, di saloon impregnati di whiskey e tequila, di lenzuola al vento, della vita dura del migrante messicano.
E’ la celebrazione vivente del bianco povero, il white trash, che ha lottato per farcela, ha lavorato duro ed è orgoglioso delle sue origini e dei valori con cui è cresciuto. La sua genuinità ha sempre conquistato il pubblico che lo ha amato anche per le durezze che il destino gli ha riservato. Suo tratto distintivo, inconfondibile, la voce virile che si chiude di quando in quando in accenni di yodel. Eccolo arrivare sul palco in completo di jeans sgualcito, stivali e cappello: non ha vestiti di scena, lui è quello che vediamo. E’ invecchiato, ha i capelli tutti bianchi ma ha un fisico invidiabile, dinoccolato, snello. Si porta dietro un’altra leggenda texana, Jesse Taylor, potente e sanguigno chitarrista proveniente dal blues, grande personaggio. L’uomo giusto per sostituire Eddy Shaver che non c’è più, forse uno dei suoi maestri. Una bella sorpresa. Con loro, un altro giovane chitarrista, basso e batteria. Poche cerimonie e si parte con una raffica di classici: Georgia On A Fast Train, Honky Tonk Heroes, Black Rose, Old Chunk Of Coal.
Colpisce la sua gestualità, spontanea non studiata: muove le braccia, appoggia un ginocchio per terra durante gli assolo e china la testa come davanti ad un falò nella notte, saluta togliendosi il cappello con le tre dita rimaste della mano destra, accenna impacciato qualche passo di danza.
Qualche episodio più recente (That’s What You Said Last Night, Try And Try Again) poi l’omaggio a Johnny Cash a cui dedica la bellissima That’s Why The Man In Black Sang The Blues e le ispirate When The Fallen Angels Fly e Live Forever. Dopo un attimo di raccoglimento, annuncia: Ora torniamo alla parte peccaminosa! Ed ecco The Hottest Thing In Town. I due chitarristi si incrociano nel lungo assolo ed è curioso notare la differenza generazionale delle due scuole: il giovane preme pulsanti, bottoni e pedali, il vecchio Taylor si interessa solo alle manopole del volume. Altri classici (Ride Me Down Easy, You Asked Me To) e qualche digressione sentimentale (Love Is So Sweet, Dèja Blues) portano al gran finale (When The World Was Thunderbird) e addirittura a tre bis. Non era previsto tanto e ci si zittisce tutti quando Billy prende la chitarra acustica e canta per il figlio Eddy una toccante Star Of My Heart. La voce gli trema un po’, poi sull’accordo finale si libera con un “God Bless You, Eddie, wherever you are!”. L’attimo di commozione coinvolge tutto il pubblico e l’applauso è immenso. E’ lui stesso a riprendersi, quasi imbarazzato, per chiudere con la vivace Tramp On Your Street e salutare definitivamente nel tripudio collettivo.
La festa non si è ancora placata quando spunta sul palco la figura esile di Ponty Bone con la sua fisarmonica appesa alla spalla. E’ un gradevolissimo signore attempato dai modi gentili e misurati, un gentiluomo del Sud, che possiede le chiavi del successo dei tanti che hanno chiesto la sua collaborazione in sala di registrazione. Personaggio familiare nella comunità artistica texana, rivela al tocco della tastiera una padronanza completa dei suoni della Louisiana bianca e nera e del conjunto di frontiera. Da quell’enorme scrigno trae ispirazione per le sue canzoni che in concerto alterna così abilmente agli adattamenti strumentali o meno di traditionals che quasi non ci si accorge delle differenze.
Dietro di lui compaiono, altra gradita sorpresa del Rendez-vous, nientemeno che gli italiani Chicken Mambo a temporanea sostituzione in chiave europea degli originali Squeezetones. Niente di strano, in realtà, visto che i Chickens nostrani collaborano da anni con Bone e con altri illustri texani. Il sorrisone e l’armonica di Fabrizio Poggi integrano perfettamente la personalità e lo strumento del protagonista. Insieme, in un’atmosfera un po’ da fine della festa, regalano un concerto allegro, disimpegnato, da ascoltare e da ballare, che avremmo però collocato meglio in palinsesto, magari in apertura di giornata per iniziare con i bignè di New Orleans e finire, più logicamente secondo le convenzionali leggi dello showbiz, con i fuochi artificiali.
Mi dicono i colleghi francesi che questa è stata l’edizione migliore, il picco di qualità del Rendez-vous di Craponne e che sarà una bella sfida fare meglio l’anno prossimo. Certamente questo 17mo Rendez-vous, in vista di una Country Night Gstaad con una line-up da richiamo contenuto, si candida alle nostre orecchie come l’appuntamento Numero Uno del 2004. Vi sapremo dire al più presto. L’edizione di Craponne 2005 è già stata fissata nel weekend del 29-31 Luglio.
Ma intanto, prenotate già con Travel West i vostri posti letto perché in zona Craponne gli hotel scarseggiano e sono condivisi con staff e artisti. Potreste trovarvi, come è successo a noi, a colazione con Jill King.
Fabrizio Salmoni, fonte Country Store n. 73, 2004