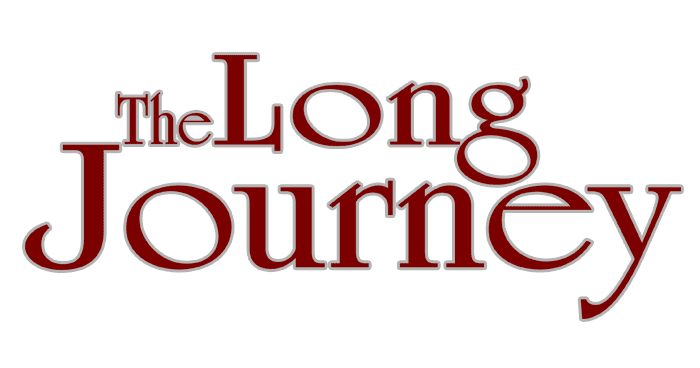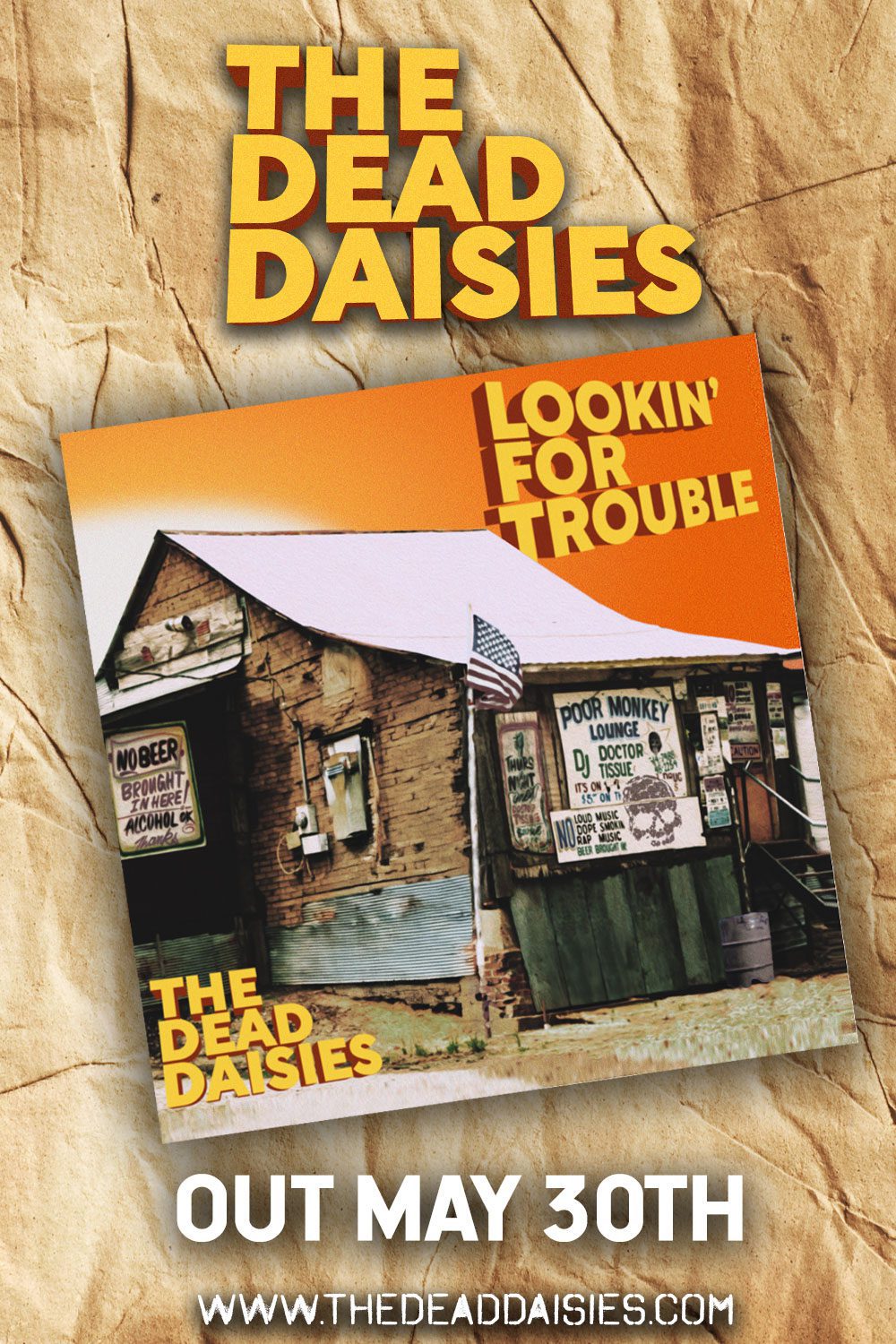Ci aveva impressionati con favore il disco Seven Day Blues (Il Blues n.142) che questo cantante ed ex batterista per decenni al fianco di Phillip Walker, ha pubblicato sul finire del 2017. La sua ilarità e il divertimento che emanava nell’occupare il palco del Lucerna Blues Festival, hanno confermato quanto di buono ci aveva lasciato l’album. Un blues ‘vecchia scuola’ in cui il cantante e la band trovano una naturale integrazione (su disco Big Jon Atkinson e soci, dal vivo il gruppo di veterani capitanati da Anthony Geraci). La sua è la storia di chi sideman per una carriera, si ritrova protagonista, in modo forse insperato e in età non più verde e forse anche per questo, gusta appieno il suo momento.
Sappiamo che vieni da una famiglia numerosa.
Una grande famiglia. Sedici figli, otto maschi e otto femmine. Tre coppie di gemelli. Eravamo molto legati, facevamo tutto insieme e la cosa rendeva contenti i nostri genitori. Eravamo una delle famiglie più grandi di Fresno, California, ed è lì che siamo cresciuti. Lavoravamo i campi e i padroni venivano da mia madre, papà non sapeva leggere, perché trovasse altri lavoratori. Cosa che mia madre faceva. Ogni anno raccoglievamo l’uva, bisognava finire prima che le piogge rovinassero il raccolto. Non potevamo andare a scuola con gli altri perché dovevamo lavorare nei campi. Il padrone dei campi venne a scuola a spiegare al preside per quale ragione dovevamo perdere il primo mese di scuola e alla fine trovarono un accordo.
Le cose sono andate avanti così fino all’adolescenza?
Sì, fino a che non sono andato via di casa. Ma non siamo mai finiti nei guai, mai rubato e mai finiti in galera. I nostri genitori ci hanno educato così, nessuno prendeva ciò che non era nostro.
Erano persone religiose?
Mia mamma lo era. A me non piaceva molto andare in chiesa, mi addormentavo sempre! La sera prima si faceva festa. Un giorno ho detto ai miei che non ci volevo più andare in chiesa, mio padre non disse nulla ma mia madre disse «ragazzo, non mi interessa nulla, tu verrai in chiesa». Inaspettatamente mio padre prese le mie parti, «se il ragazzo non vuole venire, meglio non obbligarlo, se lo forzi non imparerà nulla comunque». E allora la mamma si convinse. Che notizia fu per me. Ora invece vado in chiesa e non mi addormento più, mi tengono sveglio!
C’era qualcuno dei tuoi fratelli e sorelle con cui eri più legato?
Le mie sorelle. Nessuno doveva permettersi di prenderle in giro o fare scherzi. Gli altri sapevano che non dovevano canzonarci perché eravamo una grande famiglia con un sacco di bambini. Era una cosa del tipo «io non parlo di tua madre, perciò lascia stare la mia». Eravamo in tanti ma non ci è mai mancato nulla, anzi avevamo sempre ospiti, altri ragazzini e mia madre cucinava per tutti. Non c’erano problemi di cibo, lei non ha mai mandato via nessuno, metteva sul fuoco una grossa pentola di fagioli e avvisava i genitori degli altri bambini che si fermavano con noi a mangiare. Tutto scorreva così, ma poi mi sono appassionato alla musica, volevo cantare e suonare la batteria e ho pensato che dovevo andarmene. Mio cognato mi prese una batteria, mi ci sono voluti due giorni per montarla, non sapevo proprio come fare. L’avrò montata e rimontata una dozzina di volte prima di riuscirci nel modo giusto.
Come mai ti comprò una batteria?
La storia è questa. Raccoglievamo cotone al mattino presto e c’era la nebbia. Non si vedeva nulla da tanto era spessa. Perciò ci raccoglievamo attorno al fuoco aspettando che la nebbia si diradasse. E mio fratello si costruì una chitarra con un cavo. Era seduto di fianco a me e cominciò a prendere un cavo e metterlo sul fuoco in modo che il rivestimento di gomma si bruciasse e rimanesse solo il ferro. Prese un pezzo di legno e fisso il cavo con un chiodo ad una estremità e ne piantò un altro in fondo. Prese altri cinque cavetti e li assemblo a fianco, in questo modo sembrava proprio una chitarra. All’epoca c’era il latte condensato della marca PET, venduto in barattoli di latta, era materiale morbido, lo si poteva piegare con una mano sola, non era ferro si poteva schiacciare senza fatica. Mio fratello prese uno di questi barattoli e lo infilò sotto i cavetti in modo da regolare l’accordatura. Lo spostava lungo la tavola se il suono non gli piaceva. Quando ha cominciato a suonarla usava un pezzo di plastica ma non gli piaceva, così usava la mano, anche le sue dita presero a sanguinare perché le sfregava sui cavetti. Aveva solo tredici anni ed io ero poco più vecchio. Cantavamo anche quando lui suonava e a me piaceva il suono della batteria, battevo sui barattoli, tenevo il tempo. Quando mio fratello ha costruito la chitarra sembrava facile, invece quando tempo dopo, beh non è stato affatto semplice assemblarla, né accordarla. Faccio tutto a orecchio, anche quando canto. E tuttora lavoro in questo modo. Per l’ultimo disco, Seven Day Blues, ho solo detto alla band di suonare un blues in Sol. All’inizio non capivano quello che volevo fare, forse non so scrivere, ma so cantare. Quando sono entrato in studio, i ragazzi della band avevano già un pezzo, ma era solo suonato, me lo hanno fatto sentire e le parole mi sono uscite di bocca così. Non mi ricordo tutto quello che canto, perciò ho detto ai ragazzi, «dobbiamo farla bene la prima volta, altrimenti se la rifacciamo sarà un’altra canzone». Non riesco a fare la stessa cosa più volte. Mi ascoltano cantare, il sentimento che ci metto in un pezzo, non so cosa verrà fuori, basta che loro suonino. In questo modo abbiamo anche inciso una canzone gospel, cosa che non ho mai fatto in vita mia. Non scherzo con la Bibbia e quando vado in chiesa mi limito ad ascoltare. Però quel giorno in studio quando abbiamo riascoltato la registrazione mi sono accorto che era un gospel, è accaduto e basta, senza pensarci. Pensavo fosse un problema invece mi hanno detto di no. Il titolo della canzone è Jesus Won’t You Come By Here e l’abbiamo messa sul disco di Kid Ramos. Siamo amici.
Com’era la California all’epoca?
Non c’era la segregazione come in Mississippi, potevamo fare tutto. Non avevamo i bagni per neri o cose del genere. Già in Texas era diverso, c’erano posti in cui potevi andare ed altri in cui era meglio non farlo. C’erano cartelli white only o black only. Era una sensazione strana, d’un tratto non si potevano fare cose che eravamo abituati a fare, come camminare per strada o andare in bagno. Ero giovane e non capivo nulla di tutte queste cose, ma c’erano cose che non potevo accettare. Se posso evitarle tanto meglio, pensavo. Come mi hanno insegnato i miei, bisogna comportarsi bene, rispettare tutti, anche se non puoi piacere a tutti.
Sappiamo che da giovane cantavi anche in uno stile vicino a James Brown.
Esatto, è così che sono finito con Philllip Walker. Cantavo le canzoni di James e mio nipote ballava, era bravo quasi come James. Non l’ho mai incontrato, ma mi piaceva tutto di lui, suono da una vita e ne ho visti pochissimi con una simile carica. Dopo avermi visto cantare Bea Bopp, la moglie di Phillip, mi chiese di andare in tour con loro come cantante. Era una cosa nuova per me, lei mi rassicurò, «Johnny, non fare caso alla gente, tu vai sul palco e canta come sai fare, come se non ci fosse tutto il pubblico». All’epoca non ero tanto disinvolto, se la gente mi fissava troppo a lungo mi bloccavo. Mi ricordo una volta che mio padre e i mie fratelli vennero a sentirmi in un club, mia madre non veniva nei locali, ma a mio padre piaceva. Sono entrati nel piccolo locale e non sapevano che c’ero io a cantare, si misure a urlare «hey, ma quello è Johnny!», mi sono guardato intorno e tutti mi stavano osservando, così mi sono detto, «signore, ora mi tocca proprio cantare».
Ma come sei finito a suonare la batteria?
Vivevo a Fresno, come dicevo, e volevo trasferirmi a Los Angeles, era lì che succedeva tutto, il centro della scena musicale…volevo andarci e ritagliarmi un posto, come avevano fatto gli altri. Bea Bopp si prese cura di me, mi trattava come un figlio. Lei e Phillip erano persone splendide, mi hanno preso sotto la loro ala, sapevano che poteva non essere facile venendo da Fresno, l’impatto con L.A. Bea ha reso Phillip quello che era, leggeva libri e lo aiutava a scrivere le canzoni, si occupava di tutto. Quando se ne è andata è come se avessi perso un’altra madre. Quando mi sono unito al gruppo, nessuno sapeva che suonavo la batteria, ero lì come cantante. Ma una volta siamo andati in Texas, non ricordo l’anno ma era attorno al mio compleanno, il 17 ottobre. Credo fosse l’anno delle rivolte a Los Angeles (Watts 1965 n.d.t.) e quando siamo arrivati in Texas il batterista ha chiamato sua moglie e lei gli ha detto «o torni subito indietro oppure non farti rivedere». Così lui fu costretto a rientrare, disse a Phillip che non poteva fare altrimenti, lasciò persino la sua batteria nel caso avessimo trovato qualcuno per suonarla. Così eravamo senza batterista. Ero combattuto, non volevo riprendere a suonarla, perché nessuno presta attenzione al batterista e non prendi molti soldi, ma ce ne serviva uno e alla fine andai da Phillip e gli dissi che potevo suonarla io. Lui disse «Johnny sei sicuro di poter davvero suonare tutte quelle canzoni?». «Certo», replicai. «Dategli le bacchette». Così abbiamo provato i pezzi e lui era stupefatto che sapessi suonare la batteria. Con Phillip abbiamo suonato in tutto il mondo, sono rimasto con lui per venticinque o trent’anni. E avevo praticamente smesso di suonare!
Avete suonato anche session di altri musicisti, Lowell Fulson, Ted Hawkins, Screamin’ Jay Hawkins, cosa ricordi di loro?
Di Screamin’ Jay non mi scorderò mai! Ragazzi aveva un morto in una bara quando lo abbiamo visto a Parigi, spaventava tutti quando faceva “I Put A Spell On You”, il cadavere sembrava vero, gli aveva pure dato un nome, Henry!
E Lowell Fulson sul disco One More Blues per la Blue Phoenix?
Ah Lowell, lo chiamavo pappy. Era speciale. Lo ascoltavo da bambino e quando ho suonato con lui ho imparato molto. Tutto quel che dovevi fare era stare zitto e startene tranquillo. Parlava sempre, «Johnny fai così, no, non fare questo…c’è sempre un modo giusto per fare le cose». Lo rispettavo molto, era più vecchio di me e quelli della sua generazione non si facevano problemi a dirti che non sapevi nulla, anche quando pensavi di sapere! Mi parlava del significato dei suoi testi e mi spiegava il modo migliore per suonarli.
Poi negli anni novanta hai inciso il disco Stranded, in coppia con James Thomas su Hightone.
James io lo chiamo Broadway. Lo conosco da tanti anni, per un periodo ha suonato il basso con Phillip. E’ texano d’origine, gli ho trovato io l’ingaggio con noi. Armonizzavamo insieme, già nella band di Phillip ed era una cosa che nel blues non viene fatta tanto spesso, certo c’erano Sam & Dave, ma era diverso. Abbiamo registrato alcune canzoni di Phillip, come Someday You’ll Have These Blues, il gruppo era buono, avevamo Leon Blue al piano e Dennis Walker, bassista che è venuto con noi ovunque da Tokyo a Parigi. Con Broadway ci vediamo ancora, è venuto a sentirmi a Long Beach non molto tempo fa.
Poi è arrivato Seven Day Blues.
Ne avevo abbastanza, ma come raccontavo prima, quando sono arrivato in studio e mi hanno fatto sentire il pezzo strumentale che avevano, ho improvvisato sul momento le parole, ho usato parole che avessero senso e poi hanno eliminato quelle di troppo. Ragazzi, non sapevo che potessero farlo. Abbiamo fatto così per l’intero disco. Prima avevo inciso Why You Lookin At Me, ma era un disco un po’ diverso, più rhythm and blues. In ogni caso il mio metodo è quello di entrare in studio e cantare, non scrivo niente prima.
Qualcuno dei tuoi figli suona?
Ho quattro figlie e tre figli e nessuno di loro suona…ma non sono nei guai! Quando cresci dei figli non puoi dirgli cosa fare se non vogliono farlo. Proprio come mio padre quando non volevo andare in chiesa. Mio padre non parlava molto e comunque quando mia madre parlava ci zittivamo tutti. Eravamo una bella famiglia. Mio fratello Aaron è anche lui un batterista, ha suonato anche lui con Phillip per lungo tempo e poi con Smokey Wilson.
Grazie Johnny, vuoi aggiungere qualcosa?
Ho 73 anni e sto invecchiando, ma credo di essere diventato un ascoltatore migliore. Non mi interessa se qualcuno dice di essere bravo, non mi si può fregare su questo, lo capisco subito e non mi puoi convincere che qualcosa è giusto se non lo è. Bisogna imparare dall’esperienza, come sa bene ogni musicista del mondo.
(Intervista realizzata a Lucerna il 16 novembre 2018)
Matteo Bossi, fonte Il Blues n. 146, 2019