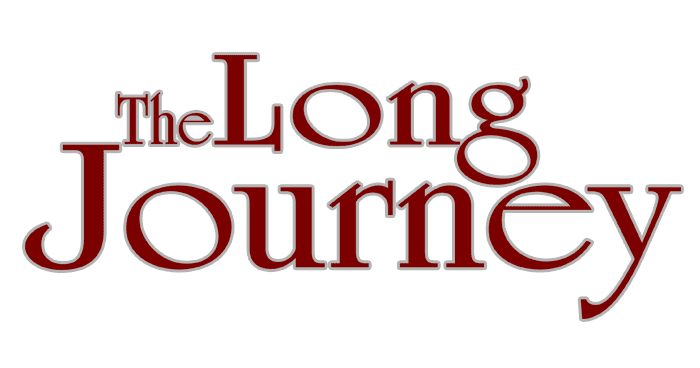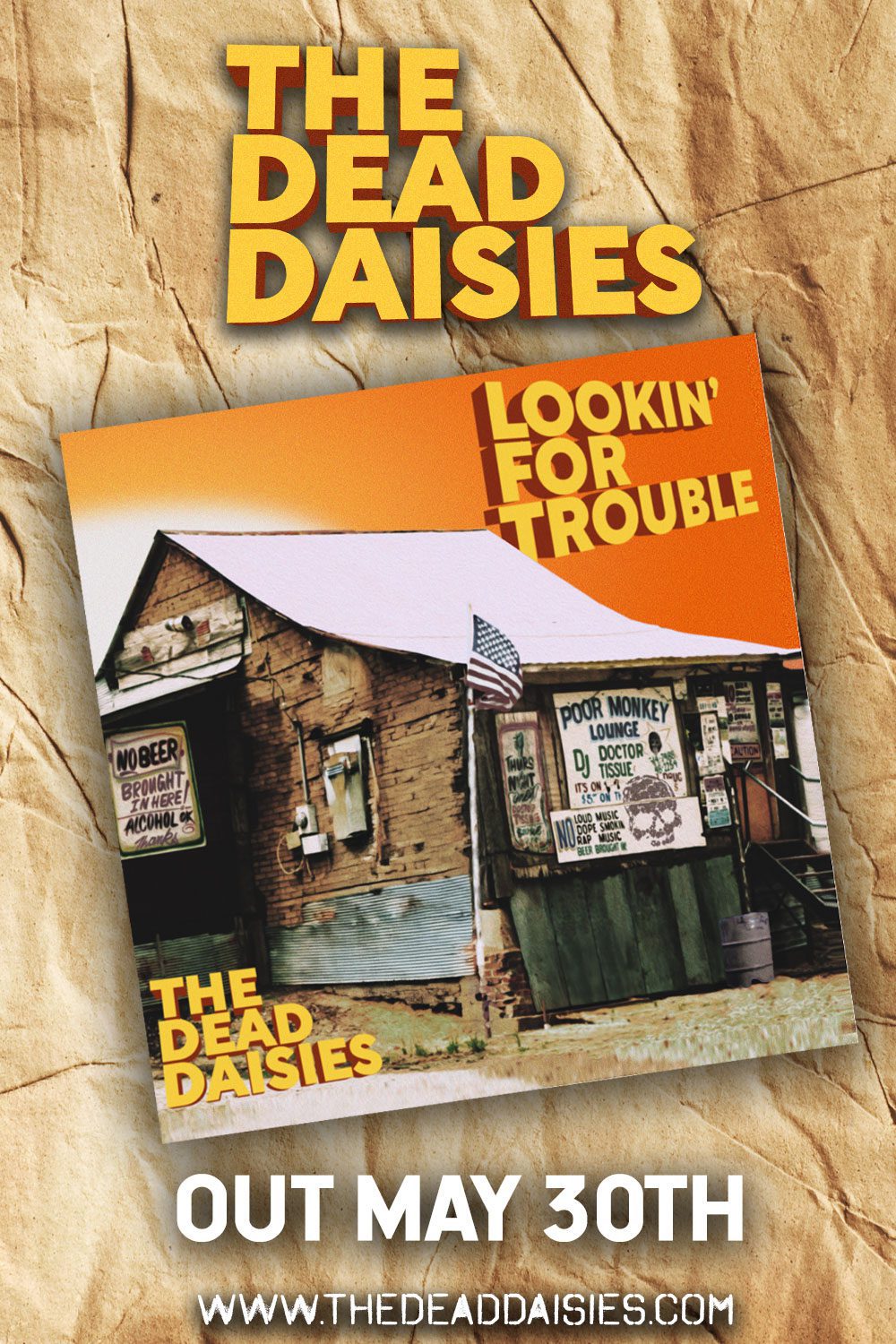Già nel numero 98 de Il Blues pubblicammo un’intervista con Shepherd, allora reduce dall’interessante viaggio musicale documentato su 10 Days Out – Blues From The Backroads. Lo ritroviamo per una breve chiacchierata, alla vigilia del suo passaggio europeo primaverile, che ha toccato anche l’Italia per due date. In quei giorni era in studio con Stephen Stills e Barry Goldberg per lavorare al seguito di Can’t Get Enough uscito nel 2013 a nome The Rides.
Come stanno andando le registrazioni per il secondo album di The Rides?
Siamo a buon punto, abbiamo terminato le incisioni, resta soltanto da finire il missaggio. Questa volta abbiamo collaborato di più anche a livello compositivo; sul primo album avevamo più o meno metà brani originali e il resto cover di classici, da Honey Bee a Rockin’ In The Free World. Non credo che inseriremo più di due cover, anche se ne abbiamo registrate quattro. Per comporre di solito ci troviamo a casa di Stephen Stills e se qualcuno ha un’idea la condivide con gli altri e ci lavoriamo sopra insieme. Anche il bassista Kevin McCormick ha contribuito alla scrittura. Non è così diverso da quanto faccio per i miei dischi, infatti di solito compongo in collaborazione con altre persone. Certo non è come scrivere con Stills e Barry Goldberg.
Come è nato il gruppo?
Stephen ed io ci conoscevamo da circa dieci anni, avevamo suonato insieme in alcune jam organizzate da un amico comune, proprietario di una squadra di football, gli Indianapolis Colts. Stephen voleva mettere insieme una band per un disco di blues ed ha cominciato a scrivere dei pezzi con Barry. Si sono accorti che ci voleva un altro componente e si sono messi a cercarlo. In qualche modo è venuto fuori il mio nome, mi hanno chiamato ed io ho detto subito di sì. Abbiamo registrato il primo disco piuttosto in fretta, nel giro di una settimana, la scelta di quali cover includere l’abbiamo fatta direttamente in studio. Per questo ci siamo presi più tempo, anche perché avevamo più canzoni su cui lavorare. La scelta del nome deriva invece dal fatto che sia io che Stills siamo grandi appassionati di auto.
Il riferimento iniziale era il celebre Super Session, con Mike Bloomfield, Al Kooper, Stills e appunto Goldberg?
Sì, credo che l’idea fosse quella, ma poi è successo che ci siamo messi a scrivere canzoni insieme. Per quel disco so che Bloomfield e Kooper si trovarono per registrare, poi Bloomfield non si presentò per finire il disco e Kooper chiamò Stephen. Non sono sicuro che si siano incrociati con Barry già allora. Nel nostro caso comunque c’è stata sin da subito una vera condivisione, come in una band, non come artisti singoli, che si trovano a collaborare per un pezzo.
Tu e Jerry Harrison, co-produttore del vostro primo, avete lavorato spesso insieme.
Jerry ha prodotto molti dei miei dischi solisti e anche il documentario Ten Days Out On The Road e ci ha dato una grossa mano. Questo secondo disco però lo abbiamo prodotto noi, ce ne siamo occupati soprattutto io e Stephen. Ho lavorato molto anche sul cantato, Stephen mi ha incoraggiato parecchio e sento di aver acquisito maggior fiducia. Ho sempre pensato che la mia voce non fosse molto adatta a cantare blues, infatti nella mia band ho Noah Hunt come cantante, ma in effetti la maggior parte dei pezzi, a parte Search And Destroy, sono di stampo blues.
Come era nato il tuo disco precedente?
Lo avevo registrato con la mia band circa quattro mesi prima che prendesse forma, ho aspettato a pubblicarlo perché era in uscita l’album con The Rides. Guardando indietro ai miei vent’anni di carriera, avevo pensato di realizzare un disco che fosse un omaggio agli artisti che mi hanno ispirato per suonare blues. Cominciai a riascoltare vecchi dischi ed è stato come ritornare a quando ero un ragazzino della Louisiana che iniziava a suonare la chitarra. Per questo mi è sembrato naturale andare a registrare proprio in Louisiana, dove sono cresciuto. Alla fine abbiamo inciso pezzi di Albert King, B.B. King, Muddy Waters…con alcuni ospiti, musicisti di gran talento come Warren Haynes, Ringo o Robert Randolph. E’ stato il mio modo per dire grazie a tutti i grandi musicisti del passato che mi hanno reso ciò che sono.
Già Ten Days Out andava in quel senso, cosa ti è rimasto di quell’esperienza?
Certamente, quello era un progetto speciale, una delle cose migliori cui abbia preso parte. Anzi stiamo parlando di organizzare un seguito. Conoscere e passare del tempo e suonare con persone come Etta Baker o Hubert Sumlin è stato splendido. Mi ha davvero riportato ai tempi in cui scoprivo il blues tradizionale. E’ dura pensare che molti di loro sono scomparsi, come Willie Smith, Hubert Sumlin, Henry Townsend…alcuni, Etta Baker e Cootie Stark per esempio, anche prima che venisse pubblicato il disco/documentario, ma d’altra parte mi piace pensare che il documentario sia servito anche a farli conoscere ad un pubblico diverso. Per questo stiamo pensando di realizzare qualcosa di simile, magari per il decimo anniversario. Prima però pubblicherò probabilmente il DVD di un concerto.
Hai esordito vent’anni fa, con Ledbetter Heights, immaginavi un percorso simile, per la tua carriera?
Non saprei, direi di no. Ricordo che quando uscì il mio primo disco non avevo idea se alla gente sarebbe piaciuto o no, se lo avrebbero comprato. Fu eccitante scoprire che il disco stava andando bene e il secondo andò anche meglio. Avevo solo diciassette anni ed ero già contento di essere pagato per registrare dischi e andare in giro a suonare per tutto il paese e non solo. Oggi le cose sono molto cambiate, non si vendono più tanti dischi come una volta, però la musica dal vivo ha ancora una sua importanza, per fortuna non c’è ancora qualcosa in grado di sostituire questo tipo di esperienza e perciò se sei in grado di metter in piedi un bel concerto, verranno a sentirti. Questo vale a maggior ragione per il blues, una musica che trova davvero la sua dimensione suonata dal vivo, davanti ad un pubblico. E’ musica senza tempo, che non segue la moda, la puoi suonare per tutta la vita al contrario del pop, in più se ben suonato, anche ascoltato tra dieci anni sarà sempre valido.
Cosa ti attratto del blues fin dall’infanzia?
Mio padre è un grande appassionato e metteva di continuo dischi di blues, ma anche di rock e country a casa. La prima cosa che mi colpito, credo sia stato il suono delle chitarre, ma anche il feeling e l’emozione che veniva fuori da quei dischi, quando sei un bambino anche se non capisci le parole, ti impressiona la passione e la forza della musica. Da piccolo mi portarono ad un concerto di John Lee Hooker e Muddy Waters, ovviamente non mi ricordo nulla, ma in qualche modo deve avere avuto qualche effetto su di me.
Matteo Bossi, fonte Il Blues n. 133, 2015