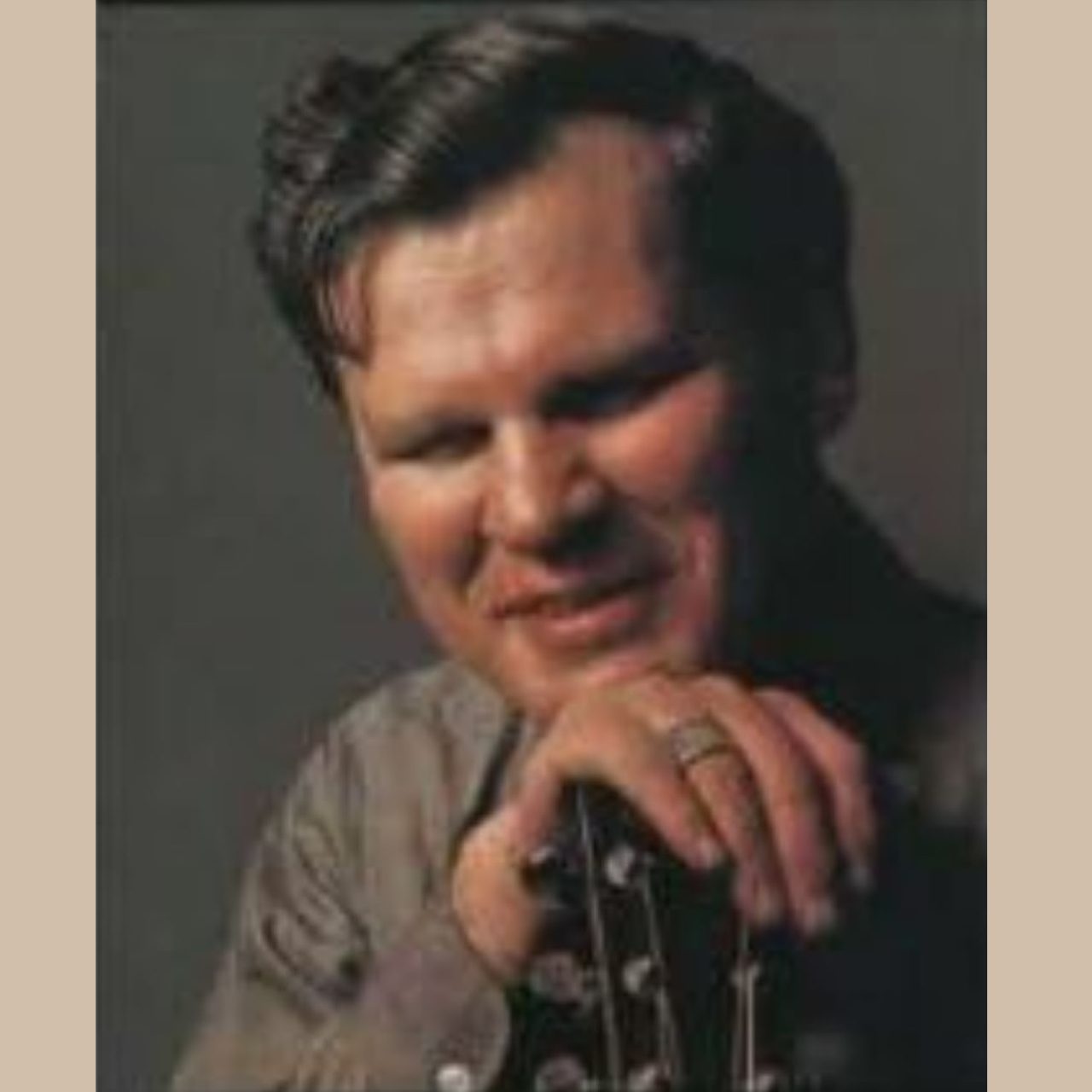E’ ormai ufficiale. Nel 1989 Doc Watson, all’età di 66 anni, lascerà il palcoscenico per ritirarsi con i suoi ricordi più intimi nella casa di Deep Gap, North Carolina.
Sotto la tenda degli artisti del Philadelphia Folk Festival, mentre consuma un dinner a base di yogurt, riesco nella, pare, non facile impresa di scambiare quattro chiacchiere con uno dei più grandi maestri della musica americana. Dopo una mezz’oretta di anticamera mi affaccio nella piccola tenda dove Doc Watson, finito il suo set, si è rintanato per consumare il frugale pasto e ricevere i saluti e gli omaggi di colleghi e amici.
Il concerto è stato bello, forse il più bello che io ricordi. La formula in duo è scarna ma molto più efficace del trio con il pur bravo T. Michael Coleman. Jack Lawrence non vale, ovviamente, Merle nel fingerpicking né tantomeno nell’uso del bottleneck, ma non teme confronti sul territorio del flatpicking dove la sua tecnica fluida e raffinata gli permette di duettare alla pari con il vecchio Doc.
“Ritornando alla vecchia formula il suono della chitarra esce meglio, sì, decisamente mi piace di più. Sono soddisfatto.” mi dice Doc.
“Allora Doc, è vero che questo è uno dei tuoi ultimi concerti?”
“Sì, sono stanco di fare tour. Ma non sono stanco di fare musica. La musica è tutta la mia vita, non potrò mai separarmene”.
E’ strano. Quest’uomo mi sembra molto meno vecchio di due anni fa quando lo vidi per l’ultima volta. Forse, allora, non aveva ancora pienamente superato la crisi seguita alla prematura morte del figlio Merle ma ricordo che anche dal punto di vista fisico il vecchio Doc mi sembrò molto giù.
Ora lo ritrovo più in salute, più presente. Il viso ingrassato e i lucenti capelli bianchi gli danno tanto l’aria di un nonno un po’ burbero ma, in fondo in fondo, buono. Sul palcoscenico, grazie anche ad un repertorio più vario ed interessante, l’ho trovato partecipativo ed emozionato: cosa che non avevo mai riscontrato nei suoi precedenti concerti, quasi tutti all’insegna di una routine troppo evidente e a volte fino seccante.
“Voglio dedicarmi nuovamente alla musica che mi è più congeniale: la musica old timey, quella delle mie radici. Gli album di bluegrass che ho fatto sono stati esperimenti interessanti ma non ho intenzione di continuare su quella strada. Mi considero un musicista legato profondamente alla musica tradizionale. Voglio tornare alla musica più genuina”.
Quando esprime concetti in cui crede, Doc Watson spalanca le fessure degli occhi quasi a cercare di superare il suo handicap per cogliere le reazioni del suo interlocutore. “Non ho niente contro chi cerca nuove strade all’interno della musica tradizionale o bluegrass, ma non è roba che fa per me. Sì, mi piacciono i New Grass Revival, ma quando Sam Bush suona il violino con me, suona la ‘mia’ musica”.
Doc ha influenzato centinaia, forse migliaia di chitarristi nel mondo. Ma la sua tecnica, il suo tocco, il suo stile restano tuttora inimitabili. “Ci sono tanti chitarristi che mi piacciono, Norman Blake, Dan Crary, Tony Rice e ovviamente Jack Lawrence. Non posso dirti chi considero il mio erede: ognuno di loro ha abilità e caratteristiche che lo rendono a sua volta un capostipite”.
Più che a guardare avanti, Doc, dal punto di vista musicale, sembra sempre cercare riferimenti nel passato, nella tradizione del Sud degli Stati Uniti. “Chitarristi come Riley Puckett restano tuttora attualissimi. E io, ancora oggi, ascolto la loro musica e la trovo fresca e trascinante”.
Ma che cosa ne pensa dei nuovi fenomeni di Nashville, del nuovo revival della Country Music?
“Alcuni di loro mi piacciono. Ad esempio Randy Travis, trovo che sia molto interessante. E così pure Dwight Yoakam. Tra i gruppi di bluegrass, apprezzo in modo particolare la Nashville Bluegrass Band”.
Ma Doc non ama fare nomi. Preferisce suonare con i musicisti-amici di cui ama circondarsi. Il fascino ed il carisma di questo grande personaggio sono rimasti immutati negli anni. E così pure l’enorme rispetto di cui Doc è circondato. Il nostro veloce colloquio è stato interrotto più volte dai saluti di musicisti, operatori e giornalisti presenti al Festival: tutti ad inchinarsi di fronte ad una delle leggende viventi della musica del nostro tempo.
“Il pubblico, gli amici e i colleghi mi hanno aiutato a superare tanti momenti difficili della mia vita. Ma credo che il debito più grosso io lo continui ad avere nei confronti della musica che è stata ed è tuttora la mia ragione di vita. Ecco perché anche se smetterò di fare tour non abbandonerò mai la mia musica”.
La speranza di avere Doc Watson nuovamente su disco non è quindi perduta. Progetti definiti ancora non ce ne sono. “Non ho ancora pensato a come organizzarmi la vita, una volta smesso di girare. Per un po’ vorrei starmene tranquillo a Deep Gap, riascoltare vecchi nastri, suonare con amici. Ma non escludo altri progetti discografici o partecipazioni saltuarie a concerti o Festival”.
E così dicendo appoggia il vasetto di yogurt ormai vuoto e riprende in mano la sua Gallagher: ‘Philadelphia’ Jerry Ricks sta entrando sotto la tenda. C’è solo il tempo per dei rapidi saluti. Ed è subito blues.
Ezio Guaitamacchi, fonte Hi, Folks! n. 32, 1988